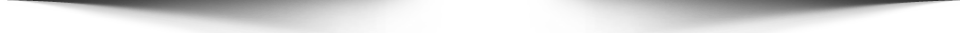

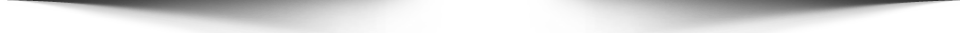
- VANGELO secondo MARCO ♫ AUDIO ▾
- INTRODUZIONE
- CAPITOLO - 01-1
- CAPITOLO - 01-2
- CAPITOLO - 01-3
- CAPITOLO - 02-1
- CAPITOLO - 02-2
- CAPITOLO - 03-1
- CAPITOLO - 03-2
- CAPITOLO - 04-1
- CAPITOLO - 04-2
- CAPITOLO - 05
- CAPITOLO - 06
- CAPITOLO - 07
- CAPITOLO - 08
- CAPITOLO - 09
- CAPITOLO - 10
- CAPITOLO - 11
- CAPITOLO - 12
- CAPITOLO - 13
- CAPITOLO - 14-1
- CAPITOLO - 14-2
- CAPITOLO - 15
- CAPITOLO - 16
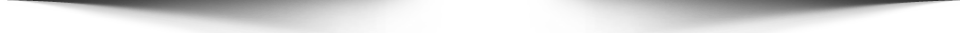

VANGELO secondoMARCO • Commenti di Padre LINO PEDRON«A nessuno sfugge che tra tutte le Scritture, anche del Nuovo Testamento, i vangeli meritatamente eccellono, in quanto sono la principale testimonianza relativa alla vita e alla dottrina del Verbo incarnato, nostro salvatore» (DV 18).INTRODUZIONE
Abbiamo tra le mani il Vangelo di Gesù Cristo secondo Marco. Vogliamo leggerlo con amore, con fede, con calma: leggerlo, rileggerlo, meditarlo e pregarlo. Vogliamo lasciarci invadere dalla Presenza che lo riempie, evitando di soffocare la Parola con le parole. Desideriamo tradurlo senza tradirlo: tradurlo in linguaggio semplice, serio, corretto e rispettoso. Ci proponiamo tre mete, sicuramente non facili da raggiungere: chiarezza, essenzialità e attualizzazione.La Parola di Dio è una Persona, è Gesù Cristo.Leggere il Vangelo significa dunque mettersi in relazione con Qualcuno vivo, presente, e sentirsi invadere da questa presenza che trasforma la vita, perché il Vangelo è una Persona viva prima di essere un libro.La domanda centrale che ci poniamo, il mistero centrale che desideriamo capire è: Chi è Gesù? Ma accanto a questa prima domanda ne sorge subito un’altra: Chi è il discepolo? La rivelazione progressiva di Gesù e del discepolo non avviene solo attraverso discorsi sempre più espliciti, ma soprattutto attraverso una storia che si chiarisce vivendola: il Vangelo è racconto, dramma, storia, non un catechismo. E chi vuole capire deve condividere questa storia, deve farsi discepolo.L’iniziazione cristiana è un viaggio dall’esterno all’interno, dalla periferia al centro, da una conoscenza per sentito dire ad un’esperienza personale. Il mistero cristiano si coglie solo dall’interno: non c’è posto per l’osservatore neutrale.Marco non si limita solo a rivelare il mistero cristiano: conduce il lettore a scoprire le proprie paure, la propria ignoranza, le proprie resistenze. Il suo Vangelo si muove contemporaneamente su due linee: la rivelazione del mistero di Gesù e la manifestazione del cuore dell’uomo.È il continuo scontro tra questi due aspetti che rende il Vangelo secondo Marco attuale, drammatico e inquietante. L’uomo vede i gesti di Gesù, sente le sue parole, ma non comprende, resta incredulo perché ha il cuore indurito (6,52) e gravemente malato (7,20–23).Il vangelo secondo Marco è quello che ci presenta meglio l’umanità di Gesù: ci fa sentire il peso del suo sguardo, la sua pietà per la folla, i momenti di delusione nei riguardi degli apostoli, la tristezza per l’incomprensione dei farisei, dei familiari, dei discepoli. Ne esce un’immagine umanissima. Gesù appare, di volta in volta, tenero, incisivo, fraterno, vicino e improvvisamente misterioso, uno che ci pone delle domande e uno di cui ci si pone la domanda: Chi è costui?È il paradosso di Gesù, incompreso e respinto dagli uomini, ma inviato ed esaltato da Dio, che interessa soprattutto il vangelo di Marco. Il suo tema essenziale è la manifestazione del Messia crocifisso.CHI È MARCO?
Per sant’Ireneo, vescovo di Lione (130–202), si tratta di Giovanni soprannominato Marco di cui parlano gli Atti degli apostoli; sua madre Maria ospitava la comunità cristiana di Gerusalemme. Pietro, uscendo di prigione, si recò appunto «alla casa di Maria, madre di Giovanni detto anche Marco, dove si trovava un buon numero di persone raccolte in preghiera» (At 12,12). Il doppio nome attesta sia la sua origine ebraica (Giovanni, in ebraico Iohanan, significa «Iahvè fa grazia») sia una certa familiarità col mondo romano (Marco, in latino Marcus, significa «il martello»).Il libro degli Atti ci parla, un po’ più avanti, di un Giovanni Marco collaboratore del cugino Barnaba, compagno di Paolo, ad Antiochia (At 12,25). Più tardi lo si vede lasciare questi due apostoli, coi quali era partito in missione per Cipro, e tornare da solo a Gerusalemme (At 13,13). In occasione di un altro viaggio, Paolo rifiuta di riprenderlo con sé, e, dopo una vivace discussione con Barnaba, si separa da loro e prende con sé Sila (o Silvano) per passare in Asia minore e poi in Macedonia, lasciando i due cugini che si imbarcarono insieme per Cipro (At 15,36). Poi però questo Marco, cugino di Barnaba, lo si ritrova ancora vicino a Paolo prigioniero a Roma (Col 4,10; Fm 24); se ne deduce che i due si fossero riconciliati. La seconda lettera a Timoteo contiene un elemento che potrebbe essere aggiunto a questo dossier: «Prendi Marco e portalo con te perché mi sarà utile per il ministero» (2Tim 4,11).Queste brevi allusioni dicono qualcosa sulla vita dell’evangelista, almeno se si tratta della stessa persona. Tuttavia la tradizione ha preso maggiormente in considerazione le sue relazioni con Pietro, delle quali troviamo un solo accenno nel Nuovo Testamento. Al termine della sua prima lettera, Pietro, evocando l’ambiente dissoluto della capitale dell’impero, scrive: «La comunità degli eletti che dimora a Babilonia (Roma) vi saluta, e anche Marco, mio figlio» (1 Pt 5,13). Da questo tenero appellativo alcuni deducono che Pietro avesse battezzato Marco.Fra i più antichi testi che parlano dei vangeli, un prologo latino detto antimarcionita – così chiamato perché si opponeva a Marcione (verso il 140 d.C.), conferma questa tradizione: «Ecco le asserzioni di Marco soprannominato l’uomo dalle dita spezzate (cologbodactylus), perché in contrasto con la prestanza della sua statura aveva le dita troppo corte; fu il traduttore di Pietro. Dopo la morte di Pietro mise per iscritto questo Vangelo in Italia».Il più antico documento che parla dell’origine dei vangeli è forse quello di Papia, vescovo di Gerapoli in Asia minore, verso il 120 o il 130, ripreso dallo storico cristiano Eusebio di Cesarea (263–339): «Il presbitero era solito dire che Marco, essendo stato l’interprete di Pietro, scrisse con cura, benché senza ordine, tutto ciò che ricordava dei detti e dei fatti del Signore. Non aveva sentito e seguito personalmente il Signore, ma Pietro, e ciò solo molto più tardi, come ho detto. Pietro insegnava secondo le circostanze senza dare un ordine ai detti del Signore. Perciò Marco non commise errori scrivendo in base ai suoi ricordi. Non aveva che una sola preoccupazione: di non omettere nulla di ciò che aveva sentito e di non riferire niente di falso».Questa informazione, in cui Papia loda l’esattezza dell’evangelista più che l’ordine logico del suo racconto, conferma i dati della tradizione: Marco scompare dietro alla testimonianza di Pietro di cui è stato il discepolo fedele e attento.
DOVE E QUANDO MARCO COMPOSE LA SUA OPERA?
La lingua usata dall’evangelista, piena di parole latine semplicemente trascritte in greco, e l’abitudine di spiegare ai suoi lettori usi propri degli ebrei di Palestina, lasciano supporre che si rivolga ai cristiani provenienti dal paganesimo e ambientati nella cultura latina. Per questo si pensa spontaneamente alla città di Roma, dove la tradizione ha stabilito la morte di Pietro e Paolo. Si data normalmente il martirio di Pietro tra gli anni 64–67, durante la persecuzione dei cristiani da parte di Nerone, scoppiata in seguito all’incendio della città nel 64. Il Vangelo secondo Marco è stato scritto tra il 65 e il 70 perché non sembra che l’evangelista faccia allusione, come Matteo e Luca, alla distruzione di Gerusalemme da parte degli eserciti romani di Tito, avvenuta nell’agosto–settembre del 70.Questo Vangelo sembra non aver avuto molto successo attraverso la storia della Chiesa: la liturgia non lo utilizzava e i commentari antichi sono rari. Forse si deve attribuire ciò al fatto che quasi tutti gli episodi narrati da Marco si trovano già in Matteo e Luca, e che Marco non riferisce quasi nessun discorso di Gesù. Sant’Agostino ha scritto molto sbrigativamente: «Marco ha seguito Matteo abbreviandolo, senza originalità».Bisognò aspettare la metà del 1800 perché la narrazione di Marco venisse apprezzata. All’inizio, questa valorizzazione non avvenne per meriti teologici o pastorali, ma storici. Gli studiosi storici di formazione positivista cercavano racconti semplici e teologicamente «neutrali», nei quali la realtà storica non fosse coperta dal manto prezioso della fede. Così il «povero» Vangelo di Marco diventava, proprio per la sua povertà, il più affidabile; la ricostruzione storica della vita di Gesù doveva farsi – dicevano – sulla falsariga della presentazione di questo Vangelo.Si è parlato di candore e di semplicità a proposito di Marco; si sono lodati i suoi talenti di narratore, pur sorridendo per la rozzezza del suo stile senza ricercatezza e della sua lingua aspra. Se vogliamo essere sinceri, si è esagerato a proposito del pittoresco e della vivacità di questo scrittore. Lo stile scarno dei suoi racconti ci disorienta, l’implacabile logica del suo pensiero scoraggia la nostra ricerca; non fa appello ai sentimenti e misura i dettagli col contagocce senza arricchimenti o spiegazioni. Il ritratto che egli offre di Gesù è insieme austero e misterioso. Raramente egli lascia indovinare la tenerezza e le emozioni profonde; sottolinea invece la radicalità delle esigenze. Il Gesù secondo Marco che a un primo contatto sembra molto umano, molto vicino alla gente che lo circonda, diventa poco alla volta inaccessibile, sfugge ai nostri tentativi di approccio e ci lascia nel cuore una segreta lacerazione.
MARCO E GESÙ
Secondo la tradizione, come abbiamo visto, Marco non è stato discepolo di Gesù, ma «compagno di Paolo» e «interprete di Pietro». Abbiamo in mano il testo del Vangelo. Il problema è di sapere se rende con fedeltà il ritratto di Gesù, di quest’uomo vissuto duemila anni fa, che ha ancora tanti credenti nel mondo e che suscita grande interesse presso dotti e ignoranti.Come incontrare il Gesù vivo attraverso questo testo vecchio di venti secoli?Coi suoi 661 versetti, ripartiti in sedici brevi capitoli, è il più corto dei quattro Vangeli; contiene solo 53 versetti che non si ritrovano nei passi paralleli degli altri due sinottici Matteo e Luca. Per questo Bossuet, dopo sant’Agostino, chiama Marco «il più divino degli abbreviatori». Oggi molti studiosi utilizzano il calcolatore per analizzare la struttura dei Vangeli sinottici, costruendo un modello matematico capace di rendere conto delle varianti poste in evidenza dal confronto sinottico.Ci chiediamo: questa utilizzazione scientifica ci aiuta veramente a comprendere Gesù e a seguirlo in un modo più concreto? Rispondiamo senza esitazioni che non è necessario affrontare questi studi specialistici per leggere il Vangelo e farlo passare nella nostra vita.Tuttavia, dobbiamo ricordare che siamo nel ventesimo secolo e abbiamo bisogno della scienza del nostro tempo, non fosse altro che per rispondere a coloro che, a torto o a ragione, ci pongono delle domande «scientifiche» sulla nostra fede e sottopongono tutto e tutti ad un’analisi rigorosa e talvolta distruttiva.La salvezza non viene dagli esegeti né dai calcolatori, ma da Dio in Gesù Cristo. Ma Gesù Cristo «si è consegnato all’esegeta, allo storico, come si consegnò un giorno ai giudici e alla folla... Se si fosse sottratto alla critica e alla controversia, all’esegeta, al critico e allo storico, ... se la sua memoria non fosse entrata nelle condizioni organiche della memoria dell’uomo, non sarebbe stato un uomo come tutti gli altri e l’incarnazione non sarebbe stata completa e leale» (C. Peguy).Leggere un Vangelo significa, anzitutto, ascoltare una testimonianza: quella degli evangelisti e delle loro comunità di cui condividiamo la fede in Cristo. Ricordiamo che una distanza di qualche decennio separa le testimonianze scritte di Marco, Matteo, e Luca dalla morte e dalla risurrezione di Cristo. «Questa distanza fra i Vangeli e Gesù non dev’essere dimenticata né deplorata. Dimenticarla, porterebbe certamente ad una lettura superficiale. Deplorarla, sarebbe sbagliarsi sulla natura di questi libri. Saranno delusi gli amatori di reportages dal vivo o coloro che preferiscono la visione istantanea alla profondità dello sguardo interiore della memoria. L’originalità della testimonianza evangelica dipende dalla memoria che essa realizza in rapporto all’avvenimento. Vibra della vita dei testimoni e delle prime Chiese per le quali Gesù significava un nuovo modo di essere al mondo.I Vangeli sono nati al termine di una lunga gestazione. Ne portano i segni indelebili. Non vederli significherebbe non capirli. I Vangeli ci fanno sentire più voci. Un testimone, parlando di altre persone, parla anche di se stesso. I vangeli attestano l’interesse della «tradizione–su–Gesù» per i primi testimoni, per i primi credenti e per coloro che ne trasmettono l’eredità. E questo fa parte del senso della vita e dell’opera di Gesù. Bisogna imparare a leggerli secondo tutte le loro dimensioni» (J. Delorme). Marco pone al centro del suo Vangelo la persona di Gesù: essa ne domina anche i particolari più insignificanti. Il problema è di lasciarsi afferrare dalla sua morte e dalla sua risurrezione come i primi compagni perché in questo consiste «essere discepoli».Marco ci introduce a un incontro: quello col Cristo del passato che è anche il Cristo vivo di oggi; ci fa così comunicare col mistero cristiano in ciò che ha di più profondo, per nutrire la nostra fede.
COME LEGGERE IL VANGELO DI MARCO?
Marco è convinto che i diversi aspetti della storia di Gesù – miracoli, parole, morte, risurrezione – non vanno semplicemente accostati (quasi bastasse la completezza a farci cogliere il significato che racchiudono), bensì vanno letti e valutati a partire da un centro: la morte e risurrezione. Ecco perché il motivo della passione è introdotto in sordina fin dall’inizio. E’ un invito a leggere il racconto a partire dalla sua conclusione.Marco ci insegna che i titoli di Gesù–Messia, Figlio dell’uomo, Figlio di Dio,vanno riempiti di contenuto rapportandoli alla morte–risurrezione: per convincersene basta leggere 8,27–38 (per i titoli Messia e Figlio dell’uomo) e 15,38–39 (per il titolo Figlio di Dio). Se non si facesse così, pensa Marco, si correrebbe il rischio di riprodurre all’interno della stessa comunità cristiana l’equivoco giudaico, cioè una teologia che rifiuta la presenza di Dio in Gesù crocifisso.
CAPITOLO 01
1 Inizio del vangelo di Gesù Cristo, Figlio di Dio. 2 Come è scritto nel profeta Isaia:Ecco, io mando il mio messaggero davanti a te,egli ti preparerà la strada.3 Voce di uno che grida nel deserto:preparate la strada del Signore,raddrizzate i suoi sentieri,4 si presentò Giovanni a battezzare nel deserto, predicando un battesimo di conversione per il perdono dei peccati.5 Accorreva a lui tutta la regione della Giudea e tutti gli abitanti di Gerusalemme. E si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. 6 Giovanni era vestito di peli di cammello, con una cintura di pelle attorno ai fianchi, si cibava di locuste e miele selvatico 7 e predicava: «Dopo di me viene uno che è più forte di me e al quale io non sono degno di chinarmi per sciogliere i legacci dei suoi sandali. 8 Io vi ho battezzati con acqua, ma egli vi battezzerà con lo Spirito Santo».Il vangelo di Marco non ci presenta una dottrina o una ideologia, ma una persona concreta, Gesù Cristo, Figlio di Dio, che va accolto come nuovo criterio di vita.Lo stesso Vangelo, come contenuto, è proprio questo Gesù, e le prime parole di Gesù non sono altro che una manifestazione, una presentazione di se stesso. Gesù esordisce «predicando il Vangelo di Dio» (1,14), cioè se stesso (1,1), e dice: «Il tempo dell’attesa è finito. Io sono qui. Rivolgetevi a me e credetemi» (1,15). Il Dio che ci rivela il Vangelo di Marco è colui che nessuno avrebbe potuto sospettare: l’uomo Gesù, il crocifisso dalla religione e dal potere. Sotto la croce si svela il segreto: «Veramente quest’uomo era Figlio di Dio» (15,39). Tutto il Vangelo è un cammino crescente verso la rivelazione finale del Figlio di Dio in Gesù, il crocifisso. Marco vuole portarci alla contemplazione di Dio–Amore crocifisso. Questo è il Vangelo, la buona notizia, che distrugge ogni immagine di Dio che l’uomo da sempre si costruisce o distrugge.Quanto Marco pone come inizio del suo Vangelo, Giovanni lo pone come conclusione: «Questi (segni) sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché, credendo, abbiate la vita nel suo nome» (Gv 20,31). Come si può constatare, lo scopo dei vangeli è sempre e solo questo: dare al mondo la gioiosa notizia che Gesù di Nazaret è Dio che ci salva.Similmente a Paolo, di cui è discepolo, Marco identifica il vangelo con Cristo: nella proclamazione del Vangelo (13,9–11) Cristo si fa presente.Il Vangelo non è primariamente una narrazione su Gesù, ma una proclamazione del Cristo risorto che il Vangelo rende nuovamente presente.I greci chiamavano vangelo (euanghélion) la proclamazione di una vittoria e il sacrificio che la celebrava, oppure l’intronizzazione di un nuovo re. Il senso religioso di questo termine lo dobbiamo cercare nell’Antico Testamento. Isaia al cap. 52,7, per fare un esempio, ci presenta così il lieto annunzio: «Come sono belli sui monti i piedi del messaggero di lieti annunzi che annunzia la pace, messaggero di bene, che annunzia la salvezza, che dice a Sion: «Regna il tuo Dio!». I contenuti di questa bella notizia sono: pace, bene, salvezza, regno di Dio. Si potrebbe quindi tradurre così questo primo versetto: «Inizio della buona notizia di salvezza che è Gesù, il Cristo, il Figlio di Dio». Tutto il Vangelo di Marco sarà lo svolgimento del tema di questo primo versetto: fino a 8,29 per arrivare alla proclamazione di Pietro: «Tu sei il Cristo»; e fino a 15,39 per giungere all’affermazione del centurione: «Veramente quest’uomo era Figlio di Dio!». Due professioni di fede che riprendono e svelano i due titoli che il primo versetto del Vangelo attribuisce a Gesù.Questa parola «principio» echeggia all’inizio della Bibbia quando Dio creò l’universo (Gen 1,1): Dio è la sorgente della vita del mondo e dell’uomo. Il Gesù presentato dal Vangelo di Marco è il «principio» di un mondo nuovo, dei cieli nuovi e della terra nuova, dove abita l’uomo nuovo.Il Vangelo è la buona notizia che Dio non è il padre–padrone, giudice onniveggente e spietato. Egli è il Padre che perdona e accoglie sempre, con un amore infinitamente più grande del nostro bisogno e di quanto possiamo immaginare. La nostra miseria è l’unica misura della sua misericordia. Solo la croce rivelerà chi è Dio per noi e chi siamo noi per lui: lui è amore senza limiti e noi siamo suoi figli amati non nonostante il nostro peccato, ma a motivo del nostro peccato. La misericordia è l’amore di Dio che incontra la miseria dell’uomo. Il Vangelo, attraverso il racconto della vita di Gesù, ci dona questa nuova esperienza di Dio. Infatti il Vangelo è «potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede» (Rm 1,16). Il Vangelo, la buona notizia, è Gesù stesso. La sua carne, la sua vita di uomo ci rivela chi è Dio. Un Dio totalmente altro rispetto a quello di ogni religione e di ogni ateismo. Ciò che lui fa e dice è una continua smentita di ogni nostra ovvietà e la sua croce è la distanza infinita che Dio ha posto tra se stesso e l’idolo.La storia di Gesù è la critica più radicale di ogni religione e di ogni ateismo: spiazza tutti, giusti ed empi, presentando l’umanità di Dio ucciso dai giusti e morto in croce per gli empi, e quindi salvezza per tutti. Tutto il Vangelo è Parola che illumina il mistero di Dio crocifisso per l’uomo.Gesù, il Cristo, il Figlio di Dio: in questi nomi è significata tutta la persona, la storia e la missione del Salvatore.Gesù significa: Dio salva.Cristo o Messia è colui che ha ricevuto l’unzione dell’olio, il consacrato; è colui che Israele attende come strumento di Dio per la salvezza del popolo.Gesù è il Cristo, ma non nella linea politica e nazionalistica, ma nella linea della croce e della risurrezione: «Ma egli (Gesù) replicò: «E voi chi dite che io sia?». Pietro gli rispose: «Tu sei il Cristo». E impose loro severamente di non parlare di lui a nessuno. E incominciò a insegnare loro che il Figlio dell’uomo doveva molto soffrire, ed essere riprovato dagli anziani, dai sommi sacerdoti e dagli scribi, poi venire ucciso e, dopo tre giorni, risuscitare» (8,29–31).Figlio di Dio: questo titolo ha chiaramente il senso teologico che gli attribuiva la comunità cristiana post–pasquale del tempo di Marco. E’ un titolo che Marco usa con sobrietà. Viene usato soprattutto in tre testi importanti: al Battesimo (1,11), alla Trasfigurazione (9,7) e nella professione di fede del centurione ai piedi della croce (15,39). Ma quale significato preciso dobbiamo attribuire al titolo «Figlio di Dio»? E’ proprio per rispondere a questa domanda che Marco racconta la vicenda di Gesù. Perché c’è modo e modo di pensare il Figlio di Dio. Sembrerebbe logico, per esempio, pensarlo unicamente nella linea della gloria e della potenza. Marco invece racconta una vicenda che ci costringe a pensarlo nella linea della povertà e della sofferenza: e questa è la tesi centrale del suo Vangelo.Se il Figlio di Dio si fosse manifestato nella forma splendida di un imperatore, non sarebbe stata una bella notizia: non sarebbe stata novità, liberazione, speranza. Ma, anche se la storia di Gesù di Nazaret si fosse fermata alla croce, non sarebbe stata una lieta notizia: sarebbe stata una prova ulteriore che l’amore è sconfitto, che la speranza degli umili e dei martiri è vana. La gioiosa notizia sta nel fatto che Gesù di Nazaret, il crocifisso, è risorto (16,6), è il Figlio di Dio, è il Signore. È importante mantenere uniti i due aspetti di Gesù: uomo e Dio, crocifisso e risorto, Gesù di Nazaret e Signore. Sta in questa unione la lieta notizia.Compito della Chiesa non è semplicemente quello di parlare di Dio, ma del Dio che si è rivelato in Gesù di Nazaret, il crocifisso. E’ proprio di fronte a Gesù morente che il primo pagano si converte. Il centurione riconosce in Gesù il Figlio di Dio non vedendo i suoi prodigi, ma vedendolo morire; quindi non nella potenza, ma nella debolezza; non nella gloria, ma nell’umiliazione della sconfitta. Nella concezione dell’evangelista, il lieto annunzio appare simultaneamente come intervento decisivo di Dio nella storia umana (1,15; 8,35; 10,29), come proclamazione di tale intervento per il mondo (13,10; 14,9) e come presenza dello stesso Signore risorto, vivente e operante, oggi, nella vita di ogni uomo (16,15).L’agire di Gesù continua ancora oggi nella Chiesa (16,15–20). Per questo il Vangelo di Marco narra solamente ciò che fu l’inizio, il principio, il punto di partenza. Se oggi possiamo predicare il Vangelo è perché intorno agli anni trenta in Palestina è passato Gesù di Nazaret, predicando, guarendo, perdonando, soffrendo, morendo; è perché di Gesù di Nazaret si può dire con verità: «E’ risorto!» (16,6). Gesù è la causa efficiente, l’origine, la fonte. Il Vangelo, oggi, è Gesù che continua ad agire nei suoi inviati, nella sua Chiesa che è il Cristo diffuso e comunicato, il prolungamento della sua umanità.Annunciare il Vangelo non vuol dire riferire una notizia come fa l’annunciatore del telegiornale, non vuol dire aggiornare una persona sugli ultimi avvenimenti lieti. Il Vangelo non è solo la notizia della salvezza, il bollettino della vittoria; è una forza che produce la salvezza: «Il Vangelo è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede» (Rm 1,16). Annunciare il Vangelo ad una persona vuol dire metterla sotto la forza dell’azione di Gesù, Dio che salva.La storia di Gesù di Nazaret è il momento a cui la predicazione deve sempre ricondursi, che la Chiesa deve continuamente meditare, e sul quale l’esistenza cristiana deve perennemente modellarsi.Il Vangelo non è apparso come qualcosa di grandioso e di perfettamente costituito: ebbe un inizio umile e uno sviluppo graduale. Ha percorso la strada del piccolo seme che diventa albero (4,30–32). La lieta notizia di Gesù non emerge dalla storia e non si spiega solo con essa: è l’irruzione nel mondo della novità di Dio. E’ una notizia attesa e desiderata (Antico Testamento), ma anche inaspettata e sorprendente. Tutti aspettavano il Messia, ma nessuno avrebbe potuto sospettare che il Messia fosse Dio in persona.Alcuni vorrebbero vedere nel Vangelo di Marco un itinerario di fede per i catecumeni (coloro che ricevono l’insegnamento orale, che ascoltano dalla viva voce). Un fatto è certo: Marco prende per mano il lettore e l’accompagna fino alla professione di fede piena in Gesù «Cristo, Figlio di Dio».Il Vangelo non colloca il Cristo–Figlio di Dio nei cieli, al di fuori della nostra storia. Il Cristo è «Gesù». E’ un uomo tra gli uomini. Cristo si trova ormai nella storia, nelle situazioni concrete, negli uomini. E’ necessario saper leggere e discernere la presenza dell’azione di Dio all’interno della nostra storia personale e sociale. Dio è qui! Dio è con noi e in noi. In questo modo si afferma l’unità tra Dio e l’uomo, contro ogni separazione, la quale fa sì che Dio sia senza l’uomo (e ciò è la radice di ogni alienazione religiosa) e che l’uomo sia senza Dio (e ciò è la radice di ogni concezione idolatrica dell’uomo). Il Vangelo toglie la divisione tra l’uomo e gli altri uomini annunciando l’unità tra Gesù e tutti gli uomini. Toglie la separazione tra gli elementi negativi (la morte) e gli aspetti positivi (la risurrezione) della vita, annunciando l’unità tra di essi: la morte e la risurrezione di Gesù sono due aspetti inseparabili come le facce di una stessa medaglia. Dal Vangelo secondo Marco impariamo a non annunciare mai l’una senza l’altra.Nel Vangelo vengono così superate e risolte tutte le scissioni e le contraddizioni che caratterizzano l’uomo e il suo mondo.La citazione della Scrittura (vv. 2–3) viene qui attribuita al profeta Isaia. In realtà questa citazione ne riunisce due di cui solo l’ultima proviene dal libro di Isaia (40,3) mentre l’altra si riferisce a Ml 3, 1. Giovanni è la voce che grida nel deserto: «Preparate la strada del Signore che è Gesù». Qui si dà chiaramente a Gesù il nome Kyrios, il nome di Iahvè, di Dio.La predicazione e il battesimo di Giovanni sono rivolti a tutti indistintamente; e la gente risponde all’appello e accorre.Giovanni Battista si inserisce nella grande tradizione profetica di cui Elia è insieme il punto di partenza (Zc 13,4) e la conclusione (Ml 3,23). Il suo abbigliamento ricorda quello del Tisbita: un perizoma di pelle o di peli di cammello (2Re 1,8), e la sua alimentazione è quella dei nomadi del deserto (Gen 43,11). Questi dettagli sul genere di vita del Battista lo presentano come il tipo dei profeti dell’Antico Testamento; il suo messaggio riassume tutta l’attesa messianica. Tutto il profetismo d’Israele, presentato sommariamente come la voce che invita a preparare la strada del Signore, e concentrato nella persona di Giovanni, viene subito messo da parte, superato dall’annuncio di Gesù che esso preparava: all’arrivo della Parola (Gesù) cessa la voce (il profeta).La predicazione di Giovanni si articola in due momenti: il primo è l’invito a riconoscere i propri peccati e a convertirsi (1,4–6); il secondo è la testimonianza resa ad un altro (1,7–8). La strada del Signore si prepara svuotando l’uomo dalle sue sicurezze e dalla sua superbia, spingendolo a riconoscersi peccatore e bisognoso di grazia e di perdono; poi orientandolo verso la salvezza che Dio gli dona purché l’attenda con desiderio e l’accolga con gioia.Non è che Dio perdoni perché ci siamo convertiti; egli perdona da sempre e per questo possiamo convertirci.L’azione di Dio previene sempre l’azione dell’uomo. Il suo perdono precede la nostra conversione, e la rende un evento di salvezza. Perdonare è l’opera di Dio per eccellenza, nella quale egli rivela la sua essenza più intima: la misericordia.Peccare in ebraico significa «fallire il bersaglio». Peccatore è colui che non raggiunge il suo fine, come una freccia che manca il segno. Siccome il fine dell’uomo è amare Dio come Dio lo ama, il peccato è l’incapacità di amare che taglia all’uomo le sue relazioni e lo chiude in una solitudine infernale. Il Vangelo di Gesù (la buona notizia di Dio che salva) è destinato a chi si riconosce perduto e peccatore; ne è escluso solo chi si ritiene giusto e non vuole riconoscersi peccatore.Giovanni e Gesù non sono semplicemente posti uno accanto all’altro, ma confrontati. Giovanni dichiara che Gesù è più forte di lui e si riconosce indegno di fargli da schiavo (v. 7). Vengono confrontati anche i rispettivi battesimi: Giovanni immerge gli uomini nell’acqua del Giordano, Gesù li immerge nello Spirito di Dio (v. 8). Ogni commento è superfluo.Il Battista anticipa l’annuncio del Cristo e ne prefigura la vita: una vita povera e coerente fino al martirio.Perché Marco parla di Giovanni e di Gesù servendosi dei testi e del linguaggio dell’Antico Testamento fino al punto di descrivere il vestito del Battezzatore con le stesse parole con cui la Bibbia descrive quello del grande profeta Elia (2Re 1,8)?I motivi sono due. Nella fede di Marco, Gesù è il punto di arrivo di una lunga storia. Tutto ciò che si narra nella Bibbia prima di lui tendeva verso di lui. Egli era l’annunziato dei profeti e l’atteso delle genti. Il secondo motivo è eminentemente pratico: far capire che la storia di Gesù era parte integrante, anzi il culmine, della storia della salvezza. Il ricorso alle Scritture fu una delle chiavi più importanti di cui la primitiva comunità cristiana si è servita per schiudere all’intelligenza il mistero di Gesù e di se stessa.Il modo cristiano di leggere l’Antico Testamento si differenzia da quello giudaico. La caratteristica di fondo della lettura cristiana sta nel fatto che l’attualizzazione delle Scritture e il compimento delle profezie sono concentrati su una persona e su un avvenimento decisivo: il Cristo. Gesù non è soltanto il maestro che istruisce i discepoli nelle Scritture: egli è colui del quale parlano le Scritture (Gv 5,39). L’Antico Testamento è letto a partire dalla risurrezione di Gesù, da un fatto veramente accaduto e non semplicemente da un’attesa, da una speranza. E’ per questo che i cristiani sono convinti di poter leggere l’Antico Testamento più a fondo dei giudei e scoprirvi significati che essi non vedono (2Cor 3,12–18).Chi è dunque Gesù?Gesù è il Signore la cui strada dev’essere preparata (v. 3); è più potente e più degno di Giovanni Battista (v. 7); è colui che battezza con lo Spirito Santo (v. 8).Preparare la strada e raddrizzare i sentieri significa cambiare vita. La realtà è questa: il Signore viene per dare agli uomini il perdono di Dio e per trasformarli con il dono dello Spirito. Senza di lui gli uomini sono nel peccato e incapaci di vera libertà.Isaia si serve del linguaggio del suo universo arcaico: visita ufficiale, precursori spediti a preparare il vitto e l’alloggio, invito agli abitanti del villaggio ad occuparsi dello stato delle vie d’accesso.Qui si tratta dello stato delle anime. Giovanni invita tutti a fare pulizia nella coscienza e ad aprire il cuore per accogliere l’amore di Dio.Gli ebrei attendevano un’effusione dello Spirito per gli ultimi tempi (Gl 3,1), collegata con una purificazione mediante l’acqua (Ez 36,25–26). Gesù ci battezza nello Spirito Santo (Vita di Dio). Il desiderio abissale che Dio ha messo nell’uomo è l’avere desiderio di lui: nel battesimo lo colma pienamente con il dono di sé.. Deus sitit sitiri: Dio desidera di essere desiderato da noi. Dio ha sete che noi abbiamo sete di lui.In questo primo brano del vangelo, Marco ci presenta immediatamente il Battista: in lui prende voce il desiderio di Dio che permea tutto l’Antico Testamento.Il Battista, infatti, sintetizza in poche parole tutto l’Antico Testamento nella sua linea essenziale: attesa del giudizio di Dio (v. 2) e liberazione degli uomini dalla condanna. Egli chiude l’Antico Testamento e preannuncia il Nuovo. E’ l’indice puntato su Gesù. E’ la porta che introduce nella novità assoluta del vangelo.Ora, il Signore è presente e si lascia trovare. Quindi bisogna rivolgersi a lui. Da qui nasce il vigoroso appello alla conversione (v. 4) che il Battista continuamente ci rivolge e la chiamata a un nuovo esodo. Infatti: «Accorreva a lui tutta la regione della Giudea e tutti gli abitanti di Gerusalemme» (v. 5).Questo ultimo esodo, inizio del cammino della nuova liberazione, è tutto diverso da quello dall’Egitto e da quello dalla schiavitù di Babilonia. La gente esce ora dalla Giudea e da Gerusalemme, che avevano costituito la meta degli esodi precedenti, e riattraversa il Giordano, ma in senso inverso: è un esodo verso una nuova patria. La Giudea e Gerusalemme, infatti, sono il luogo da cui uscire per liberarsi dalla schiavitù della legge, che uccide, e accogliere lo Spirito che dà la vita (2Cor 3,6): bisogna uscire dalla propria giustizia (Fil 3,7ss.) per accogliere il Signore che non è più nel luogo santo e inaccessibile, ma qui fra gli uomini, nell’uomo Gesù, nel quale «abita corporalmente tutta la pienezza della divinità» (Col 2,9). L’esodo del verso 5 è l’esodo del Vangelo: l’esodo definitivo verso la patria promessa, verso l’Assoluto: «Sarete come Dio».Il Vangelo è il messaggio della salvezza, l’annuncio della volontà salvifica di Dio: la misericordia è offerta ai peccatori, la speranza è donata ai disperati, il senso della vita e della storia è rivelato ai dubbiosi e agli incerti, il cammino è indicato ai disorientati. E’ la buona novella, il lieto annuncio, un grido di gioia: perché l’uomo prigioniero è liberato e l’uomo perduto è ritrovato.9 In quei giorni Gesù venne da Nazaret di Galilea e fu battezzato nel Giordano da Giovanni. 10 E, uscendo dall’acqua, vide aprirsi i cieli e lo Spirito discendere su di lui come una colomba. 11 E si sentì una voce dal cielo: «Tu sei il Figlio mio prediletto, in te mi sono compiaciuto».La breve annotazione biografica del v. 9 evoca la piena umanità del Messia e le sue umili origini. Nessuno si aspettava un messia proveniente da un oscuro villaggio di Galilea.. Ricordiamo l’esclamazione di Natanaele: «Da Nazaret può mai venire qualcosa di buono?» (Gv 1,46). E nessuno si aspettava un messia che si sottoponesse ad un battesimo di penitenza. Eppure, è in questo figlio di Galilea che si fa presente l’azione salvifica definitiva di Dio per tutti.I cieli, che sembrano separare ermeticamente l’abitazione di Dio da quella degli uomini, si squarciano e la potenza di Dio invade Gesù di Nazaret; così in lui si riconciliano cielo e terra, Dio e umanità.Gesù «sale» dall’acqua incontro allo Spirito che «scende» verso di lui. L’avvenimento richiama Is 61,1: «Lo Spirito del Signore Dio è su di me perché il Signore mi ha consacrato con l’unzione; mi ha mandato a portare il lieto annunzio ai miseri, a fasciare le piaghe dei cuori spezzati, a proclamare la libertà agli schiavi, la scarcerazione ai prigionieri…».L’immagine dello Spirito che scende in forma di colomba evoca la tenerezza amorosa del Padre che si china sul proprio Figlio diletto come una colomba si avvicina ai suoi piccoli svolazzando. Si può vedervi un episodio ispirato a Genesi 1,2; 8,8–12. Lo Spirito, che intervenne nella prima creazione e nel ristabilimento dell’umanità dopo il diluvio, interviene qui per operare la nuova creazione: nel battesimo di Gesù inizia la storia del mondo nuovo.Una nuova voce si sovrappone a quella di Giovanni che grida nel deserto. La voce dal cielo riconosce ed attesta che Gesù è l’unico Figlio di Dio (Sal 2,7), il Servo (Is 42,1) e la vittima che sarà immolata a Dio sopra il monte (Gen 22).I riferimenti al Sal 2,7, a Is 42,1 e a Gen 22 sono particolarmente illuminanti. Gesù e la primitiva comunità cristiana dopo di lui amavano riferirsi a queste grandi profezie per trarne la vera immagine del Messia, servo amato da Dio e perseguitato dagli uomini, fedele al Signore e solidale con il suo popolo al punto di caricarsi sulle spalle i peccati di tutti e di espiarli morendo sulla croce, da dove egli regna. E’ in questa ottica che Gesù viene proclamato «Figlio mio prediletto».. Il battesimo di Gesù guarda dunque in avanti verso la croce: in Mc 10,38–39 la morte di Gesù in croce è chiamata, appunto, battesimo.Giovanni dichiara: «Dopo di me verrà uno più forte di me» (v.7). Gesù è il più forte che noi attendiamo. Ma viene con la forza di Dio che è amore e debolezza estrema. L’amore, infatti, si spoglia e dona tutto fino al dono di sé: si fa in tutto solidale con noi, si fa servo degli uomini suoi fratelli. Come un qualunque sconosciuto si mette in fila coi peccatori e si fa battezzare. Questo ultimo della fila è il nostro Signore e Salvatore. Nessuno avrebbe mai pensato un Dio così. Questa sua solidarietà con noi lo porterà molto lontano, fino a patire con noi e per noi la nostra morte.Il vecchio Adamo si innalzò per rapire l’uguaglianza con Dio e cadde nella morte. Il Figlio di Dio si abbassa fino alla morte e viene innalzato a una vita nuova nella gloria. Gesù, nuovo Adamo, compie la scelta contraria a quella del vecchio.La contemplazione di Gesù in fila con i peccatori corregge in noi la falsa immagine di un Dio onnipotente, giudice tremendo e ci presenta la potenza di un amore che si spoglia di tutto e si fa servo, portando su di sé il male del mondo. L’incontro con lui avviene dove pensiamo che lui sia massimamente assente: nel nostro peccato, nella nostra debolezza.Se la sua potenza ci ha creati, la sua impotenza ci ha salvati. Ci ha creati con le sue mani libere e operose, ci ha salvati con le sue mani inchiodate alla croce, nell’atteggiamento della massima impotenza e inoperosità.Il vero battesimo di Gesù sarà la sua morte in croce (Mc 10,38). Proprio allora, e non prima, il centurione per la prima volta sulla terra proclamerà la stessa parola che il Padre fa risuonare dal cielo: «Veramente quest’uomo era Figlio di Dio!» (Mc 15,39). Qui è già data tutta la struttura del cammino di Gesù e del cristiano, cammino inverso rispetto a quello di Adamo (Fil 2,5–11): il cammino dell’umiliazione che porta all’esaltazione. E’ la logica di tutto il vangelo: «Il primo sarà l’ultimo di tutti e il servo di tutti» (Mc 9,35).Gesù troverà la morte tra due delinquenti, ma già in questo inizio della sua vita pubblica si mette in fila con i peccatori. Questo è il posto di Gesù, e questo deve essere il posto del cristiano.12 Subito dopo lo Spirito lo sospinse nel deserto 13 e vi rimase quaranta giorni, tentato da satana; stava con le fiere e gli angeli lo servivano.Marco descrive la tentazione nel deserto con due soli versetti. Lo Spirito Santo spinge con forza Gesù a uno scontro con satana. Nessun uomo, neppure Gesù è esentato dalla tentazione e dalla lotta: satana non rispetta nessuno. La tentazione è la situazione abituale di ogni uomo che vive in questo mondo di peccato, e Gesù è vissuto in questo mondo. Marco ci presenta un Gesù che deve fare in continuità delle scelte: le tentazioni saranno continue anche per lui fino alla fine. Solo nella risurrezione egli vincerà definitivamente satana.Deserto, quaranta giorni, satana, angeli: elementi che noi incontriamo nella storia di Elia, di Mosè e soprattutto dell’esodo. Marco continua a narrare la storia di Gesù con immagini e parole tolte dall’Antico Testamento: è la storia della salvezza che continua. Gli israeliti (2Cor 10,1–2) si addentrarono nel deserto e vi restarono quarant’anni. Fu un tempo pieno di prove e di tentazioni, ma l’angelo del Signore accompagnava il popolo.Il deserto può significare solitudine e incontro con Dio e può significare l’abitazione del male. Nel vangelo di Marco, il deserto è il luogo della preghiera solitaria (1,35), del rifugio che sottrae alla folla (1,45), del riposo (6,31–32), della moltiplicazione dei pani (6,35).L’espressione «quaranta giorni» è ricca di suggestioni bibliche: quaranta è un numero simbolico che denota il tempo dell’oppressione e del cammino verso la salvezza: i quaranta giorni del diluvio (Gen 7,12), i quarant’anni d’Israele nel deserto (Sal 95,10), i quaranta giorni di Mosè sul Sinai (Es 34,28; Dt 9,18), i quarant’anni del dominio dei Filistei (Gdc 13,1), i quaranta giorni del cammino di Elia nel deserto (1Re 19,8).Nei quaranta giorni di prova vissuti da Gesù nel deserto, il testo di Marco evoca la tipologia dell’esodo (Nm 14,33–34; Dt 2,7; 8,1–6) già applicata a Elia (1Re 19,8) e a Mosè (Es 24,18; 34,28; Dt 9,9). (I «tipi» sono personaggi, avvenimenti, istituzioni della storia sacra che preparavano, prefiguravano, in anticipo, il mistero della salvezza portata a compimento da Cristo).Lo Spirito spinge Gesù a uno scontro con satana (avversario, oppositore). Egli ne esce vittorioso, a differenza di Adamo e del popolo di Dio nel deserto.«Tentato da satana». Ci sono altre tre occasioni in cui il verbo tentare è usato da Marco (8,11; 10,2; 12,15) e, in tutti e tre i casi, si tratta dei farisei che mettono alla prova Gesù. Sorge la domanda: «Esiste qualche parentela tra satana e i farisei?». Il vangelo di Giovanni lo afferma esplicitamente: «Voi (farisei) avete per padre il diavolo e volete compiere i desideri del padre vostro» (Gv 8,44). Satana si è servito di tutto e di tutti per ostacolare la strada messianica di Gesù.«Stava con le fiere e gli angeli lo servivano». Viene evocato un tema paradisiaco (Gen 2,19; Is 11,6–9; 65,25; Os 2,18). Gesù viene presentato come antitipo di Adamo nel paradiso terrestre: ambedue tentati da satana, ma con esito opposto. La caduta di Adamo, ad opera del maligno, fu l’inizio di tutti i mali; la vittoria di Gesù, nuovo Adamo, fu l’inizio del rimedio di tutti i mali. Gesù, subito dopo il battesimo, fu tentato da satana. Il legame tra battesimo e tentazione è stretto: «subito dopo» (v. 12). La vita nella quale il battesimo introduce è fatta di lotta. Come Gesù, anche il cristiano inizia la sua guerra contro satana il giorno del battesimo e potrà cantare vittoria definitiva solo il giorno della risurrezione.Il battesimo di Gesù ci presenta Dio solidale con il nostro male e la nostra morte; le sue tentazioni ci fanno vedere Dio solidale con la nostra fatica di vivere in libertà. Quanto è allettante essere figli di un Dio padrone e onnipotente, altrettanto è scomodo essere figli di un Dio servo, che è amore, povertà, servizio e umiltà.Questo breve racconto, unito a quello del battesimo, anticipa il significato essenziale della vita di Gesù: Egli è l’uomo pieno di Spirito Santo, che è venuto per vincere il male e liberare l’uomo. E’ lo Spirito che spinge con forza Gesù nel deserto, che è luogo di prova, Gesù vi rimane quaranta giorni, ripercorrendo in sé tutta la storia dell’umanità: la storia di Adamo che fu tentato, peccò e morì, la storia del popolo di Dio, che nel deserto fu messo alla prova e cadde! Ma mentre tutti i membri del popolo di Dio soccombettero alla prova e morirono senza giungere alla patria desiderata, Gesù sarà il primo uomo che vince il male, supera la prova e giunge alla terra promessa.La tentazione di Gesù è quella di ogni uomo: quella di «pensare secondo gli uomini» e non secondo «la parola rivelata da Dio»: il male è interno all’uomo, che intende l’esser figlio di Dio a modo suo, come Adamo. In tutto il vangelo si svolgerà il cammino del Figlio di Dio contrapposto al cammino dell’uomo (Fil 2,5–11). Gesù, nuovo Adamo, vince il male e ricostituisce l’ordine com’era all’inizio: infatti, «stava con le fiere» e questo vuol essere il segno della riconciliazione di tutto il creato, liberato ormai dal dominio dell’iniquità.14 Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù si recò nella Galilea predicando il vangelo di Dio e diceva: 15 «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi e credete al vangelo».16 Passando lungo il mare della Galilea, vide Simone e Andrea, fratello di Simone, mentre gettavano le reti in mare; erano infatti pescatori. 17 Gesù disse loro: «Seguitemi, vi farò diventare pescatori di uomini». 18 E subito, lasciate le reti, lo seguirono. 19 Andando un poco oltre, vide sulla barca anche Giacomo di Zebedèo e Giovanni suo fratello mentre riassettavano le reti. 20 Li chiamò. Ed essi, lasciato il loro padre Zebedèo sulla barca con i garzoni, lo seguirono.Giovanni il Battista ha introdotto Gesù nella storia del suo tempo, poi è scomparso dalla scena bruscamente: questo è il destino di tutti i profeti. Giovanni scompare per lasciare il posto al «più forte» di lui.Le parole di Gesù del v. 15 contengono due elementi: l’annuncio di ciò che Dio sta per fare e il comando agli uomini perché rispondano all’azione di Dio con l’atteggiamento adeguato: la conversione e la fede.«Il tempo è compiuto». L’attesa è finita, le promesse si sono realizzate; è l’ultima tappa della storia della salvezza, l’ultima fase della realizzazione del progetto di Dio; è la fine dei tempi (Ger 3,17; 5,8; 50,4.20; Ez 7,7.12; Dan 7,22; 12,4.9); è giunta la pienezza dei tempi (Gal 4,4; Eb 9,26); il momento presente è pieno fino all’orlo della presenza di Dio che salva.Proclamando il Vangelo, Gesù dà consistenza alla storia degli uomini, dà un contenuto vero e un senso nuovo al tempo e allo spazio: dà senso al passato, al presente e al futuro. Gesù è Dio che riempie di senso infinito il nostro non–senso: senza di lui siamo pieni di vuoto.«Il regno di Dio è vicino». E’ vicino il momento in cui Dio eserciterà in modo effettivo e completo la sua sovranità sul mondo. Se adesso il mondo è governato dalla potenza del denaro, dell’inganno e della forza (la potenza di satana), è vicino il momento in cui Dio prenderà nelle sue mani il potere. Sta per cambiare radicalmente il regime del governo del mondo: si instaura definitivamente la sovranità di Dio che significa giustizia, concordia, pace, pienezza di vita.«Dio regna!» è la buona notizia. Se finora gli uomini hanno obbedito a satana e le loro scelte erano determinate dall’interesse, dal proprio comodo e dalla volontà di primeggiare, ora non deve più essere così: c’è stata la rivoluzione, è cambiato il regime e la legge.Il regno di Dio è presente nella persona di Gesù, nelle sue parole: poi si comunicherà ai Dodici, alle folle e al mondo.«Convertitevi e credete nel vangelo». La conversione è un cambiamento radicale, un vero e proprio rovesciamento, un passaggio dall’egoismo all’amore, dalla difesa dei propri interessi alla solidarietà. Deve cambiare l’atteggiamento interiore e la condotta esteriore. Convertirsi è voltarsi verso Dio in atteggiamento di obbedienza e accogliere con gioia la sua sovranità. Se la sovranità di satana era oppressiva, quella di Dio sarà liberante: servire Dio è regnare.Ecco dunque il vangelo: la possibilità di sperimentare gioiosamente la sovranità di Dio sulla propria vita.Il breve racconto della chiamata dei primi quattro discepoli vuole essere un esempio concreto di conversione; non la conversione proposta a degli specialisti del regno di Dio, ma semplicemente la conversione necessaria per essere cristiani.L’iniziativa è di Gesù: la vita cristiana non è tanto una scelta nostra quanto una risposta alla sua chiamata. L’appello di Cristo ha una nota di urgenza: è il momento favorevole, non c’è tempo da perdere: è la grande occasione.L’appello di Gesù esige un distacco radicale: lasciare le ricchezze (Mc 10,21), abbandonare la strada del dominio e del potere (Mc 9,35), smantellare quell’idea di Dio che abbiamo costruito a difesa dei nostri privilegi (Mc 7,8–13), vivere nella logica della croce (Mc 8,34) fino a riconoscere nel volto sfigurato di un uomo crocifisso la vera immagine del Dio senza figura (Mc 15,39).«Subito, lasciate le reti, … lasciato il padre, … lo seguirono». Il racconto della chiamata degli apostoli si ispira alla chiamata di Eliseo (1Re 19,19–21). Immediata rottura con il passato, cambio di rotta, conversione. Per questi primi quattro discepoli la forza di attrazione del regno di Dio è stata così grande da superare quella del possesso, degli affetti familiari e dell’abitudine. La fede si concretizza in un’adesione totale alla persona di Gesù, nell’accogliere lui come guida e come scopo della propria vita: vivere per lui nel senso più pieno.21 Andarono a Cafarnao e, entrato proprio di sabato nella sinagoga, Gesù si mise ad insegnare. 22 Ed erano stupiti del suo insegnamento, perché insegnava loro come uno che ha autorità e non come gli scribi. 23 Allora un uomo che era nella sinagoga, posseduto da uno spirito immondo, si mise a gridare: 24 «Che c’entri con noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci! Io so chi tu sei: il santo di Dio». 25 E Gesù lo sgridò: «Taci! Esci da quell’uomo». 26 E lo spirito immondo, straziandolo e gridando forte, uscì da lui. 27 Tutti furono presi da timore, tanto che si chiedevano a vicenda: «Che è mai questo? Una dottrina nuova insegnata con autorità. Comanda persino agli spiriti immondi e gli obbediscono!». 28 La sua fama si diffuse subito dovunque nei dintorni della Galilea.L’attività di Gesù si concentra in una giornata a Cafarnao (Mc 1,21–45), poi la sua missione si allarga a tutta la Galilea.La «giornata di Cafarnao» è il modello in piccolo di quello che sarà tutto il ministero di Gesù. Lo riassumiamo così: Gesù insegna, caccia i demoni, guarisce i malati, prega. Questo è il ritmo fondamentale della vita di Gesù: attività e preghiera.L’attività di Gesù comprende due elementi: parole e opere. Marco ama rilevare soprattutto la potenza e l’autorità con cui Gesù parla e agisce. Egli si presenta così: una potenza sovrumana, una compassione che si avvicina a ogni povero, malato, peccatore.Gesù incontra gli uomini del suo tempo lì dove essi sono normalmente: mentre celebrano il sabato o si dedicano alle loro occupazioni. Li avvicina nelle situazioni in cui si trovano: tormentati interiormente, colpiti da malattia, immersi nella loro miseria.La potenza di Gesù si manifesta nella sinagoga, poi in casa, quindi alla porta della città: tutto lo spazio, sacro e profano, viene riempito dalla sua presenza.«Spirito immondo». La Bibbia definisce immondo o impuro tutto ciò che si oppone alla santità divina. I demoni sono forze d’opposizione all’azione di Dio, quindi sono detti immondi.La proclamazione del Vangelo scatena la guerra. Tra Gesù e satana c’è un contrasto netto e irriducibile. La novità del Vangelo è la vittoria di Gesù sul male sotto qualunque forma si presenti. Il male non viene solo dall’uomo: dentro di lui c’è un inquilino che lo degrada e lo distrugge. Gesù è venuto a scacciarlo.Senza Cristo siamo tutti in balia delle forze del male e incapaci di entrare in comunione con Dio, anche se siamo nella sinagoga (v. 23): la religione che salva non è la pratica di un culto o la presenza materiale nei luoghi sacri o l’adempimento di un precetto, ma l’incontro personale con Cristo.«Il Santo di Dio». Questo titolo rivela la vera identità di Gesù e la sua autorità divina. Il Santo di Dio è l’avversario dichiarato del peccato che solo Dio può smascherare e perdonare.Dopo la guarigione dell’indemoniato, la meraviglia di tutti si manifesta in forma corale. L’avvenimento è provocante perché Gesù non ha agito come gli esorcisti del suo tempo, con incantesimi o formule magiche, ma soltanto con la sua parola.Gesù libera dal potere di satana. Ma gli uomini sono disposti ad accettare la libertà di Cristo? La risposta è solo in parte affermativa. Se vi sono i discepoli che lo seguono, vi sono però altri, la massa, che si limitano all’entusiasmo inconcludente e alle belle parole. La gente per Marco è sempre una massa che vive nell’indecisione e spesso preferisce una schiavitù comoda a una libertà esigente. Ma il discepolo non può essere così.29 E, usciti dalla sinagoga, si recarono subito in casa di Simone e di Andrea, in compagnia di Giacomo e di Giovanni. 30 La suocera di Simone era a letto con la febbre e subito gli parlarono di lei. 31 Egli, accostatosi, la sollevò prendendola per mano; la febbre la lasciò ed essa si mise a servirli.32 Venuta la sera, dopo il tramonto del sole, gli portavano tutti i malati e gli indemoniati. 33 Tutta la città era riunita davanti alla porta. 34 Guarì molti che erano afflitti da varie malattie e scacciò molti demòni; ma non permetteva ai demòni di parlare, perché lo conoscevano.35 Al mattino si alzò quando ancora era buio e, uscito di casa, si ritirò in un luogo deserto e là pregava. 36 Ma Simone e quelli che erano con lui si misero sulle sue tracce 37 e, trovatolo, gli dissero: «Tutti ti cercano!». 38 Egli disse loro: «Andiamocene altrove per i villaggi vicini, perché io predichi anche là; per questo infatti sono venuto!». 39 E andò per tutta la Galilea, predicando nelle loro sinagoghe e scacciando i demòni.La guarigione della suocera di Pietro ci presenta il miracolo del servizio. Può sembrare un miracolo insignificante. Ma i miracoli non sono spettacoli di potenza, ma segni della misericordia di Dio. In questo racconto la piccolezza del segno è tutta a vantaggio della grandezza del significato: un miracolo più straordinario avrebbe attirato la nostra attenzione a scapito di ciò di cui è segno.Con questo piccolissimo segno l’evangelista ci dà il significato di tutti i miracoli: sono delle guarigioni che Gesù opera per restituire a ciascuno di noi la capacità di servire, che è la nostra somiglianza con Dio.Il miracolo che Gesù è venuto a compiere in terra è la capacità di amare, cioè di servire. Chi ama serve, serve gratuitamente, serve continuamente, serve tutti indistintamente.Noi siamo raffigurati nella suocera di Pietro: incapaci di servire, costretti a farci servire o a servirci degli altri. Il contatto con Gesù ci rende come lui, che è venuto per servire (Mc 10,45).Il servizio è la guarigione dalla febbre mortale dell’uomo: l’egoismo, che lo uccide come immagine di Dio che è amore. L’egoismo si esprime nel servirsi degli altri, che porta all’asservimento reciproco; l’amore si realizza nel servire, che porta alla libertà dell’altro. Solo nel servizio reciproco saremo tutti finalmente liberi: «Portate i pesi gli uni degli altri, così adempirete la legge di Cristo» (Gal 6,3).Il fatto che Gesù non lascia parlare i demoni è un aspetto importante del Vangelo. Egli vuol farci capire che una conoscenza di Dio, prima di vederlo in croce, è diabolica: non capiremmo né il nostro male né il suo amore. Sarebbe la solita presentazione di un Dio creato dalla nostra testa. Voltaire ha scritto: «Dio ha creato l’uomo a sua immagine, e l’uomo ha creato Dio a sua immagine».La giornata tipo di Gesù si conclude con una preghiera notturna, che dà inizio alla nuova attività. Per lui la contemplazione è insieme termine e sorgente dell’azione, fine di ciò che ha fatto e principio di ciò che sta per fare.L’uomo, fatto a immagine e somiglianza di Dio, è totalmente se stesso quando sta davanti a Dio. Per questo il fine di ogni apostolato è insegnare a stare davanti a Dio e a pregare il vero Dio nel modo giusto. Dal vero rapporto con Dio nasce di conseguenza il vero rapporto con sé, con gli altri e con le cose.Il cristiano prega soprattutto per ringraziare Dio che gli dà tutto, per amarlo, per conoscerlo meglio e vivere così nella gioia, nell’amore e nella verità.La preghiera non serve per ricevere qualcosa, ma per diventare Qualcuno: per diventare come il Dio che preghiamo, per essere perfetti come è perfetto il Padre nostro che è nei cieli (cf. Mt 5,48). La preghiera è il punto di arrivo di ogni realtà cristiana perché è l’approdo in Dio.«Andiamocene altrove». L’entusiasmo delle folle e la popolarità condizionano l’agire umano e impediscono la vera libertà. Chi vuole a tutti i costi suscitare applausi non riesce ad evitare i compromessi.Gesù scarta le immagini false che la gente si fa del suo ruolo di guaritore. Egli taglia corto riguardo all’entusiasmo popolare.Proprio perché Gesù sa sottrarsi ai primi frutti della sua missione, questa può estendersi per tutta la Galilea.40 Allora venne a lui un lebbroso: lo supplicava in ginocchio e gli diceva: «Se vuoi, puoi guarirmi!». 41 Mosso a compassione, stese la mano, lo toccò e gli disse: «Lo voglio, guarisci!». 42 Subito la lebbra scomparve ed egli guarì. 43 E, ammonendolo severamente, lo rimandò e gli disse: 44 «Guarda di non dir niente a nessuno, ma va’, presentati al sacerdote, e offri per la tua purificazione quello che Mosè ha ordinato, a testimonianza per loro». 45 Ma quegli, allontanatosi, cominciò a proclamare e a divulgare il fatto, al punto che Gesù non poteva più entrare pubblicamente in una città, ma se ne stava fuori, in luoghi deserti, e venivano a lui da ogni parte.Secondo la concezione ebraica, la lebbra era «la primogenita della morte» (Gb 18,13). Chi veniva segnato da questa malattia doveva tenersi separato dagli altri e non poteva avvicinarsi a nessuno. I lebbrosi erano lasciati languire lungamente in una lenta morte, e per giunta venivano infamati come peccatori, perché la lebbra era considerata il castigo di gravi peccati.La legge ebraica dichiarava intoccabile un lebbroso, ma per Gesù non c’è legge che valga quando c’è di mezzo il bene di un uomo.Gesù è la «buona notizia» di uno che tocca il lebbroso e lo guarisce. Egli è il medico venuto per guarire tutti i mali e tutti i malati (Mc 2,17).Solo Gesù può liberare la nostra vita dalla lebbra che la devasta. Gli uomini e le leggi riconoscono il male e lo condannano, ma solo Gesù lo guarisce.Il nostro diritto di accostarci al Signore non viene dal fatto di essere giusti e degni, belli e buoni, ma proprio dal fatto che siamo ingiusti e immondi, brutti e peccatori. Il diritto di precedenza è dato ai malati più gravi. Dio guarda il nostro bisogno, non il nostro merito.Questo è il vangelo, la buona notizia che ci salva: Dio mi ama perché mi ama; la mia miseria non è ostacolo, ma misura della sua misericordia. Dio non è la legge che mi giudica né la coscienza che mi condanna: è il Padre che dà la vita, e mi ama più di se stesso, senza condizioni, così come sono. Il mio male non lo allontana, ma lo attira verso di me con un amore che non conosce altro metro che quello del mio bisogno. San Tommaso d’Aquino ha scritto: «Dio non ci ama perché siamo buoni, ma ci rende buoni amandoci».Il comportamento antipubblicitario di Gesù ci ricorda un importante proverbio: «Il bene non fa rumore e il rumore non fa bene». Coloro che credono con umiltà, come la suocera di Pietro o il paralitico, non hanno bisogno di essere zittiti: servono e ubbidiscono.
CAPITOLO 021 Entrò di nuovo nella sinagoga. C’era un uomo che aveva una mano inaridita, 2 e lo osservavano per vedere se lo guariva in giorno di sabato per poi accusarlo. 3 Egli disse all’uomo che aveva la mano inaridita: «Mettiti nel mezzo!». 4 Poi domandò loro: «È lecito in giorno di sabato fare il bene o il male, salvare una vita o toglierla?». 5 Ma essi tacevano. E guardandoli tutt’intorno con indignazione, rattristato per la durezza dei loro cuori, disse a quell’uomo: «Stendi la mano!». La stese e la sua mano fu risanata. 6 E i farisei uscirono subito con gli erodiani e tennero consiglio contro di lui per farlo morire.Un altro episodio ancora riguardo al sabato. Questa volta però non sono i discepoli di Gesù che trasgrediscono la legge, ma Gesù stesso. Il criterio di Gesù è questo: «Fare il bene, salvare una vita» (v. 4). Proprio a questo deve servire la legge del sabato: per la libertà e per il bene dell’uomo, per evitargli una vita da schiavo e da forzato.«Rattristato per la durezza dei loro cuori» (v. 5). Gesù aveva cercato di evitare questa situazione; si era sforzato di rompere le barriere cercando il dialogo, perché fossero loro a dire ciò che si poteva fare in giorno di sabato, «ma essi tacevano» (v. 5). A questo punto Gesù fece la sua scelta: scelse l’uomo e lo guarì. Non lasciò passare quel giorno di festa senza che diventasse anche per quel malato un segno concreto di libertà. Gesù ha sempre amato la libertà per sé e per gli altri.«Tennero consiglio contro di lui per farlo morire» (v. 6). Perché Gesù deve morire se guarisce la gente e cerca il vero bene dell’uomo? Per gli scribi la vera immagine di Dio può essere soltanto quella del giudice che condanna il colpevole (e, in questo, ben volentieri, gli darebbero una mano. Cf. anche Gv 8,3–11).E’ abissale la differenza tra la loro concezione di Dio e il vero Dio, manifestato da Gesù: un Dio che sana, perdona, riconcilia, ama. Nel contrasto tra Gesù e coloro che detengono il potere, sono in gioco due diverse concezioni di Dio.Facciamo una breve digressione sulla logica dei farisei. Essi non hanno approvato la guarigione di un malato in giorno di sabato per timore di violare la legge, ma non hanno scrupolo, in giorno di sabato, di decidere la morte di una persona innocente, del Salvatore, di Dio stesso. Guarire e far vivere è un delitto che merita la morte, far morire è un’opera buona che rende gloria a Dio. Strana logica, strana morale: è la «morale» dell’odio che si oppone alla morale dell’amore. I farisei avevano fatto di Dio il nemico dell’uomo: il colmo dell’opera diabolica (cf. Gen 3; Gv 8,44).In Gesù si rivela Dio–con–noi–e–per–noi: questa è la grande novità della rivelazione. Ma gli uomini spesso rifiutano un Dio amico che li ama e li libera, e gli preferiscono un falso dio che li spadroneggi. Di fronte alla durezza di cuore dei farisei, Gesù prova indignazione e tristezza. Il Cristo manifesta contemporaneamente la collera di Dio e la sua compassione che non viene mai meno di fronte alle sue creature incapaci di aprirsi alle sue sollecitazioni.Il miracolo della guarigione dell’uomo che aveva la mano secca costerà la vita a Gesù. La croce si profila ormai chiaramente. E’ il prezzo del dono che ci fa guarendo la nostra mano incapace di accogliere e di donare. Le sue mani inchiodate scioglieranno la nostra mano rigida.Si scorge all’orizzonte l’albero dal quale penderà Gesù, il frutto della vita, verso cui possiamo e dobbiamo tendere la mano per diventare come Dio (cf. Gen 3).Questo racconto chiude una tappa del vangelo in cui Gesù ci ha rivelato chi è lui per noi in ciò che ha fatto per noi.7 Gesù intanto si ritirò presso il mare con i suoi discepoli e lo seguì molta folla dalla Galilea. 8 Dalla Giudea e da Gerusalemme e dall’Idumea e dalla Transgiordania e dalle parti di Tiro e Sidone una gran folla, sentendo ciò che faceva, si recò da lui. 9 Allora egli pregò i suoi discepoli che gli mettessero a disposizione una barca, a causa della folla, perché non lo schiacciassero. 10 Infatti ne aveva guariti molti, così che quanti avevano qualche male gli si gettavano addosso per toccarlo.11 Gli spiriti immondi, quando lo vedevano, gli si gettavano ai piedi gridando: «Tu sei il Figlio di Dio!». 12 Ma egli li sgridava severamente perché non lo manifestassero.Il rifiuto e la condanna a morte di Gesù, da parte dei farisei e degli erodiani, segna il nuovo inizio del popolo di Dio. L’efficacia evangelica è molto diversa dall’efficienza umana: trae la sua forza dall’impotenza dell’uomo e dalla potenza di Dio: «Quando sono debole, è allora che sono forte» (2Cor 12,10). Perché Dio, contrariamente all’uomo, sa trarre successo dall’insuccesso e vita dalla morte.Le località nominate sono sette, un numero che indica completezza, totalità. Tutti accorrono a Cristo per formare la sua Chiesa. Egli non ha raggiunto il successo mediante la brama di avere, di potere e di apparire, origine di ogni male, ma ha vinto tutto questo proprio con il suo insuccesso, con la povertà, con il servizio e l’umiltà di chi ama.Gesù è presentato come il centro di un ampio movimento di gente che cerca e trova in lui la possibilità di guarire. L’uomo è malato e il pellegrinaggio verso Gesù nasce da questo bisogno di salvezza.È bello vedere Gesù pressato da tanta gente. Ma perché accorrono? Per interesse o per fede? Marco ci fa capire che l’entusiasmo della folla è suscitato dall’azione guaritrice di Gesù, non dalla fede.Solo i demoni conoscono l’identità di Gesù e la proclamano. Ma la loro propaganda è controproducente; il loro intento è di far fallire la rivelazione autentica di Gesù «bruciandola» anzitempo: di qui la reazione di Gesù che impone loro di tacere.La trappola tesa a Gesù dai demoni sta nel fatto che satana vuole anticipare la manifestazione della gloria di Gesù prima della sua morte in croce, perché solo lì Gesù si rivela veramente Figlio di Dio (cf. Mc 15,39), che dona agli uomini la salvezza totale e definitiva, cioè la redenzione della loro esistenza nella comunione con Dio. E’ la tentazione che satana gli ripresenterà nuovamente per mezzo di Pietro (Mc 8,32–33).La fede non è solo sapere chi è Gesù. Anche i demoni lo sanno, meglio e prima di noi. Come scrive s. Giacomo: «Credono, ma tremano» (2,19). Credere è prima di tutto fare esperienza di Gesù che mi ha amato e ha dato se stesso per me (cf. Gal 2,20). Una fede ideologica, che tutto conosce, ma non fa esperienza dell’amore di Dio, è un anticipo dell’inferno. E’ la pena del dannato che conosce il bene, ma non lo possiede.Il Signore non desidera la pubblicità da parte di nessuno (tanto meno da parte dei demoni!). Raggiunge tutti solo attraverso la debolezza di chi, conoscendolo veramente, lo annuncia come amore crocifisso, povero, umiliato e umile. La propaganda va esattamente nella direzione opposta e si serve proprio di quei mezzi che il Signore ha denunciato e rifiutato come tentazioni.13 Salì poi sul monte, chiamò a sé quelli che egli volle ed essi andarono da lui. 14 Ne costituì Dodici che stessero con lui15 e anche per mandarli a predicare e perché avessero il potere di scacciare i demòni.16 Costituì dunque i Dodici: Simone, al quale impose il nome di Pietro; 17 poi Giacomo di Zebedèo e Giovanni fratello di Giacomo, ai quali diede il nome di Boanèrghes, cioè figli del tuono; 18 e Andrea, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Tommaso, Giacomo di Alfeo, Taddeo, Simone il Cananèo 19 e Giuda Iscariota, quello che poi lo tradì.È inutile cercare di localizzare questo monte perché «la montagna», in Marco, indica soprattutto il luogo delle rivelazioni divine, mentre il mare, come vedremo (4,35–39; 5,46–52), appare come il luogo della prova e delle dure realtà umane.Il numero dodici ha un chiaro valore simbolico: deve, evidentemente, essere messo in relazione con quello delle dodici tribù d’Israele presenti al Sinai per formare la comunità dell’Alleanza (Es 24,4; Dt 1,23; Gs 3,12; 4,2ss).La funzione dei Dodici viene subito precisata: «Ne costituì Dodici che stessero con lui e anche per mandarli a predicare e perché avessero il potere di scacciare i demoni» (vv. 14–15). Marco ha descritto Gesù come colui che predica e scaccia i demoni (1,39); ora afferma la stessa cosa dei suoi discepoli. La missione di Gesù continua e si rende visibile nel mondo attraverso i suoi inviati.Gesù sceglie e chiama. È il cerchio di Gesù che si allarga: partecipa ad altre persone la sua forza e la sua autorità. In Gesù il regno di Dio si è fatto vicino agli uomini; ora si dilata nei Dodici e attraverso di loro si estenderà al mondo intero.Questi uomini sono presi dalla gente comune, con pregi e difetti, e sarebbe ingenuo e sbagliato idealizzare il gruppo che ne è uscito: non è una comunità di puri né un gruppo di educande. Il seguito del vangelo ce ne darà puntuale conferma.Il cristianesimo non è un’ideologia: è una compagnia reale con Gesù, in un rapporto da persona a persona, che ci coinvolge totalmente. E da questo coinvolgimento con Gesù, veniamo spinti verso tutti gli uomini fino agli estremi confini della terra: «L’amore di Cristo ci spinge… (2Cor 5,14).Andare verso tutti gli uomini e stare con lui sembrano due cose contraddittorie. Ma, in realtà, il Cristo va insieme con i cristiani: «Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore operava con loro e confermava la parola con i prodigi che l’accompagnavano» (Mc 16,20).Non c’è alternativa tra contemplazione e azione. La nostra missione nasce dall’essere in Cristo, e la nostra prima occupazione è di restare uniti con lui come il tralcio alla vite (cf. Gv 15,1ss), fino ad essere contemplativi nell’azione.20 Entrò in una casa e si radunò di nuovo attorno a lui molta folla, al punto che non potevano neppure prendere cibo.21 Allora i suoi, sentito questo, uscirono per andare a prenderlo; poiché dicevano: «È fuori di sé».A questo punto il vangelo comincia a presentare le prime risposte degli uomini al problema fondamentale: «Chi è Gesù?».La prima è dei «suoi», cioè dei parenti di Gesù, i quali dicevano: «E’ fuori di sé» (v. 21). Lo considerano dunque un pazzo, uno scriteriato, uno che getta il discredito su tutta la famiglia. La cosa migliore è prenderlo e rinchiuderlo.Questo testo ci rivela la maniera di pensare degli uomini, ai quali manca qualsiasi comprensione per le assolute esigenze di Dio. Essi non comprendono che un uomo possa essere tutto preso dagli interessi di Dio e dedicarsi completamente al suo servizio. Una tale cecità è sempre un pericolo per parenti e familiari di uomini che Dio chiama a un particolare servizio, ed è un ammonimento a guardarsi da pensieri di ordine semplicemente naturale e da preoccupazioni borghesi riguardo al buon nome, alla salute e agli affari. Gesù sta al di fuori di queste categorie e fa entrare anche i suoi discepoli al servizio delle esigenze totalitarie di Dio.Più avanti i suoi parenti torneranno alla carica (Mc 3,31–35) e il ritorno di Gesù nella sua patria renderà palese lo stesso rifiuto a credergli (Mc 6,1–8).Secondo i «suoi» (vedi Pietro in Mc 8,31ss), Gesù dovrebbe avere un po’ più di buon senso: Dovrebbe investire meglio le sue qualità per avere di più, potere di più e valere di più.. Secondo i «suoi», questi sono i mezzi utili per il trionfo del bene, per togliere il potere ai cattivi, per orientare tutto «a fin di bene» e, soprattutto, per la gloria di Dio.Gesù invece simpatizza con i cattivi e trascura i propri interessi: si può prevedere che con la sua bontà e sprovvedutezza, e facendo l’avvocato degli emarginati e di quelli che non contano (l’avvocato delle cause perse!), andrà a finir male.È fuori di sé, è pazzo! Per noi che abbiamo barattato l’intelligenza con la furbizia, saggio è colui che cerca l’utile e il vantaggio proprio, e non il bene e la verità.. Questo buon senso umano ha fuorviato i parenti di Gesù, fuorvierà Giuda e tanti altri dopo di lui.Gesù fu, è e sarà rifiutato proprio perché povero, umiliato e umile. Ma questa sua pazzia è la sapienza di Dio. «Mentre i giudei chiedono miracoli e i greci cercano la sapienza, noi predichiamo Cristo crocifisso, scandalo per i giudei, stoltezza per i pagani; ma per coloro che sono chiamati, sia giudei che greci, predichiamo Cristo potenza di Dio e sapienza di Dio. Perché ciò che è stoltezza di Dio è più sapiente degli uomini, e ciò che è debolezza di Dio è più forte degli uomini» (1Cor 1,22–25).«Essere con Gesù» richiede il cambiamento dal pensiero dell’uomo al pensiero di Dio. Senza questa conversione radicale della mente e del cuore si rimane fuori della sua famiglia, anche se ci sembra di volergli bene.Senza una conversione radicale, in realtà, non si ama lui, ma se stessi e i propri progetti proiettati in lui e nei suoi progetti, pronti a seguirlo quando lui ci segue e a catturarlo quando lui non ci segue. Questo non è amore, ma egoismo, è il tentativo di assimilare lui a noi invece di assimilare noi a lui.Anche nella preghiera, c’è la tentazione costante di chiedere a Dio di fare la nostra volontà invece della sua. E, naturalmente, sempre a fin di bene!22 Ma gli scribi, che erano discesi da Gerusalemme, dicevano: «Costui è posseduto da Beelzebùl e scaccia i demòni per mezzo del principe dei demòni». 23 Ma egli, chiamatili, diceva loro in parabole: «Come può satana scacciare satana?24 Se un regno è diviso in se stesso, quel regno non può reggersi; 25 se una casa è divisa in se stessa, quella casa non può reggersi. 26 Alla stessa maniera, se satana si ribella contro se stesso ed è diviso, non può resistere, ma sta per finire. 27 Nessuno può entrare nella casa di un uomo forte e rapire le sue cose se prima non avrà legato l’uomo forte; allora ne saccheggerà la casa. 28 In verità vi dico: tutti i peccati saranno perdonati ai figli degli uomini e anche tutte le bestemmie che diranno; 29 ma chi avrà bestemmiato contro lo Spirito santo, non avrà perdono in eterno: sarà reo di colpa eterna». 30 Poiché dicevano: «È posseduto da uno spirito immondo».La seconda risposta degli uomini al problema fondamentale: «Chi è Gesù?» è data dagli scribi venuti da Gerusalemme. Sono persone importanti, hanno una posizione ufficiale nel mondo religioso giudaico, sono esperti della legge di Dio che hanno studiato a Gerusalemme, il centro culturale d’Israele. Essi tengono una specie di consulto, al termine del quale esprimono la loro diagnosi: «E’ posseduto da Beelzebùl, principe dei demoni» (v. 22), «è posseduto da uno spirito immondo» (v. 30).Queste due risposte, che definiscono Gesù pazzo e indemoniato, hanno una cosa in comune: definiscono Gesù indegno di essere preso in considerazione. Lui che guarisce i malati è giudicato malato; lui che scaccia i demoni è giudicato posseduto dal demonio.C’è nell’uomo qualcosa di demoniaco quando si ripiega su se stesso e rifiuta la luce dello Spirito Santo. L’accusa degli scribi non è solamente una calunnia, ma anche una bestemmia. Attribuire a satana la potenza di cui Gesù dispone, significa opporsi all’azione dello Spirito Santo e rendere inefficace la misericordia divina.L’unico caso in cui il perdono può essere inefficace è il rifiuto di lasciarsi perdonare: è questo il peccato contro lo Spirito Santo. Peccare contro lo Spirito santo significa rifiutare di credere che in Gesù agisce Dio salvatore. Questo rifiuto è il peccato più grande che l’uomo possa commettere. Finché l’uomo rimane in simile situazione di rifiuto, la salvezza è impossibile. «In nessun altro c’è salvezza; non vi è infatti altro nome dato agli uomini sotto il cielo nel quale è stabilito che possiamo essere salvati» (At 4,12).Solo la fede in Gesù può eliminare la tragedia della situazione umana, altrimenti l’uomo «non avrà il perdono in eterno: sarà reo di colpa eterna» (v. 29).Dio perdona sempre tutti. Il peccato contro lo Spirito Santo è rifiutare il perdono che Dio ci offre. Se questo nostro rifiuto rimane per sempre, il peccato e la conseguente dannazione, dureranno per sempre.Non è Dio che non perdona; è l’uomo che non vuole essere perdonato. Gesù denuncia questo peccato «eterno» non per condannare gli scribi, ma per chiamarli a conversione, mostrando loro la gravità di quanto stanno facendo. Ogni «minaccia» di Dio nella Bibbia è di questo tipo, e raggiunge il suo effetto quando non si avvera perché ha provocato la conversione.31 Giunsero sua madre e i suoi fratelli e, stando fuori, lo mandarono a chiamare. 32 Tutto attorno era seduta la folla e gli dissero: «Ecco tua madre, i tuoi fratelli e le tue sorelle sono fuori e ti cercano». 33 Ma egli rispose loro: «Chi è mia madre e chi sono i miei fratelli?». 34 Girando lo sguardo su quelli che gli stavano seduti attorno, disse: «Ecco mia madre e i miei fratelli! 35 Chi compie la volontà di Dio, costui è mio fratello, sorella e madre».Gesù si era allontanato dalla madre e dai parenti per seguire il richiamo di Dio, e ora mostra di essersi separato da essi anche interiormente non per freddezza d’animo o per disprezzo dei legami familiari, ma per appartenere completamente a Dio: egli ha compiuto personalmente quanto esige anche dai suoi discepoli: «Chi ama il padre o la madre più di me non è degno di me; chi ama il figlio o la figlia più di me non è degno di me» (Mt 10,37).Ma la sua risposta non ha solo questo significato; essa riguarda soprattutto la consapevolezza che la comunità cristiana deve avere di sé. Gesù si è scelto un’altra famiglia al posto di quella naturale: una famiglia spirituale.Il problema proposto dal brano è il discernimento se siamo con lui o contro di lui; se siamo dentro o fuori dalla comunità di Gesù. La vera famiglia di Gesù è composta da coloro che compiono la volontà di Dio: «Chi compie la volontà di Dio, costui è mio fratello, sorella e madre» (v. 35).Il compimento della volontà del Padre che è nei cieli sarà l’elemento discriminante anche nel giorno del giudizio finale: «Non chiunque mi dice: Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio, che è nei cieli» (Mt 7,21).
CAPITOLO 03
1 Entrò di nuovo nella sinagoga. C’era un uomo che aveva una mano inaridita, 2 e lo osservavano per vedere se lo guariva in giorno di sabato per poi accusarlo. 3 Egli disse all’uomo che aveva la mano inaridita: «Mettiti nel mezzo!». 4 Poi domandò loro: «È lecito in giorno di sabato fare il bene o il male, salvare una vita o toglierla?». 5 Ma essi tacevano. E guardandoli tutt’intorno con indignazione, rattristato per la durezza dei loro cuori, disse a quell’uomo: «Stendi la mano!». La stese e la sua mano fu risanata. 6 E i farisei uscirono subito con gli erodiani e tennero consiglio contro di lui per farlo morire.Un altro episodio ancora riguardo al sabato. Questa volta però non sono i discepoli di Gesù che trasgrediscono la legge, ma Gesù stesso. Il criterio di Gesù è questo: «Fare il bene, salvare una vita» (v. 4). Proprio a questo deve servire la legge del sabato: per la libertà e per il bene dell’uomo, per evitargli una vita da schiavo e da forzato.«Rattristato per la durezza dei loro cuori» (v. 5). Gesù aveva cercato di evitare questa situazione; si era sforzato di rompere le barriere cercando il dialogo, perché fossero loro a dire ciò che si poteva fare in giorno di sabato, «ma essi tacevano» (v. 5). A questo punto Gesù fece la sua scelta: scelse l’uomo e lo guarì. Non lasciò passare quel giorno di festa senza che diventasse anche per quel malato un segno concreto di libertà. Gesù ha sempre amato la libertà per sé e per gli altri.«Tennero consiglio contro di lui per farlo morire» (v. 6). Perché Gesù deve morire se guarisce la gente e cerca il vero bene dell’uomo? Per gli scribi la vera immagine di Dio può essere soltanto quella del giudice che condanna il colpevole (e, in questo, ben volentieri, gli darebbero una mano. Cf. anche Gv 8,3–11).E’ abissale la differenza tra la loro concezione di Dio e il vero Dio, manifestato da Gesù: un Dio che sana, perdona, riconcilia, ama. Nel contrasto tra Gesù e coloro che detengono il potere, sono in gioco due diverse concezioni di Dio.Facciamo una breve digressione sulla logica dei farisei. Essi non hanno approvato la guarigione di un malato in giorno di sabato per timore di violare la legge, ma non hanno scrupolo, in giorno di sabato, di decidere la morte di una persona innocente, del Salvatore, di Dio stesso. Guarire e far vivere è un delitto che merita la morte, far morire è un’opera buona che rende gloria a Dio. Strana logica, strana morale: è la «morale» dell’odio che si oppone alla morale dell’amore. I farisei avevano fatto di Dio il nemico dell’uomo: il colmo dell’opera diabolica (cf. Gen 3; Gv 8,44).In Gesù si rivela Dio–con–noi–e–per–noi: questa è la grande novità della rivelazione. Ma gli uomini spesso rifiutano un Dio amico che li ama e li libera, e gli preferiscono un falso dio che li spadroneggi. Di fronte alla durezza di cuore dei farisei, Gesù prova indignazione e tristezza. Il Cristo manifesta contemporaneamente la collera di Dio e la sua compassione che non viene mai meno di fronte alle sue creature incapaci di aprirsi alle sue sollecitazioni.Il miracolo della guarigione dell’uomo che aveva la mano secca costerà la vita a Gesù. La croce si profila ormai chiaramente. È il prezzo del dono che ci fa guarendo la nostra mano incapace di accogliere e di donare. Le sue mani inchiodate scioglieranno la nostra mano rigida.Si scorge all’orizzonte l’albero dal quale penderà Gesù, il frutto della vita, verso cui possiamo e dobbiamo tendere la mano per diventare come Dio (cf. Gen 3).Questo racconto chiude una tappa del vangelo in cui Gesù ci ha rivelato chi è lui per noi in ciò che ha fatto per noi.7 Gesù intanto si ritirò presso il mare con i suoi discepoli e lo seguì molta folla dalla Galilea. 8 Dalla Giudea e da Gerusalemme e dall’Idumea e dalla Transgiordania e dalle parti di Tiro e Sidone una gran folla, sentendo ciò che faceva, si recò da lui. 9 Allora egli pregò i suoi discepoli che gli mettessero a disposizione una barca, a causa della folla, perché non lo schiacciassero. 10 Infatti ne aveva guariti molti, così che quanti avevano qualche male gli si gettavano addosso per toccarlo.11 Gli spiriti immondi, quando lo vedevano, gli si gettavano ai piedi gridando: «Tu sei il Figlio di Dio!». 12 Ma egli li sgridava severamente perché non lo manifestassero.Il rifiuto e la condanna a morte di Gesù, da parte dei farisei e degli erodiani, segna il nuovo inizio del popolo di Dio. L’efficacia evangelica è molto diversa dall’efficienza umana: trae la sua forza dall’impotenza dell’uomo e dalla potenza di Dio: «Quando sono debole, è allora che sono forte» (2Cor 12,10). Perché Dio, contrariamente all’uomo, sa trarre successo dall’insuccesso e vita dalla morte.Le località nominate sono sette, un numero che indica completezza, totalità. Tutti accorrono a Cristo per formare la sua Chiesa. Egli non ha raggiunto il successo mediante la brama di avere, di potere e di apparire, origine di ogni male, ma ha vinto tutto questo proprio con il suo insuccesso, con la povertà, con il servizio e l’umiltà di chi ama.Gesù è presentato come il centro di un ampio movimento di gente che cerca e trova in lui la possibilità di guarire. L’uomo è malato e il pellegrinaggio verso Gesù nasce da questo bisogno di salvezza.È bello vedere Gesù pressato da tanta gente. Ma perché accorrono? Per interesse o per fede? Marco ci fa capire che l’entusiasmo della folla è suscitato dall’azione guaritrice di Gesù, non dalla fede.Solo i demoni conoscono l’identità di Gesù e la proclamano. Ma la loro propaganda è controproducente; il loro intento è di far fallire la rivelazione autentica di Gesù «bruciandola» anzitempo: di qui la reazione di Gesù che impone loro di tacere.La trappola tesa a Gesù dai demoni sta nel fatto che satana vuole anticipare la manifestazione della gloria di Gesù prima della sua morte in croce, perché solo lì Gesù si rivela veramente Figlio di Dio (cf. Mc 15,39), che dona agli uomini la salvezza totale e definitiva, cioè la redenzione della loro esistenza nella comunione con Dio. E’ la tentazione che satana gli ripresenterà nuovamente per mezzo di Pietro (Mc 8,32–33).La fede non è solo sapere chi è Gesù. Anche i demoni lo sanno, meglio e prima di noi. Come scrive s. Giacomo: «Credono, ma tremano» (2,19). Credere è prima di tutto fare esperienza di Gesù che mi ha amato e ha dato se stesso per me (cf. Gal 2,20). Una fede ideologica, che tutto conosce, ma non fa esperienza dell’amore di Dio, è un anticipo dell’inferno. E’ la pena del dannato che conosce il bene, ma non lo possiede.Il Signore non desidera la pubblicità da parte di nessuno (tanto meno da parte dei demoni!). Raggiunge tutti solo attraverso la debolezza di chi, conoscendolo veramente, lo annuncia come amore crocifisso, povero, umiliato e umile. La propaganda va esattamente nella direzione opposta e si serve proprio di quei mezzi che il Signore ha denunciato e rifiutato come tentazioni.13 Salì poi sul monte, chiamò a sé quelli che egli volle ed essi andarono da lui. 14 Ne costituì Dodici che stessero con lui 15 e anche per mandarli a predicare e perché avessero il potere di scacciare i demòni.16 Costituì dunque i Dodici: Simone, al quale impose il nome di Pietro; 17 poi Giacomo di Zebedèo e Giovanni fratello di Giacomo, ai quali diede il nome di Boanèrghes, cioè figli del tuono; 18 e Andrea, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Tommaso, Giacomo di Alfeo, Taddeo, Simone il Cananèo 19 e Giuda Iscariota, quello che poi lo tradì.È inutile cercare di localizzare questo monte perché «la montagna», in Marco, indica soprattutto il luogo delle rivelazioni divine, mentre il mare, come vedremo (4,35–39; 5,46–52), appare come il luogo della prova e delle dure realtà umane.Il numero dodici ha un chiaro valore simbolico: deve, evidentemente, essere messo in relazione con quello delle dodici tribù d’Israele presenti al Sinai per formare la comunità dell’Alleanza (Es 24,4; Dt 1,23; Gs 3,12; 4,2ss).La funzione dei Dodici viene subito precisata: «Ne costituì Dodici che stessero con lui e anche per mandarli a predicare e perché avessero il potere di scacciare i demoni» (vv. 14–15). Marco ha descritto Gesù come colui che predica e scaccia i demoni (1,39); ora afferma la stessa cosa dei suoi discepoli. La missione di Gesù continua e si rende visibile nel mondo attraverso i suoi inviati.Gesù sceglie e chiama. È il cerchio di Gesù che si allarga: partecipa ad altre persone la sua forza e la sua autorità. In Gesù il regno di Dio si è fatto vicino agli uomini; ora si dilata nei Dodici e attraverso di loro si estenderà al mondo intero.Questi uomini sono presi dalla gente comune, con pregi e difetti, e sarebbe ingenuo e sbagliato idealizzare il gruppo che ne è uscito: non è una comunità di puri né un gruppo di educande. Il seguito del vangelo ce ne darà puntuale conferma.Il cristianesimo non è un’ideologia: è una compagnia reale con Gesù, in un rapporto da persona a persona, che ci coinvolge totalmente. E da questo coinvolgimento con Gesù, veniamo spinti verso tutti gli uomini fino agli estremi confini della terra: «L’amore di Cristo ci spinge… (2Cor 5,14).Andare verso tutti gli uomini e stare con lui sembrano due cose contraddittorie. Ma, in realtà, il Cristo va insieme con i cristiani: «Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore operava con loro e confermava la parola con i prodigi che l’accompagnavano» (Mc 16,20).Non c’è alternativa tra contemplazione e azione. La nostra missione nasce dall’essere in Cristo, e la nostra prima occupazione è di restare uniti con lui come il tralcio alla vite (cf. Gv 15,1ss), fino ad essere contemplativi nell’azione.20 Entrò in una casa e si radunò di nuovo attorno a lui molta folla, al punto che non potevano neppure prendere cibo. 21 Allora i suoi, sentito questo, uscirono per andare a prenderlo; poiché dicevano: «È fuori di sé».A questo punto il vangelo comincia a presentare le prime risposte degli uomini al problema fondamentale: «Chi è Gesù?».La prima è dei «suoi», cioè dei parenti di Gesù, i quali dicevano: «E’ fuori di sé» (v. 21). Lo considerano dunque un pazzo, uno scriteriato, uno che getta il discredito su tutta la famiglia. La cosa migliore è prenderlo e rinchiuderlo.Questo testo ci rivela la maniera di pensare degli uomini, ai quali manca qualsiasi comprensione per le assolute esigenze di Dio. Essi non comprendono che un uomo possa essere tutto preso dagli interessi di Dio e dedicarsi completamente al suo servizio. Una tale cecità è sempre un pericolo per parenti e familiari di uomini che Dio chiama a un particolare servizio, ed è un ammonimento a guardarsi da pensieri di ordine semplicemente naturale e da preoccupazioni borghesi riguardo al buon nome, alla salute e agli affari. Gesù sta al di fuori di queste categorie e fa entrare anche i suoi discepoli al servizio delle esigenze totalitarie di Dio.Più avanti i suoi parenti torneranno alla carica (Mc 3,31–35) e il ritorno di Gesù nella sua patria renderà palese lo stesso rifiuto a credergli (Mc 6,1–8).Secondo i «suoi» (vedi Pietro in Mc 8,31ss), Gesù dovrebbe avere un po’ più di buon senso: Dovrebbe investire meglio le sue qualità per avere di più, potere di più e valere di più.. Secondo i «suoi», questi sono i mezzi utili per il trionfo del bene, per togliere il potere ai cattivi, per orientare tutto «a fin di bene» e, soprattutto, per la gloria di Dio.Gesù invece simpatizza con i cattivi e trascura i propri interessi: si può prevedere che con la sua bontà e sprovvedutezza, e facendo l’avvocato degli emarginati e di quelli che non contano (l’avvocato delle cause perse!), andrà a finir male.È fuori di sé, è pazzo! Per noi che abbiamo barattato l’intelligenza con la furbizia, saggio è colui che cerca l’utile e il vantaggio proprio, e non il bene e la verità.. Questo buon senso umano ha fuorviato i parenti di Gesù, fuorvierà Giuda e tanti altri dopo di lui.Gesù fu, è e sarà rifiutato proprio perché povero, umiliato e umile. Ma questa sua pazzia è la sapienza di Dio. «Mentre i giudei chiedono miracoli e i greci cercano la sapienza, noi predichiamo Cristo crocifisso, scandalo per i giudei, stoltezza per i pagani; ma per coloro che sono chiamati, sia giudei che greci, predichiamo Cristo potenza di Dio e sapienza di Dio. Perché ciò che è stoltezza di Dio è più sapiente degli uomini, e ciò che è debolezza di Dio è più forte degli uomini» (1Cor 1,22–25).«Essere con Gesù» richiede il cambiamento dal pensiero dell’uomo al pensiero di Dio. Senza questa conversione radicale della mente e del cuore si rimane fuori della sua famiglia, anche se ci sembra di volergli bene.Senza una conversione radicale, in realtà, non si ama lui, ma se stessi e i propri progetti proiettati in lui e nei suoi progetti, pronti a seguirlo quando lui ci segue e a catturarlo quando lui non ci segue. Questo non è amore, ma egoismo, è il tentativo di assimilare lui a noi invece di assimilare noi a lui.Anche nella preghiera, c’è la tentazione costante di chiedere a Dio di fare la nostra volontà invece della sua. E, naturalmente, sempre a fin di bene!22 Ma gli scribi, che erano discesi da Gerusalemme, dicevano: «Costui è posseduto da Beelzebùl e scaccia i demòni per mezzo del principe dei demòni». 23 Ma egli, chiamatili, diceva loro in parabole: «Come può satana scacciare satana? 24 Se un regno è diviso in se stesso, quel regno non può reggersi; 25 se una casa è divisa in se stessa, quella casa non può reggersi. 26 Alla stessa maniera, se satana si ribella contro se stesso ed è diviso, non può resistere, ma sta per finire. 27 Nessuno può entrare nella casa di un uomo forte e rapire le sue cose se prima non avrà legato l’uomo forte; allora ne saccheggerà la casa. 28 In verità vi dico: tutti i peccati saranno perdonati ai figli degli uomini e anche tutte le bestemmie che diranno; 29 ma chi avrà bestemmiato contro lo Spirito santo, non avrà perdono in eterno: sarà reo di colpa eterna». 30 Poiché dicevano: «È posseduto da uno spirito immondo».La seconda risposta degli uomini al problema fondamentale: «Chi è Gesù?» è data dagli scribi venuti da Gerusalemme. Sono persone importanti, hanno una posizione ufficiale nel mondo religioso giudaico, sono esperti della legge di Dio che hanno studiato a Gerusalemme, il centro culturale d’Israele. Essi tengono una specie di consulto, al termine del quale esprimono la loro diagnosi: «È posseduto da Beelzebùl, principe dei demoni» (v. 22), «è posseduto da uno spirito immondo» (v. 30).Queste due risposte, che definiscono Gesù pazzo e indemoniato, hanno una cosa in comune: definiscono Gesù indegno di essere preso in considerazione. Lui che guarisce i malati è giudicato malato; lui che scaccia i demoni è giudicato posseduto dal demonio.C’è nell’uomo qualcosa di demoniaco quando si ripiega su se stesso e rifiuta la luce dello Spirito Santo. L’accusa degli scribi non è solamente una calunnia, ma anche una bestemmia. Attribuire a satana la potenza di cui Gesù dispone, significa opporsi all’azione dello Spirito Santo e rendere inefficace la misericordia divina.L’unico caso in cui il perdono può essere inefficace è il rifiuto di lasciarsi perdonare: è questo il peccato contro lo Spirito Santo. Peccare contro lo Spirito santo significa rifiutare di credere che in Gesù agisce Dio salvatore. Questo rifiuto è il peccato più grande che l’uomo possa commettere. Finché l’uomo rimane in simile situazione di rifiuto, la salvezza è impossibile. «In nessun altro c’è salvezza; non vi è infatti altro nome dato agli uomini sotto il cielo nel quale è stabilito che possiamo essere salvati» (At 4,12).Solo la fede in Gesù può eliminare la tragedia della situazione umana, altrimenti l’uomo «non avrà il perdono in eterno: sarà reo di colpa eterna» (v. 29).Dio perdona sempre tutti. Il peccato contro lo Spirito Santo è rifiutare il perdono che Dio ci offre. Se questo nostro rifiuto rimane per sempre, il peccato e la conseguente dannazione, dureranno per sempre.Non è Dio che non perdona; è l’uomo che non vuole essere perdonato. Gesù denuncia questo peccato «eterno» non per condannare gli scribi, ma per chiamarli a conversione, mostrando loro la gravità di quanto stanno facendo. Ogni «minaccia» di Dio nella Bibbia è di questo tipo, e raggiunge il suo effetto quando non si avvera perché ha provocato la conversione.31 Giunsero sua madre e i suoi fratelli e, stando fuori, lo mandarono a chiamare. 32 Tutto attorno era seduta la folla e gli dissero: «Ecco tua madre, i tuoi fratelli e le tue sorelle sono fuori e ti cercano». 33 Ma egli rispose loro: «Chi è mia madre e chi sono i miei fratelli?». 34 Girando lo sguardo su quelli che gli stavano seduti attorno, disse: «Ecco mia madre e i miei fratelli! 35 Chi compie la volontà di Dio, costui è mio fratello, sorella e madre».Gesù si era allontanato dalla madre e dai parenti per seguire il richiamo di Dio, e ora mostra di essersi separato da essi anche interiormente non per freddezza d’animo o per disprezzo dei legami familiari, ma per appartenere completamente a Dio: egli ha compiuto personalmente quanto esige anche dai suoi discepoli: «Chi ama il padre o la madre più di me non è degno di me; chi ama il figlio o la figlia più di me non è degno di me» (Mt 10,37).Ma la sua risposta non ha solo questo significato; essa riguarda soprattutto la consapevolezza che la comunità cristiana deve avere di sé. Gesù si è scelto un’altra famiglia al posto di quella naturale: una famiglia spirituale.Il problema proposto dal brano è il discernimento se siamo con lui o contro di lui; se siamo dentro o fuori dalla comunità di Gesù. La vera famiglia di Gesù è composta da coloro che compiono la volontà di Dio: «Chi compie la volontà di Dio, costui è mio fratello, sorella e madre» (v. 35).Il compimento della volontà del Padre che è nei cieli sarà l’elemento discriminante anche nel giorno del giudizio finale: «Non chiunque mi dice: Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio, che è nei cieli» (Mt 7,21).
CAPITOLO 04
1 Di nuovo si mise a insegnare lungo il mare. E si riunì attorno a lui una folla enorme, tanto che egli salì su una barca e là restò seduto, stando in mare, mentre la folla era a terra lungo la riva. 2 Insegnava loro molte cose in parabole e diceva loro nel suo insegnamento: 3 «Ascoltate. Ecco, uscì il seminatore a seminare. 4 Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada e vennero gli uccelli e la divorarono. 5 Un’altra cadde fra i sassi, dove non c’era molta terra, e subito spuntò perché non c’era un terreno profondo; 6 ma quando si levò il sole, restò bruciata e, non avendo radice, si seccò. 7 Un’altra cadde tra le spine; le spine crebbero, la soffocarono e non diede frutto. 8 E un’altra cadde sulla terra buona, diede frutto che venne su e crebbe, e rese ora il trenta, ora il sessanta e ora il cento per uno». 9 E diceva: «Chi ha orecchi per intendere intenda!».10 Quando poi fu solo, i suoi insieme ai Dodici lo interrogavano sulle parabole. Ed egli disse loro: 11 «A voi è stato confidato il mistero del regno di Dio; a quelli di fuori invece tutto viene esposto in parabole, 12 perché:guardino, ma non vedano, ascoltino, ma non intendano,perché non si convertano e venga loro perdonato».13 Continuò dicendo loro: «Se non comprendete questa parabola, come potrete capire tutte le altre parabole? 14 Il seminatore semina la parola. 15 Quelli lungo la strada sono coloro nei quali viene seminata la parola; ma quando l’ascoltano, subito viene satana, e porta via la parola seminata in loro. 16 Similmente quelli che ricevono il seme sulle pietre sono coloro che, quando ascoltano la parola, subito l’accolgono con gioia, 17 ma non hanno radice in se stessi, sono incostanti e quindi, al sopraggiungere di qualche tribolazione o persecuzione a causa della parola, subito si abbattono. 18 Altri sono quelli che ricevono il seme tra le spine: sono coloro che hanno ascoltato la parola, 19 ma sopraggiungono le preoccupazioni del mondo e l’inganno della ricchezza e tutte le altre bramosie, soffocano la parola e questa rimane senza frutto. 20 Quelli poi che ricevono il seme su un terreno buono, sono coloro che ascoltano la parola, l’accolgono e portano frutto nella misura chi del trenta, chi del sessanta, chi del cento per uno».Fino a questo punto l’insegnamento di Gesù si era reso visibile nel suo agire: insegnava con i fatti. Ora esprime la sua dottrina in parabole, cioè con degli esempi, con dei paragoni illustrativi.Le parabole evangeliche non nascono semplicemente da un’esigenza didattica preoccupata della chiarezza e della vivacità. Nascono da un’esigenza teologica, dal fatto che non possiamo parlare direttamente del regno di Dio che è oltre le nostre esperienze, ma solo in parabole, indirettamente, mediante paragoni presi dalla vita quotidiana.La parabola del seminatore inizia e termina con il comandamento dell’ascolto: «Ascoltate!», «Chi ha orecchi per ascoltare, ascolti».La parola di Gesù è il seme immortale che ci rigenera: «Siete stati rigenerati non da un seme corruttibile, ma immortale, cioè dalla parola di Dio viva ed eterna» (1Pt 1,23). Il regno di Dio è paragonato costantemente al seme, la cui forza vitale è attiva proprio nella morte. La morte non distrugge il seme, ma anzi è la condizione perché germini e si manifesti in tutta la sua potenza, a differenza di tutte le altre cose che marciscono e finiscono.L’oggetto dell’insegnamento di Gesù è la sua stessa vita, spiegata con similitudini. Queste parabole, mentre illustrano la storia di Gesù, ci danno anche il criterio di discernimento per essere tra i suoi e appartenere al suo regno. Non dobbiamo cercare il successo (vv. 3–9), la fama e la rilevanza (vv. 21–25), il protagonismo e la grandezza (vv. 26–32).L’opera di Dio passa attraverso le difficoltà, il fallimento, il nascondimento, l’irrilevanza, l’attesa paziente e la piccolezza. Queste sono le qualità del seme da cui nasce l’albero del Regno. Esso è come un chicco, che porta frutto abbondante non «nonostante» la morte, ma proprio perché muore (cf. Gv 12,24).Sono parabole di speranza contro ogni speranza, di una fede che sa che la parola di Dio è un seme che produce sempre il frutto e l’effetto per cui è mandata (cf. Is 55,11). Le resistenze che incontra, rappresentate dai vari tipi di terreno, fanno parte del progetto di Dio.Gesù è il seminatore, il seme e il raccolto, perché chi l’ascolta si identifica con lui.Il risultato di questa semina sembra disastroso. Sembra che la parola di Gesù non riesca a entrare nel cuore dell’uomo; e, se entra, non mette radici; e, se mette radici, è soffocata. Eppure lui va avanti nella sua semina. «Egli disse loro: Andiamocene altrove per i villaggi vicini, perché io predichi anche là; per questo infatti sono venuto» (Mc 1,38).Noi oggi vediamo quanto Gesù abbia avuto ragione. Il suo seme è germinato in tutto il mondo.Gesù è la parola di Dio seminata in noi. Il mistero del regno di Dio nella storia è quello del seme, che rivive in noi la sua stessa vicenda di allora.21 Diceva loro: «Si porta forse la lampada per metterla sotto il moggio o sotto il letto? O piuttosto per metterla sul lucerniere? 22 Non c’è nulla infatti di nascosto che non debba essere manifestato e nulla di segreto che non debba essere messo in luce. 23 Se uno ha orecchi per intendere, intenda!».24 Diceva loro: «Fate attenzione a quello che udite: Con la stessa misura con la quale misurate, sarete misurati anche voi; anzi vi sarà dato di più. 25 Poiché a chi ha, sarà dato e a chi non ha, sarà tolto anche quello che ha».La lampada è la parola di Dio: «Lampada per i miei passi è la tua parola, luce sul mio cammino» (Sal 119,105; cf. 2Pt 1,19). La parola del vangelo è come una luce posta sul candelabro: essa illumina tutto ciò che è nascosto nel cuore dell’uomo. Nella Lettera agli Ebrei 4,12–13 si legge: «Infatti la parola di Dio è viva, efficace e più tagliente di ogni spada a doppio taglio; essa penetra fino al punto di divisione dell’anima e dello spirito, delle giunture e delle midolla, e scruta i sentimenti e i pensieri del cuore. Non vi è creatura che possa nascondersi davanti a lui, ma tutto è nudo e scoperto agli occhi suoi e a lui noi dobbiamo rendere conto».È la parola che mostra chiaramente se l’uomo è simile a un buon terreno o a un terreno pieno di pietre o di spine. Essa ha la funzione di giudice: è l’espressione del giudizio di Dio. Ognuno faccia dunque attenzione al proprio modo di ascoltare, perché l’ascolto è la misura del messaggio ricevuto: ognuno infatti intende solo ciò che può o vuole intendere. L’uomo si giudica da se stesso, secondo il modo e la misura del suo ascolto.La frase finale: «A chi ha, sarà dato e a chi non ha, sarà tolto anche quello che ha» si chiarisce alla luce del contesto: ciò che si tratta di avere sono, anzitutto, delle orecchie in grado di ascoltare. Ritroviamo qui il tema sapienziale della capacità di accoglienza della conoscenza; questa aumenta a misura della disponibilità. La sapienza divina è principio di comprensione sempre più profonda per chi si lascia ammaestrare da lei: «Ascolti il saggio e aumenterà il sapere» (Pr 1,5), ma diventa progressivamente impenetrabile per chi la rifiuta: «Il beffardo ricerca la sapienza, ma invano» (Pr 14,6).Come nella parabola del seminatore si sottolinea la necessità di non soffocare il seme del regno di Dio, annunciato dalla parola di Gesù, così in questo brano siamo invitati a non chiudere gli occhi dinanzi alla luce che si manifesta e che, se accolta, diventerà sempre più sfolgorante.26 Diceva: «Il regno di Dio è come un uomo che getta il seme nella terra; 27 dorma o vegli, di notte o di giorno, il seme germoglia e cresce; come, egli stesso non lo sa. 28 Poiché la terra produce spontaneamente, prima lo stelo, poi la spiga, poi il chicco pieno nella spiga. 29 Quando il frutto è pronto, subito si mette mano alla falce, perché è venuta la mietitura».30 Diceva: «A che cosa possiamo paragonare il regno di Dio o con quale parabola possiamo descriverlo? 31 Esso è come un granellino di senapa che, quando viene seminato per terra, è il più piccolo di tutti semi che sono sulla terra; 32 ma appena seminato cresce e diviene più grande di tutti gli ortaggi e fa rami tanto grandi che gli uccelli del cielo possono ripararsi alla sua ombra».33 Con molte parabole di questo genere annunziava loro la parola secondo quello che potevano intendere. 34 Senza parabole non parlava loro; ma in privato, ai suoi discepoli, spiegava ogni cosa.L’ottimismo di Gesù è evidente. Egli ha fiducia nel suo lavoro, crede nella forza delle idee e sa che quelle racchiuse nella parola di Dio hanno una potenza divina che supera tutte le altre: la parola uscita dalla bocca di Dio non tornerà senza effetto, senza aver operato ciò che egli desidera e senza aver compiuto ciò per cui egli l’ha mandata (cf. Is 55,11).Perché la Parola produca frutto basta seminarla, annunciando il vangelo: il resto viene da sé. Forse che il contadino, dopo la semina, si ferma nel campo per ricordare al seme che deve germogliare? Il seme non ha bisogno di lui, è autosufficiente: ha in sé tutto il necessario per diventare spiga matura. Così il regno di Dio annunciato dalla Parola.Compito del cristiano è l’evangelizzazione: il resto non dipende da lui, ma da chi accoglie la parola di Dio. Riferendosi alla comunità cristiana di Corinto, Paolo ha scritto: «Io ho piantato, Apollo ha irrigato, ma è Dio che ha fatto crescere» (1Cor 3,6).Non è l’azione dell’uomo che produce il Regno, ma la potenza stessa di Dio, nascosta nel seme della sua parola. Tante nostre ansie per il bene, non solo non sono utili, ma dannose. Tutte le nostre inquietudini non vengono da Dio, che ci ha comandato di non affannarci (cf. Mt 6,25–34), ma dalla nostra mancanza di fede.L’efficacia del vangelo è l’opposto dell’efficienza mondana. Il regno di Dio è di Dio. Quindi l’uomo non può né farlo né impedirlo. Può solo ritardarlo un po’, come una diga sul fiume.Gesù ha seminato la Parola, ed è lui stesso il seme di Dio gettato nel campo della storia. Ha bisogno solo di trovare una terra preparata che lo accoglie e una pazienza fiduciosa che sa attendere.Gesù ha proclamato: «Il regno di Dio è vicino» (Mc 1,5), ma apparentemente nulla è cambiato nel mondo: la gente continua a vivere, a soffrire e a morire. Di nuovo c’è semplicemente un uomo che predica in un luogo poco importante dell’impero e i suoi ascoltatori sono malati, analfabeti, squattrinati: quelli che non contano niente. È tutto qui il regno di Dio? Sì, è tutto qui! Grande come un granellino di senapa. Proprio perché Dio è grande non ha paura di farsi piccolo; proprio perché il suo regno è potente, può fare a meno di ogni apparato esterno grandioso: non ha bisogno di terrorizzare per affermarsi.Il mondo oppone al regno di Dio le sue terribili seduzioni: il denaro, il piacere, e le sue forze che impauriscono: la persecuzione, le tribolazioni, la morte violenta… Le parabole presentano una visione severa del Regno: esso viene attraverso lotte e opposizioni. Eppure esso prevarrà certamente contro ogni ostacolo.La venuta del regno di Dio non è tanto ostacolata dalla malvagità dei cattivi, ma dalla stupidità dei buoni. La nostra inesperienza spirituale è la più grande alleata del nemico. Il diavolo ci dà volentieri tanto zelo quando manchiamo di esperienza evangelica, perché usiamo per la venuta del regno di Dio quei mezzi che il Signore scartò come tentazioni: il successo, la pubblicità, l’efficienza e la grandezza.Gesù è la grandezza di Dio che per noi si è fatto piccolo fino alla morte di croce. Proprio così è diventato il grande albero dove tutti possono trovare accoglienza. Il discepolo deve rispecchiare il suo spirito di piccolezza e di servizio. Questo vince il male del mondo, che è desiderio di grandezza e di potere.Chi ama si fa piccolo per lasciare posto all’amato; il suo io scompare per diventare pura accoglienza dell’altro. Per questo la piccolezza è il segno della grandezza di Dio (cf. Lc 2,12).«Annunciava loro la parola secondo quello che potevano intendere» (v. 33). È un tratto importante della pedagogia di Gesù: progressività, adattamento alle persone e ai loro ritmi di crescita.Anche noi, a imitazione di Gesù, dobbiamo incarnarci nella situazione di chi non capisce o non riesce a convertirsi rapidamente e a reggersi costantemente in piedi, ricordandoci che un tempo eravamo anche noi nelle medesime condizioni e forse lo siamo ancora.L’evangelizzatore deve agire come Gesù. Egli vuole la conversione di tutti: il suo atteggiamento è dettato dalla misericordia e dalla compassione. Egli si rivolge a tutti, buoni e cattivi, disposti e indisposti (ricordiamo i quattro tipi di terreno della parabola!) perché vuole che tutti siano salvati.35 In quel medesimo giorno, verso sera, disse loro: «Passiamo all’altra riva». 36 E lasciata la folla, lo presero con sé, così com’era, nella barca. C’erano anche altre barche con lui. 37 Nel frattempo si sollevò una gran tempesta di vento e gettava le onde nella barca, tanto che ormai era piena. 38 Egli se ne stava a poppa, sul cuscino, e dormiva. Allora lo svegliarono e gli dissero: «Maestro, non t’importa che moriamo?». 39 Destatosi, sgridò il vento e disse al mare: «Taci, calmati!». Il vento cessò e vi fu grande bonaccia. 40 Poi disse loro: «Perché siete così paurosi? Non avete ancora fede?». 41 E furono presi da grande timore e si dicevano l’un l’altro: «Chi è dunque costui, al quale anche il vento e il mare obbediscono?».Il linguaggio vivo di questo racconto è come la sequenza di un film che coinvolge il lettore nell’evento. Pare incredibile che un passeggero se ne stia dormendo tranquillo durante una simile burrasca.Il racconto richiama il Libro di Giona: «Il Signore scatenò sul mare un forte vento e ne venne in mare una tempesta tale che la nave stava per sfasciarsi. I marinai impauriti invocavano ciascuno il proprio dio e gettavano in mare quanto avevano sulla nave per alleggerirla. Intanto Giona, sceso nel luogo più riposto della nave, si era coricato e dormiva profondamente. Gli si avvicinò il capo dell’equipaggio e gli disse: «Che cos’hai così addormentato? Alzati, invoca il tuo Dio! Forse Dio si darà pensiero di noi e non periremo» (Gn 1,4–6).Giona si dichiarò peccatore e si fece gettare in mare, e il mare placò la sua furia. Gesù è il Santo di Dio che domina il mare con la propria potenza divina.Per comprendere la potenza dimostrata da Gesù in questa occasione, bisogna intenderla come un esorcismo della burrasca, e le parole con cui egli comanda al mare come una espulsione di demoni. Il potere di Gesù sul vento e sul mare dimostra che egli domina le potenze demoniache.Gesù sgrida il vento come faceva con gli spiriti immondi (cf. Mc 1,25; 3,12). Con la stessa ingiunzione fa tacere il mare che contiene una moltitudine di demoni che ostacolano con tutte le loro energie l’andata di Gesù verso i territori pagani dove essi hanno il loro quartier generale.L’uomo biblico considera il mare come il luogo dove si raccolgono le forze del male che solo Dio può dominare. I salmi, in particolare, contengono allusioni alla lotta vittoriosa di Dio contro il mostro marino del caos primitivo (cf. Sal 89,10–11; 93,3–4; 104,25–26), contro le acque del mare dei Giunchi o del fiume Giordano (cf. Sal 74,14–15; 77,17–21; 78,13) o, più semplicemente, contro i flutti che si accaniscono contro i naviganti (cf. Sal 107,23–30). L’azione di Gesù, come quella di Dio, è istantanea ed efficace.I discepoli hanno paura di andare a fondo con Cristo, non hanno fede in lui. Il battesimo è andare a fondo con Cristo: essere associati a lui nella sua morte e risurrezione. Questo racconto è un’esercitazione battesimale per vedere se la Parola ha prodotto il suo frutto, cioè la fiducia di abbandonare la nostra vita nelle mani di Gesù che è morto e risorto.Lo stesso giorno delle parabole, i discepoli falliscono l’esame. Ma l’esperimento non è inutile: li sveglia e suscita in loro la domanda: «Chi è dunque costui, al quale anche il vento e il mare obbediscono?». E questa è la domanda fondamentale del vangelo.Il discepolo è colui che, dopo aver ascoltato la Parola, si affida a Gesù che dorme, e sulla parola del Signore, accetta di andare a fondo (morire con Cristo) nella speranza–certezza di emergere con lui a vita nuova (risorgere con Cristo). «Certa è questa parola: se moriamo con lui, vivremo anche con lui» (2Tim 2,11). L’alternativa a questa proposta di Cristo non è stare a galla, ma andare a fondo senza di lui.La fede consiste nel non temere di andare a fondo con Gesù e accettare di dormire con lui che dorme per stare con noi. È affidare la nostra vita, la nostra morte e le nostre paure al Signore della vita, che si prende cura di noi proprio con il suo sonno (la sua morte che opera la salvezza).Anche il particolare che descrive Gesù che dorme sulla poppa della barca non è secondario. La poppa è la parte della barca che va a fondo per prima. Gesù ci precede nel naufragio della morte e nel risveglio della risurrezione, per esorcizzare le nostre paure e suscitare in noi una fede fiduciosa e fattiva.
CAPITOLO 05
1 Intanto giunsero all’altra riva del mare, nella regione dei Gerasèni. 2 Come scese dalla barca, gli venne incontro dai sepolcri un uomo posseduto da uno spirito immondo. 3 Egli aveva la sua dimora nei sepolcri e nessuno più riusciva a tenerlo legato neanche con catene, 4 perché più volte era stato legato con ceppi e catene, ma aveva sempre spezzato le catene e infranto i ceppi, e nessuno più riusciva a domarlo. 5 Continuamente, notte e giorno, tra i sepolcri e sui monti, gridava e si percuoteva con pietre. 6 Visto Gesù da lontano, accorse, gli si gettò ai piedi, 7 e urlando a gran voce disse: «Che hai tu in comune con me, Gesù, Figlio del Dio altissimo? Ti scongiuro, in nome di Dio, non tormentarmi!». 8 Gli diceva infatti: «Esci, spirito immondo, da quest’uomo!». 9 E gli domandò: «Come ti chiami?». «Mi chiamo Legione, gli rispose, perché siamo in molti». 10 E prese a scongiurarlo con insistenza perché non lo cacciasse fuori da quella regione.11 Ora c’era là, sul monte, un numeroso branco di porci al pascolo. 12 E gli spiriti lo scongiurarono: «Mandaci da quei porci, perché entriamo in essi». 13 Glielo permise. E gli spiriti immondi uscirono ed entrarono nei porci e il branco si precipitò dal burrone nel mare; erano circa duemila e affogarono uno dopo l’altro nel mare. 14 I mandriani allora fuggirono, portarono la notizia in città e nella campagna e la gente si mosse a vedere che cosa fosse accaduto.15 Giunti che furono da Gesù, videro l’indemoniato seduto, vestito e sano di mente, lui che era stato posseduto dalla Legione, ed ebbero paura. 16 Quelli che avevano visto tutto, spiegarono loro che cosa era accaduto all’indemoniato e il fatto dei porci. 17 Ed essi si misero a pregarlo di andarsene dal loro territorio. 18 Mentre risaliva nella barca, colui che era stato indemoniato lo pregava di permettergli di stare con lui. 19 Non glielo permise, ma gli disse: «Va’ nella tua casa, dai tuoi, annunzia loro ciò che il Signore ti ha fatto e la misericordia che ti ha usato». 20 Egli se ne andò e si mise a proclamare per la Decàpoli ciò che Gesù gli aveva fatto, e tutti ne erano meravigliati.Abbiamo già conosciuto la potenza di Gesù contro i demoni (cf. Mc 1,21–28; 1,34; 3,11–12). Ma qui c’è qualcosa di nuovo: siamo nel territorio della Decapoli (che significa dieci città), in terra pagana, dove il potere di satana ha maggiore solidità.Segno concreto della terra pagana è quel numeroso branco di porci al pascolo sul monte (luogo riservato al culto e alla preghiera). Il porco è animale immondo, aborrito dagli ebrei, e che può trovarsi solo in una terra immonda e pagana.Nell’indemoniato geraseno prevale un istinto di morte: odia la vita degli altri e danneggia la propria, vive nei sepolcri… Il demonio che tiene schiavo quest’uomo si chiama legione: una coalizione di demoni. Combattuti e vinti in terra d’Israele, essi avevano ripiegato in terra pagana. Nella tempesta sul mare (Mc 4,35–41) avevano tentato di fermare l’avanzata vittoriosa del Cristo. Gesù, superata la linea di sbarramento, attacca l’impero di satana al cuore, alla sede dello stato maggiore.Questo indemoniato viene considerato come il rappresentante–tipo del paganesimo, e ciò alla luce di Isaia 65,1–4: «Mi feci ricercare da chi non mi interrogava, mi feci trovare da chi non mi cercava. Dissi: Eccomi, a gente che non invocava il mio nome. Ho teso la mano ogni giorno a un popolo ribelle; essi andavano per una strada non buona, seguendo i loro capricci, un popolo che mi provocava sempre, con sfacciataggine. Essi sacrificavano nei giardini, offrivano incenso sui mattoni, abitavano nei sepolcri, passavano la notte in nascondigli, mangiavano carne suina e cibi immondi nei loro piatti».Questo pagano ha un nome. In pieno testo greco, risponde con una parola latina: legione. Ricordiamo che la legione romana era formata da seimila uomini. Questa parola evoca la guerra, la presenza e la dominazione romana, personificata da quei «porci» di legionari (il verro era uno dei simboli della potenza imperiale raffigurato sulle insegne dell’esercito romano). È la demonizzazione dell’esercito romano.Per Marco che scrive il suo vangelo probabilmente a Roma, capitale dell’impero di satana, in piena persecuzione di Nerone, questo brano potrebbe voler dire ai cristiani: Cristo butterà a mare questa legione di porci indemoniati (i persecutori) e libererà la terra dal potere oppressivo dell’impero romano, che è una manifestazione del potere di satana. A conferma di questa visione della storia si legga Ap 13–20.Il brano di porci che precipita in mare è certamente una scena sconvolgente per l’»uomo economico» di tutti i tempi. Il Signore sta liberando la terra dal male e dal maligno, e questa liberazione è motivo di gioia, ma questa gioia ha un prezzo salato: la perdita di duemila porci. E i geraseni non se la sentono di pagare prezzi così alti.Sarà anche un grande liberatore questo Gesù, ma presenta delle parcelle troppo esose. Meglio allora sopportare rassegnati la schiavitù di satana e godere indisturbati la propria ricchezza e le proprie «porcherie». E la loro stessa preghiera suona assurda e sconcertante: «Si misero a pregarlo di andarsene dal loro territorio» (v. 17).Gli uomini parlano tanto di libertà e di liberazione, ma la rifiutano appena si accorgono che c’è un prezzo da pagare.Al desiderio dell’indemoniato guarito di stare con Gesù, il Signore risponde inviandolo in missione. Egli è diventato apostolo perché è in grado di raccontare ciò che il Signore gli ha fatto. Il vangelo è la buona notizia di quanto Gesù ha fatto per noi. L’evangelizzazione non è tanto un’esposizione di dottrina o di idee, ma un racconto di fatti, una narrazione di quanto il Signore ha operato per noi.Come Gesù iniziò a proclamare il vangelo nella Galilea (Mc 1,14), così questo indemoniato guarito lo proclama nella Decapoli. È l’inizio della missione ai pagani.21 Essendo passato di nuovo Gesù all’altra riva, gli si radunò attorno molta folla, ed egli stava lungo il mare. 22 Si recò da lui uno dei capi della sinagoga, di nome Giàiro, il quale, vedutolo, gli si gettò ai piedi 23 e lo pregava con insistenza: «La mia figlioletta è agli estremi; vieni a imporle le mani perché sia guarita e viva». 24 Gesù andò con lui. Molta folla lo seguiva e gli si stringeva intorno.25 Or una donna, che da dodici anni era affetta da emorragia 26 e aveva molto sofferto per opera di molti medici, spendendo tutti i suoi averi senza nessun vantaggio, anzi peggiorando, 27 udito parlare di Gesù, venne tra la folla, alle sue spalle, e gli toccò il mantello. Diceva infatti: 28 «Se riuscirò anche solo a toccare il suo mantello, sarò guarita». 29 E subito le si fermò il flusso di sangue, e sentì nel suo corpo che era stata guarita da quel male.30 Ma subito Gesù, avvertita la potenza che era uscita da lui, si voltò alla folla dicendo: «Chi mi ha toccato il mantello?». 31 I discepoli gli dissero: «Tu vedi la folla che ti si stringe attorno e dici: Chi mi ha toccato?». 32 Egli intanto guardava intorno, per vedere colei che aveva fatto questo. 33 E la donna impaurita e tremante, sapendo ciò che le era accaduto, venne, gli si gettò davanti e gli disse tutta la verità. 34 Gesù rispose: «Figlia, la tua fede ti ha salvata. Va’ in pace e sii guarita dal tuo male».35 Mentre ancora parlava, dalla casa del capo della sinagoga vennero a dirgli: «Tua figlia è morta. Perché disturbi ancora il Maestro?». 36 Ma Gesù, udito quanto dicevano, disse al capo della sinagoga: «Non temere, continua solo ad aver fede!». 37 E non permise a nessuno di seguirlo fuorché a Pietro, Giacomo e Giovanni, fratello di Giacomo. 38 Giunsero alla casa del capo della sinagoga ed egli vide trambusto e gente che piangeva e urlava. 39 Entrato, disse loro: «Perché fate tanto strepito e piangete? La bambina non è morta, ma dorme». 40 Ed essi lo deridevano. Ma egli, cacciati tutti fuori, prese con sé il padre e la madre della fanciulla e quelli che erano con lui, ed entrò dove era la bambina. 41 Presa la mano della bambina, le disse: «Talità kum», che significa: «Fanciulla, io ti dico, alzati!». 42 Subito la fanciulla si alzò e si mise a camminare; aveva dodici anni. Essi furono presi da grande stupore. 43 Gesù raccomandò loro con insistenza che nessuno venisse a saperlo e ordinò di darle da mangiare.Questo accorrere di popolo è un tratto permanente nella narrativa di Marco (cf. 3,7–8; 4,1). Per primo si avvicina a lui Giairo (nome che significa Dio illumina o Dio risuscita) e lo prega di salvare la sua figlioletta.L’imposizione delle mani era un gesto usato fin dall’antichità per indicare la guarigione degli infermi, perché si pensava che servisse a comunicare al malato una forza vivificante. A questo scopo si chiamavano al letto degli infermi persone anziane o religiose (cf. Gc 5,14).La donna affetta da emorragia, nella sua fede semplice, è un esempio di come Gesù si rivolge a chi mostra in lui una fiducia infantile: egli la guarisce e la orienta verso quella fede completa alla quale è promessa la salvezza eterna. Egli le dà conforto e fiducia, assicurandole una guarigione stabile con parole che testimoniano la bontà di Dio e la sua volontà di salvezza. A coloro che lo toccano con fede, Gesù dona sempre guarigione e salvezza.La nuova scena viene introdotta dalla notizia che in questo frattempo la figlia di Giairo è morta. Gesù non ha paura della morte e non retrocede di fronte ad essa. Egli ascolta la notizia e incoraggia il padre: «Non temere, continua solo ad avere fede!» (v. 36). Anche qui si prosegue sul tema della fede: una fede genuina non si arrende nemmeno di fronte al potere della morte.Per comprendere la scena svoltasi nella casa di Giairo, è importante notare come Gesù voglia evitare di mettersi in mostra e tenere lontana una fede che si basa solo sui miracoli come tali. Egli prende tuttavia con sé un gruppetto di testimoni qualificati, ossia i tre discepoli che in seguito saranno presenti alla sua trasfigurazione (9,2) e alla sua angoscia mortale nel Getsemani (14,33–34). Dopo la risurrezione (cf. 9,9), essi potranno narrare queste cose, e allora anche la risurrezione della figlia di Giairo apparirà sotto una nuova luce.L’allontanamento delle lamentatrici e dei flautisti non ha solo il significato di permettergli di compiere il miracolo nel silenzio e nel nascondimento. Gesù sa che cosa sta per accadere; perciò i lamenti funebri sono fuori posto.Nella stessa direzione è orientata la frase enigmatica: «La bambina non è morta, ma dorme» (v. 39). La bambina era morta, ma alla luce della fede, la morte è solamente un sonno, dal quale siamo risvegliati dalla potenza di Dio.La Chiesa ha conservato l’espressione antica quando chiama i defunti coloro che «si sono addormentati» nel Signore, alimentando così continuamente la sua speranza nella futura risurrezione dei morti.Il «risveglio» della figlia di Giairo però non è ancora la risurrezione definitiva, ma un ritorno alla vita terrena e un prolungamento di essa.Questo brano ci presenta due miracoli intrecciati: la guarigione della donna affetta da emorragia e la risurrezione della figlia di Giairo. Questi due miracoli hanno in sé una somiglianza in crescendo. L’emorragia è una perdita di sangue e, quindi, una perdita di vita: «La vita di ogni essere vivente è il suo sangue» (Lv 17,14).Guarendo la donna affetta da perdita di sangue, Gesù si rivela come colui che ferma la perdita graduale della vita; con la risurrezione della figlia di Giairo, si manifesta come colui che ridona la vita totalmente perduta.La risurrezione della figlia di Giairo è il culmine di questa prima parte del vangelo. Di tutti i limiti a cui l’uomo è sottomesso, la morte è quello che ha l’aspetto pauroso della definitività. Contro la malattia si può combattere e vincere; contro le disgrazie si può sempre tentare qualcosa, ricostruirsi una vita dopo il fallimento, e si è soliti dire: «Finché c’è vita, c’è speranza!». Ma di fronte alla morte si constata: «A tutto c’è rimedio, fuorché alla morte!».E questa è proprio la convinzione che sta dietro al nostro racconto: «Tua figlia è morta. Perché disturbi ancora il Maestro?» (v. 35). In altre parole: ormai è troppo tardi; contro la morte non c’è rimedio. Di fronte alla morte, l’impotenza umana è totale.Avere fede vuol dire costruire la propria speranza su un Altro più forte della morte. Dal punto di vista umano, la vita è provvisoria e la morte è definitiva. Dal punto di vista cristiano, la morte è provvisoria (come il sonno: cf. Mc 5,39; Gv 11,11) e la vita è definitiva ed eterna.La conversione che Gesù ci ha chiesto fin dall’inizio del vangelo (cf. Mc 1,5) comprende anche, e soprattutto, questo cambiamento di ottica e di valutazione riguardo alla vita e alla morte.
CAPITOLO 06
1 Partito quindi di là, andò nella sua patria e i discepoli lo seguirono. 2 Venuto il sabato, incominciò a insegnare nella sinagoga. E molti ascoltandolo rimanevano stupiti e dicevano: «Donde gli vengono queste cose? E che sapienza è mai questa che gli è stata data? E questi prodigi compiuti dalle sue mani? 3 Non è costui il carpentiere, il figlio di Maria, il fratello di Giacomo, di Ioses, di Giuda e di Simone? E le sue sorelle non stanno qui da noi?». E si scandalizzavano di lui. 4 Ma Gesù disse loro: «Un profeta non è disprezzato che nella sua patria, tra i suoi parenti e in casa sua». 5 E non vi potè operare nessun prodigio, ma solo impose le mani a pochi ammalati e li guarì. 6 E si meravigliava della loro incredulità.La visita di Gesù nella sua patria è un avvenimento penoso che riprende il tema della mancanza di fede del popolo ebraico già sottolineata nell’insegnamento delle parabole e nella discussione su Beelzebùl.I parenti di Gesù prima (cf. Mc 3,21.31–32), e la gente di Nazaret poi, tentano di impadronirsi di lui per impedirgli di illudersi e di nuocere agli altri, ma egli non accetta di lasciarsi circoscrivere entro i legami naturali. Ormai i legami umani si definiscono in rapporto a lui e non viceversa: i «suoi» sono coloro che vivono con lui, ascoltano la sua voce e fanno la volontà del Padre.Gli abitanti del suo paese credono di conoscere Gesù meglio di chiunque altro. L’hanno visto crescere ed esercitare il suo mestiere. Incontrano ogni giorno sua madre e i membri della sua famiglia di cui conoscono nomi, vita e miracoli. Di fronte a lui si sentono turbati, imbarazzati, irritati. Rifiutano di lasciar mettere in discussione il loro piccolo mondo e la valutazione che si erano fatta sulla sua persona. Si fa fatica a cambiare parere e a ricredersi: è più facile e sbrigativo cancellare una persona dalla nostra vita che l’immagine o il giudizio che ci siamo fatto di lei. Gli abitanti di Nazaret non sanno aprirsi al Gesù reale, perché restano caparbiamente attaccati al ritratto che si erano fatto di lui.L’episodio va al di là del rifiuto di un piccolo paese della Galilea: prefigura il rifiuto dell’intero Israele (cfr Gv 1,11). Che un profeta sia rifiutato dal suo popolo non è una novità: c’è perfino un proverbio che lo dice. È un proverbio nato da una lunga esperienza che ha accompagnato tutta la storia d’Israele, che trova la sua più clamorosa dimostrazione nella storia del Figlio di Dio e che continuerà a ripetersi puntualmente nella storia successiva.Dio è dalla parte dei profeti, eppure i profeti sono sempre rifiutati; gli uomini di Dio, i giusti, sono sistematicamente tolti di mezzo, salvo poi costruire loro sepolcri e monumenti tardivi (cf. Lc 11,47–48).«E non vi poté operare nessun prodigio, ma solo impose le mani a pochi ammalati e li guarì» (v. 5). I miracoli di Gesù sono una risposta alla sincerità dell’uomo che cerca la verità; non sono il tentativo di forzare, in ogni modo, il cuore dell’uomo. Diversamente dagli uomini, Dio non usa la violenza per imporre i propri diritti. E neppure fa miracoli per permettere agli uomini di esimersi dal rischio e dalla fatica del credere.Anche a Nazaret Gesù ha cercato i malati e i poveri; essi sono il buon terreno arato dalla sofferenza e irrigato dalle lacrime: il seme della Parola viene accolto da loro e produce frutto. Nella sua città purtroppo il bilancio è deludente, ma non fallimentare.A Nazaret tutti si sono scandalizzati di Gesù. Tutti gli uomini inciampano e cadono davanti alla grandezza dell’amore di un Dio che si fa piccolo e insignificante. Tutti rifiutano un Dio la cui sapienza è la follia e l’impotenza dell’amore. Noi lo pensiamo e lo vogliamo diverso. La nostra mancanza di fede è così incredibile che il Signore stesso se ne meraviglia.In Gesù ci troviamo davanti allo scandalo di un Dio fatto carne, che sottostà alla legge della fatica umana e del bisogno, del lavoro e del cibo, della veglia e del sonno, della vita e della morte. Lo vorremmo diverso. Ci piacerebbe condividere le sue caratteristiche divine, ma non ci piace che egli condivida le nostre prerogative umane, delle quali volentieri faremmo a meno.Il cristiano e la Chiesa devono sempre misurarsi sulla carne di Gesù, venduta per trenta sicli, il prezzo di un asino o di uno schiavo.La prima eresia – è e sarà sempre la prima! – non consistette nel negare la divinità di Cristo, ma nel minimizzare e trascurare l’umanità di Gesù che nella sua debolezza e stoltezza crocifissa è la salvezza per tutti. Il cardine della salvezza è la carne crocifissa e risorta di Cristo.7 Allora chiamò i Dodici, ed incominciò a mandarli a due a due e diede loro potere sugli spiriti immondi. 8 E ordinò loro che, oltre al bastone, non prendessero nulla per il viaggio: né pane, né bisaccia, né denaro nella borsa; 9 ma, calzati solo i sandali, non indossassero due tuniche. 10 E diceva loro: «Entrati in una casa, rimanetevi fino a che ve ne andiate da quel luogo. 11 Se in qualche luogo non vi riceveranno e non vi ascolteranno, andandovene, scuotete la polvere di sotto ai vostri piedi, a testimonianza per loro». 12 E partiti, predicavano che la gente si convertisse, 13 scacciavano molti demòni, ungevano di olio molti infermi e li guarivano.I Dodici erano stati scelti da Gesù perché «stessero con lui e anche per mandarli a predicare e perché avessero il potere di scacciare i demoni» (Mc 3,14–15). Nei capitoli precedenti li abbiamo visti stare con lui, ascoltare e imparare, ora Marco ci mostra la seconda dimensione del discepolo, quella missionaria. Per descrivere la missione degli apostoli, Marco usa le medesime parole con cui ha descritto la missione di Gesù: predicavano la conversione, guarivano i malati e scacciavano i demoni.L’invio dei discepoli avviene «a due a due», sia in riferimento alla duplice testimonianza (Dt 17,6; 19,15; Nm 35,40), sia secondo il consiglio del saggio Qoelet (4,9–12) adottato poi anche dalla comunità cristiana di Gerusalemme (At 13, 2).Gli ordini che Gesù dà ai suoi inviati riguardano, anzitutto, la povertà e la rinuncia: senza alcun aiuto umano, i discepoli hanno come appoggio solo la fede in colui che li manda.Queste parole condannano il trionfalismo e la ricchezza e impongono la povertà e la discrezione. L’apostolo non deve usare i mezzi del mondo (denaro, potere e forza) per conquistare l’adesione dei suoi ascoltatori. Il vero apostolo non compera nessuno e non si lascia comperare da nessuno: forse sarà venduto a poco prezzo come il suo Maestro (Mc 14,10–11).La povertà è una condizione indispensabile per la missione: i missionari devono essere «truppe leggere». Questa povertà è fede, libertà e leggerezza. Un discepolo appesantito dai bagagli diventa sedentario, conservatore, incapace di cogliere la novità di Dio, abilissimo nel trovare mille ragioni di comodo. La povertà è fede concreta di chi non confida in se stesso e nei propri mezzi, ma nell’assistenza e nella provvidenza di chi l’ha mandato.L’annuncio del vangelo deve sempre essere in povertà, perché proclama la croce che ha salvato il mondo. Più che ciò che dobbiamo dire, Gesù ci insegna ciò che dobbiamo essere. Ciò che siamo grida più forte di ciò che diciamo. Finché non siamo poveri, ogni cosa che diamo o che diciamo non è dono, ma solo esercizio di potere sugli altri.Già nell’Antico Testamento, povertà, piccolezza e impotenza sono i mezzi che Dio sceglie per vincere (cf. 1Sam 2,1–10; Es 3,11; 4,10; Gdc 7,2). Infatti «Dio ha scelto ciò che nel mondo è stolto per confondere i sapienti, Dio ha scelto ciò che nel mondo è debole per confondere i forti. Dio ha scelto ciò che nel mondo è ignobile e disprezzato e ciò che è nulla per ridurre al nulla le cose che sono, perché nessun uomo possa gloriarsi davanti a Dio» (1Cor 1,27–29).Questa lezione l’aveva imparata bene Pietro, quando compì il primo miracolo. Egli disse allo storpio: «Non possiedo né argento né oro, ma quello che ho te lo do: nel nome di Gesù Cristo, il Nazareno, cammina» (At 3,6). Se Pietro e Giovanni avessero avuto argento e oro, avrebbero fatto un’opera buona, forse avrebbero fondato un istituto per portatori di handicap, avrebbero dato dei soldi, ma non avrebbero pensato che dovevano dare Gesù, il salvatore.La salvezza viene dalla croce, svuotamento che rivela Dio. Guai se la nostra potenza o sapienza la vanifica: «Cristo mi ha mandato a predicare il vangelo; non però con un discorso sapiente, perché non venga resa vana la croce di Cristo» (1Cor 1,17).Gesù invia i suoi in povertà, come il Padre aveva mandato lui in povertà. I discepoli, mediante la missione, sono chiamati alla forma più alta di vita cristiana: sono pienamente associati al Figlio, che conoscendo l’amore del Padre, è spinto verso tutti i fratelli.I Dodici possono annunciare agli altri la conversione mostrando di essere loro stessi convertiti perché sono e vivono come Gesù.Il vangelo parla anche della possibilità, tutt’altro che teorica, vista la sorte toccata a Gesù, che i discepoli non siano accolti e ascoltati. È una sofferenza che il discepolo deve affrontare senza perdersi d’animo. A lui è stato affidato un compito, non garantito il successo.Sulla attività dei Dodici, Marco non dà alcuna indicazione di tempo e di luogo; gli basta segnalare che essi realizzano esattamente ciò che aveva detto e fatto il Maestro: proclamare la conversione e operare esorcismi e guarigioni.14 Il re Erode sentì parlare di Gesù, poiché intanto il suo nome era diventato famoso. Si diceva: «Giovanni il Battista è risuscitato dai morti e per questo il potere dei miracoli opera in lui». 15 Altri invece dicevano: «È Elia»; altri dicevano ancora: «È un profeta, come uno dei profeti». 16 Ma Erode, al sentirne parlare, diceva: «Quel Giovanni che io ho fatto decapitare è risuscitato!».17 Erode infatti aveva fatto arrestare Giovanni e lo aveva messo in prigione a causa di Erodìade, moglie di suo fratello Filippo, che egli aveva sposata. 18 Giovanni diceva a Erode: «Non ti è lecito tenere la moglie di tuo fratello». 19 Per questo Erodìade gli portava rancore e avrebbe voluto farlo uccidere, ma non poteva, 20 perché Erode temeva Giovanni, sapendolo giusto e santo, e vigilava su di lui; e anche se nell’ascoltarlo restava molto perplesso, tuttavia lo ascoltava volentieri.21 Venne però il giorno propizio, quando Erode per il suo compleanno fece un banchetto per i grandi della sua corte, gli ufficiali e i notabili della Galilea. 22 Entrata la figlia della stessa Erodìade, danzò e piacque a Erode e ai commensali. Allora il re disse alla ragazza: «Chiedimi quello che vuoi e io te lo darò». 23 E le fece questo giuramento: «Qualsiasi cosa mi chiederai, te la darò, fosse anche la metà del mio regno». 24 La ragazza uscì e disse alla madre: «Che cosa devo chiedere?». Quella rispose: «La testa di Giovanni il Battista». 25 Ed entrata di corsa dal re fece la richiesta dicendo: «Voglio che tu mi dia subito su un vassoio la testa di Giovanni il Battista». 26 Il re divenne triste; tuttavia, a motivo del giuramento e dei commensali, non volle opporle un rifiuto. 27 Subito il re mandò una guardia con l’ordine che gli fosse portata la testa. 28 La guardia andò, lo decapitò in prigione e portò la testa su un vassoio, la diede alla ragazza e la ragazza la diede a sua madre. 29 I discepoli di Giovanni, saputa la cosa, vennero, ne presero il cadavere e lo posero in un sepolcro.I discepoli sono partiti e la scena è vuota. Marco la riempie con due brani che servono d’intermezzo: l’opinione di Erode su Gesù e l’assassinio di Giovanni Battista. Questo episodio, collocato tra l’invio in missione dei discepoli e il loro ritorno, acquista un significato preciso: è un segno premonitore dell’opposizione e del martirio riservati a Gesù e ai suoi discepoli.Questo brano del vangelo ci dà la versione «religiosa» della morte del Battista. Flavio Giuseppe ci dà quella «politica». Leggiamo in Antichità giudaiche 18,119: «Erode, temendo che egli con la sua grande influenza potesse spingere i sudditi alla ribellione (sembrando in effetti disposti a fare qualsiasi cosa che egli suggerisse loro), pensò che era meglio toglierlo di mezzo prima che sorgesse qualche complicazione per causa sua, anziché rischiare di non potere poi affrontare la situazione. E così, per questo sospetto di Erode, egli fu fatto prigioniero, inviato nella fortezza di Macheronte e qui decapitato».Quando i profeti mettono il dito sulla piaga e arrivano al nocciolo della questione, vengono tolti di mezzo senza scrupoli. La testa di Giovanni Battista su un vassoio, nel pieno svolgimento di un banchetto, può sembrare una «portata» insolita. A pensarci bene, non è poi un «piatto» tanto raro: quante decapitazioni durante pranzi, cene…!Questo brano, posto dopo l’invio in missione dei Dodici, indica il destino del missionario, del testimone di Cristo. In greco, testimone si dice «martire».La morte di Giovanni prelude la morte di Gesù e di quanti saranno inviati. Ciò può sembrare poco confortante, ma l’uomo deve comunque morire. La differenza della morte per cause naturali e martirio sta nel fatto che la prima è la fine, il secondo è il fine della vita. Il martire infatti testimonia fin dentro ed oltre la morte, l’amore che sta a principio della vita.Il banchetto di Erode nel suo palazzo fa da contrappunto a quello imbandito da Gesù nel deserto, descritto immediatamente di seguito (Mc 6,30–44). Il primo ricorda una nascita festeggiata con una morte; il secondo prefigura il memoriale della morte del Signore, festeggiato come dono della vita.Gli ingredienti del banchetto di Erode sono ricchezza, potere, orgoglio, falso punto d’onore, lussuria, intrigo, rancore e ingiustizia e, infine, il macabro piatto di una testa mozzata. La storia mondana non è altro che una variazione, monotona fino alla nausea, di queste vivande velenose.Il banchetto di Gesù invece ha la semplice fragranza del pane, dell’amore che si dona e germina in condivisione e fraternità.30 Gli apostoli si riunirono attorno a Gesù e gli riferirono tutto quello che avevano fatto e insegnato. 31 Ed egli disse loro: «Venite in disparte, in un luogo solitario, e riposatevi un po’». Era infatti molta la folla che andava e veniva e non avevano più neanche il tempo di mangiare. 32 Allora partirono sulla barca verso un luogo solitario, in disparte.33 Molti però li videro partire e capirono, e da tutte le città cominciarono ad accorrere là a piedi e li precedettero. 34 Sbarcando, vide molta folla e si commosse per loro, perché erano come pecore senza pastore, e si mise a insegnare loro molte cose. 35 Essendosi ormai fatto tardi, gli si avvicinarono i discepoli dicendo: «Questo luogo è solitario ed è ormai tardi; 36 congedali perciò, in modo che, andando per le campagne e i villaggi vicini, possano comprarsi da mangiare». 37 Ma egli rispose: «Voi stessi date loro da mangiare».. Gli dissero: «Dobbiamo andar noi a comprare duecento denari di pane e dare loro da mangiare?». 38 Ma egli replicò loro: «Quanti pani avete? Andate a vedere». E accertatisi, riferirono: «Cinque pani e due pesci». 39 Allora ordinò loro di farli mettere tutti a sedere, a gruppi, sull’erba verde. 40 E sedettero tutti a gruppi e gruppetti di cento e di cinquanta. 41 Presi i cinque pani e i due pesci, levò gli occhi al cielo, pronunziò la benedizione, spezzò i pani e li dava ai discepoli perché li distribuissero; e divise i due pesci fra tutti. 42 Tutti mangiarono e si sfamarono, 43 e portarono via dodici ceste piene di pezzi di pane e anche dei pesci. 44 Quelli che avevano mangiato i pani erano cinquemila uomini.Gesù non si fida dell’entusiasmo: sa che svanisce di fronte alle prime difficoltà (cf. Mc 4,16–17) e che non è segno di fede. È la situazione che viene descritta in questo brano. I discepoli sono presi dall’entusiasmo e raccontano a Gesù tutto quello che avevano fatto e insegnato.Il risultato della loro missione è lì sotto gli occhi di tutti, in quella gente che va e viene e non lascia più loro neppure il tempo per mangiare. Risultato strepitoso. Quella gente li fa sentire veramente «pescatori di uomini» (cf. Mc 1,7) realizzati.Questo racconto mira a rispecchiare già la futura immagine dell’attività missionaria della Chiesa: fare e insegnare come Gesù.Dopo le guarigioni descritte nel primo capitolo di questo vangelo, Gesù si era ritirato in un luogo deserto a pregare (1,35) e alla provocante espressione: «Tutti ti cercano» (1,37) aveva risposto con un atteggiamento, umanamente parlando, poco intelligente: «Andiamocene altrove!» (1,38).Gesù non sfrutta mai le occasioni favorevoli della popolarità e dell’entusiasmo viscerale: ci vuol ben altro per recidere alla radice il peccato del mondo e per immettere la novità di Dio in un’umanità così malandata.In questo brano, l’entusiasmo della folla è per i discepoli oltre che per Gesù. In questa cornice, la parola di Gesù: «Venite in disparte, in un luogo solitario, e riposatevi un po’» (v. 31) acquista il suo giusto valore. Gesù li vuole sfebbrare (cfr Lc 10,17–20). L’entusiasmo è pericoloso: per la folla e per i discepoli.L’insegnamento è chiaro: se vogliamo evitare i pericoli della popolarità, non dobbiamo lasciarci travolgere dall’entusiasmo viscerale e acritico che fa perdere il senso del limite e dà i fumi alla testa. L’antidoto è la solitudine e la preghiera.Gesù ha pietà della folla perché è disorganizzata. Non c’è nessuno che si occupi di essa ed è abbandonata a se stessa: non forma un popolo ma un’accozzaglia. La pietà di Gesù si traduce in insegnamento. Nel vangelo di Marco, quando Gesù si trova con la folla, si può stare certi che non perderà l’occasione per istruirla. Il seguito del vangelo ribadirà, con maggiore forza, questa costante di Gesù: «La folla accorse di nuovo a lui e di nuovo egli l’ammaestrava, come era solito fare» (Mc 10,1).Il legame che Marco instaura tra insegnamento e formazione di un popolo non è artificiale. Siamo davanti a un gregge senza pastore, un gregge disperso: solo la parola di Gesù può radunare e riunire gli smarriti e i dispersi. E dopo la parola, il pane; parola e pane che saziano la fame integrale delle folle: come nelle nostre Eucaristie.Viene in mente l’inquietudine di Mosè, ormai prossimo alla morte, quando chiese a Dio di provvedere alla sua successione dando un capo alla comunità radunata nel deserto (Nm 27,15–17). Anche Ezechiele confidava ai suoi ascoltatori la speranza che Dio si sarebbe preso personalmente cura del proprio gregge procurandogli un buon pasto e dandogli come pastore un nuovo Davide per porre fine al suo errare (Ez 34). Il salmo 23 aveva ripreso questo tema del Dio–pastore che offre al suo popolo il riposo per rinfrancarlo e apparecchiargli la mensa.Il riposo dei discepoli consiste nel bere alla fonte della misericordia divina, incarnata in Gesù, e nel fare propria la tenerezza di Dio per il suo popolo: così si impara a diventare apostoli. Gesù li invita a fare propria la sua ansia per le folle: ciò implica il preciso impegno di istruirle e di nutrirle (6,37–41) prima di concedersi il tempo per mangiare e riposarsi (6,31).Assumendo la sua missione di Pastore–Messia annunciato dai profeti (Es 34,23–25; 37,24) e invocato dalla preghiera del popolo ebraico (Sal 74,1; 77,21; 78,52–53.70–72, 80,1), Gesù comincia ad insegnare loro molte cose (v. 34). Marco, che attribuisce sempre molta importanza all’insegnamento di Gesù, non ne specifica mai il contenuto, come se volesse far capire che questo contenuto è la persona stessa di Gesù.La prima moltiplicazione dei pani (vv. 33–34) ha sicuramente l’intento di presentarci Gesù come pastore d’Israele che, in luogo deserto, dona il pane al popolo della prima alleanza, agli ebrei. Il racconto viene descritto sul modello del miracolo operato dal profeta Eliseo (2Re 4,42–44), mettendo però in risalto il divario tra i due (venti pani per cento persone in 2Re 4, cinque pani per cinquemila uomini in Marco), in modo che emerga la maggiore grandezza di Gesù rispetto al profeta.Questa prima moltiplicazione, secondo Marco, avviene in terra d’Israele, sulla riva occidentale del lago. Inoltre, le cifre riportate sembrano avere anche un significato simbolico: i cinque pani moltiplicati ricordano i cinque libri della Legge di cui Gesù era Maestro; i dodici canestri avanzati appaiono come una destinazione del pane alle dodici tribù d’Israele, e la distribuzione per gruppi, certamente, riguarda soltanto il popolo eletto nell’ordine operato da Mosè nel deserto (Es 18,24–26; Dt 1,15).Tutte queste particolarità indicano la prima moltiplicazione dei pani come azione destinata anzitutto ai giudei e come prefigurazione dell’Eucaristia riservata prima ad essi, quale garanzia del compimento delle promesse dell’Antico Testamento. Lo ricorderà ben presto Gesù alla donna siro–fenicia: «Lascia prima che si sfamino i figli» (Mc 7,27).Questo brano è iniziato svelando la sorgente del dono del Signore: «vide molta folla e si commosse per loro» (v. 34). La compassione è l’essenza nascosta di Dio, che lo porterà a dare la vita per noi.Il banchetto che Gesù imbandisce nel deserto è ben diverso da quello di Erode nel palazzo (Mc 6,21–29). Partecipando alla mensa di Cristo, il discepolo passa dall’egoismo e dalla brama dell’avere, del potere e dell’apparire, a una vita nuova nell’amore sotto il segno del dono e del servizio in umiltà. Entra a far parte di un popolo nuovo che ha le caratteristiche del pane che mangia. Perché l’uomo è ciò che mangia. Gesù ha detto: «Chi mangia di me, vivrà per me» (Gv 6,57).45 Ordinò poi ai discepoli di salire sulla barca e precederlo sull’altra riva, verso Betsàida, mentre egli avrebbe licenziato la folla. 46 Appena li ebbe congedati, salì sul monte a pregare. 47 Venuta la sera, la barca era in mezzo al mare ed egli solo a terra. 48 Vedendoli però tutti affaticati nel remare, poiché avevano il vento contrario, già verso l’ultima parte della notte andò verso di loro camminando sul mare, e voleva oltrepassarli. 49 Essi, vedendolo camminare sul mare, pensarono: «È un fantasma», e cominciarono a gridare, 50 perché tutti lo avevano visto ed erano rimasti turbati. Ma egli subito rivolse loro la parola e disse: «Coraggio, sono io, non temete!». 51 Quindi salì con loro sulla barca e il vento cessò.. Ed erano enormemente stupiti in se stessi, 52 perché non avevano capito il fatto dei pani, essendo il loro cuore indurito.Gesù «costringe» i discepoli a lasciare la folla esaltata e a precederlo sull’altra riva. Lo svezzamento è severo e il viaggio che li attende particolarmente faticoso. Nello stesso tempo, Gesù congeda la folla e sale sul monte a pregare.Nei momenti di euforia, Gesù è solito fare il vuoto attorno a sé e ai discepoli. Nella preghiera offre al Padre, dal quale proviene ogni bene, gli onori, la gloria e i ringraziamenti che la folla aveva rivolto a lui e ai discepoli.Ma lo sguardo fisso in Dio non distrae Gesù dalle necessità degli uomini, anzi, gliele fa vedere più distintamente.Nell’Antico Testamento, Dio cammina sulle acque (Sal 77,20; Gb 9,8; 38,16; Sir 24,5; Is 43,16). Egli infatti domina i flutti e calma la loro violenza (Sal 65,8; 77,17; 89,10; 93,4; 107,28–30).L’apparizione di Gesù ai discepoli li impaurisce e li fa gridare perché lo scambiano per un fantasma. La parola che Gesù rivolge loro: «Abbiate fiducia. Sono io. Non temete» (v. 50) è un invito alla calma, che accompagna ogni rivelazione divina (Es 14,13; 20,20; Sof 3,16–17), una rivelazione della sua divinità (Es 3,4; Dt 32,39; Is 41,4; 43,10) e un aiuto a superare la paura (Gen 15,1; Gs 8,1; Dn 10,12.19; Tb 12,17).Marco conclude il racconto con un’espressione fortissima: «Erano fuori di sé del tutto!» (v. 51). Perché? «Perché non avevano capito il fatto dei pani, essendo il loro cuore indurito (v. 52). Se essi avessero penetrato il mistero della moltiplicazione miracolosa, avrebbero riconosciuto colui che veniva camminando sulle acque del mare. Il martellare dei miracoli sulla loro intelligenza li rendeva ancora più confusi e spaventati: ne ritenevano gli elementi esterni, ma non riuscivano ancora a scendere nel loro significato più profondo. È un accecamento dello spirito. Una cecità che non impedisce di vedere gli avvenimenti, ma di capire la portata dei gesti compiuti da Gesù, di penetrare il significato profondo di ciò che passa sotto i loro occhi e, soprattutto di trarne le dovute conseguenze a riguardo della persona di Gesù.Durezza di cuore significa, in definitiva, totale incapacità di percepire il profondo significato della rivelazione che Gesù fa di se stesso attraverso le parabole e i miracoli. I Dodici non comprendono il mistero della sua persona, che traspare qui nel miracolo dei pani (cf. Lc 24,13–35).Questo brano ci dice l’identità misteriosa del pane. È il Signore che appare ai suoi come il Dio creatore e liberatore, dominatore del caos e salvatore dall’abisso. Egli si manifesta dicendo il nome rivelato a Mosè: «Io sono» (Es 3,14).L’Eucaristia non è una semplice condivisione e fraternità, ma è il Signore che si dona totalmente a noi nel suo amore. Mangiare l’Eucaristia significa nutrirsi di Cristo e porsi reciprocamente al servizio dei fratelli. I discepoli sulla barca sono in difficoltà perché non hanno capito questo (v. 52).L’Eucaristia è la forza del cammino della Chiesa nella misura in cui la comunità cristiana riconosce in essa il suo Signore morto e risorto.53 Compiuta la traversata, approdarono e presero terra a Genèsaret. 54 Appena scesi dalla barca, la gente lo riconobbe, 55 e accorrendo da tutta quella regione cominciarono a portargli sui lettucci quelli che stavano male, dovunque udivano che si trovasse. 56 E dovunque giungeva, in villaggi o città o campagne, ponevano i malati nelle piazze e lo pregavano di potergli toccare almeno la frangia del mantello; e quanti lo toccavano guarivano.Le folle riconoscono Gesù e gli portano i malati. Egli salva tutti coloro che lo toccano. Viene messa in evidenza sia l’avidità degli uomini nell’approfittare della potenza del guaritore, sia la compassione di Gesù verso le «pecore senza pastore» (6,34).La gente lo cerca come salvatore del popolo e operatore di prodigi: per ora non sembra che germogli in essa una fede più profonda. Il lettore del vangelo deve convincersi che bisogna «toccare» Gesù in un senso più vero di quanto non abbiano fatto i galilei; si deve credere in lui come nel Messia promesso, che raduna il popolo di Dio e che è veramente il Figlio di Dio.Marco descrive Gesù come un «uomo divino», dal quale emanano prodigiose virtù risanatrici. Egli appare come soccorritore e medico dei poveri e degli infermi. Ma dopo la moltiplicazione dei pani e il camminare sulle acque (6,35–52), il lettore cristiano sa con maggiore chiarezza che Gesù è assai più che un operatore di prodigi e un guaritore. Il suo potere viene da Dio e ha le radici nel mistero del tutto singolare di essere il Figlio di Dio.
CAPITOLO 07
1 Allora si riunirono attorno a lui i farisei e alcuni degli scribi venuti da Gerusalemme. 2 Avendo visto che alcuni dei suoi discepoli prendevano cibo con mani immonde, cioè non lavate – 3 i farisei infatti e tutti i Giudei non mangiano se non si sono lavate le mani fino al gomito, attenendosi alla tradizione degli antichi, 4 e tornando dal mercato non mangiano senza aver fatto le abluzioni, e osservano molte altre cose per tradizione, come lavature di bicchieri, stoviglie e oggetti di rame – 5 quei farisei e scribi lo interrogarono: «Perché i tuoi discepoli non si comportano secondo la tradizione degli antichi, ma prendono cibo con mani immonde?». 6 Ed egli rispose loro: «Bene ha profetato Isaia di voi, ipocriti, come sta scritto:Questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me.7 Invano essi mi rendono culto, insegnando dottrine che sono precetti di uomini.8 Trascurando il comandamento di Dio, voi osservate la tradizione degli uomini». 9 E aggiungeva: «Siete veramente abili nell’eludere il comandamento di Dio, per osservare la vostra tradizione. 10 Mosè infatti disse: Onora tuo padre e tua madre, e chi maledice il padre e la madre sia messo a morte. 11 Voi invece dicendo: Se uno dichiara al padre o alla madre: è Korbàn, cioè offerta sacra, quello che ti sarebbe dovuto da me, 12 non gli permettete più di fare nulla per il padre e la madre,13 annullando così la parola di Dio con la tradizione che avete tramandato voi. E di cose simili ne fate molte».14 Chiamata di nuovo la folla, diceva loro: «Ascoltatemi tutti e intendete bene: 15 non c’è nulla fuori dell’uomo che, entrando in lui, possa contaminarlo; sono invece le cose che escono dall’uomo a contaminarlo». 16 .17 Quando entrò in una casa lontano dalla folla, i discepoli lo interrogarono sul significato di quella parabola. 18 E disse loro: «Siete anche voi così privi di intelletto? Non capite che tutto ciò che entra nell’uomo dal di fuori non può contaminarlo, 19 perché non gli entra nel cuore ma nel ventre e va a finire nella fogna?». Dichiarava così mondi tutti gli alimenti. 20 Quindi soggiunse: «Ciò che esce dall’uomo, questo sì contamina l’uomo. 21 Dal di dentro infatti, cioè dal cuore degli uomini, escono le intenzioni cattive: fornicazioni, furti, omicidi, 22 adultèri, cupidigie, malvagità, inganno, impudicizia, invidia, calunnia, superbia, stoltezza. 23 Tutte queste cose cattive vengono fuori dal di dentro e contaminano l’uomo».Questi primi versetti del capitolo 7 di Marco possono sembrare a noi del 2000 questioni ridicole e controversie definitivamente superate da un pezzo: e in parte è vero, per fortuna! Dobbiamo però cogliere almeno due affermazioni importanti e valide in tutti i tempi e sotto tutti i cieli:1. Comandamenti di Dio e tradizioni degli uomini devono essere tenuti sempre distinti: i primi hanno valore perenne e universale e quindi sono immutabili; le seconde sono provvisorie e quindi possono, e spesso devono, essere cambiate. Di conseguenza, il cristiano, e più in generale l’uomo onesto e intelligente, si rinnova in continuità ed è disponibile alle riforme e al progresso;2. Gesù rifiuta la distinzione giudaica fra puro e impuro, fra una sfera religiosa separata, in cui Dio è presente, e una sfera ordinaria, quotidiana, in cui Dio è assente. Non ci si purifica dalla vita quotidiana cercando Dio altrove, fuori dalla vita di tutti i giorni, ma al contrario ci si deve purificare dal peccato che è dentro di noi. Gesù contesta la distinzione ormai ritenuta sicura e indiscutibile: l’ebreo è puro e tutti gli altri sono impuri.La questione del puro e impuro ha avuto una grande importanza nei primi tempi del cristianesimo, soprattutto per la partecipazione alla stessa mensa tra giudei e pagani (Gal 2,11–17). Ci ritorna alla mente la voce che Pietro sentì nella visione di Ioppe: «Ciò che Dio ha purificato, tu non chiamarlo più profano» (At 10,15).I due casi specifici che questo brano prende in considerazione sono l’occasione per giungere al nocciolo della questione che interessa Gesù: non è ciò che entra nell’uomo che lo contamina, ma quello che esce dal suo cuore. Ognuno deve dare importanza alla conversione radicale del cuore.Per Gesù il cuore dev’essere pulito, libero, retto. Si tratta di creare una situazione interiore degna di Dio, perché è lì che egli si rivela e abita. «Beati i puri di cuore perché vedranno Dio» (Mt 5,8). L’autenticità della vita religiosa si misura dal cuore, cioè dalle scelte libere che escono dall’interno dell’uomo. La santità non consiste in fatti esterni e superficiali, ma nella purezza del cuore.Citando il quarto comandamento, Gesù dimostra di accettare la forza vincolante della legge scritta di Mosè, ma rifiuta le tradizioni asfissianti e cavillose che contraddicono ai comandamenti di Dio più che aiutare a capirli e ad osservarli meglio.Ciò che tiene lontano da Dio le persone buone sono le tradizioni religiose staccate dall’amore, che è la loro sorgente. L’uomo è sempre tradizionalista e abitudinario. Ma il cristiano rompe con il passato perché vive una novità inaudita: la memoria del corpo e del sangue del suo Signore consegnato a lui nel pane. Questo mistero di amore è la «sua» tradizione, che ha ricevuto e, a sua volta, trasmette (1Cor 11,23ss).Il discepolo mangia questo pane e ne vive, e fonda la sua vita non sulla propria osservanza della legge, ma sulla grazia di Dio.Il principio del bene e del male è il nostro cuore buono o cattivo, illuminato dall’amore o accecato dall’egoismo. La norma ultima di comportamento per fare la volontà di Dio viene dal discernimento del nostro cuore: siamo mossi da Dio o dal demonio?, dall’amore o dall’egoismo? S. Agostino ha scritto: «Ama, e fa’ quello che vuoi!».24 Partito di là, andò nella regione di Tiro e di Sidone. Ed entrato in una casa, voleva che nessuno lo sapesse, ma non potè restare nascosto. 25 Subito una donna che aveva la sua figlioletta posseduta da uno spirito immondo, appena lo seppe, andò e si gettò ai suoi piedi. 26 Ora, quella donna che lo pregava di scacciare il demonio dalla figlia era greca, di origine siro–fenicia. 27 Ed egli le disse: «Lascia prima che si sfamino i figli; non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini». 28 Ma essa replicò: «Sì, Signore, ma anche i cagnolini sotto la tavola mangiano delle briciole dei figli». 29 Allora le disse: «Per questa tua parola và, il demonio è uscito da tua figlia».30 Tornata a casa, trovò la bambina coricata sul letto e il demonio se n’era andato.L’attacco portato da Gesù contro le tradizioni alimentari del suo popolo fu un colpo ben assestato contro le divisioni esistenti tra ebrei e pagani.L’opera di demolizione continua in questa breve narrazione: è la fede che rende partecipi del nuovo popolo di Dio, non il fatto di essere ebrei (cf. Gal 3,7–9).Il problema che soggiace a questa narrazione è questo: «E’ lecito concedere ai pagani i benefici che Dio accorda agli ebrei?». La risposta di Gesù è affermativa e chiara.Il racconto della seconda moltiplicazione dei pani (8,1–10) sarà la risposta, alla luce del sole e davanti a quattromila persone, di quanto Gesù ci ha anticipato qui nel segreto di una casa privata: Gesù è venuto per tutti, è pane per tutti, è il salvatore di tutti.La donna pagana, originaria della Sirofenicia, dimostra di possedere una fede altrettanto tenace che la donna ebrea che soffriva di perdite di sangue (cf. 5,25–34) e non si lascia impaurire dal rifiuto iniziale di Gesù.La risposta di Gesù a questa donna può sembrare addirittura offensiva, ma tale non è. Nel suo parlare allegorico, egli vuol dire: Sono stato mandato anzitutto per i figli d’Israele, e non posso preferire i pagani.Si è voluto spesso richiamare il fatto che gli ebrei consideravano se stessi come figli di Dio e designavano i pagani col nome di «cani», per disprezzo; infatti questa parola in Oriente suonava come insulto. Tuttavia ci si riferiva ai cani randagi, mentre Gesù parla qui di «cagnolini», ossia di animali domestici, ed è in questo senso che l’intende anche la donna. Perciò Gesù non parla in uno stile odioso, ma, come usava spesso, conia qui una similitudine per dare rilievo al suo pensiero.Le parole di Gesù non sono un rifiuto totale, ma soltanto un accenno al fatto che egli deve recare la benedizione della salvezza in primo luogo a Israele.La donna accetta l’allegoria usata da Gesù e la volge prontamente a suo favore: anche i cagnolini sotto la tavola ricevono qualche briciola del pane dei figli. Gesù non poteva desiderare nulla di meglio se non che la fede della donna fosse abbastanza forte per riconoscerlo e approfittarne.Questo racconto si presenta come un esempio di fede. Una fede genuina che non si lascia turbare nemmeno quando sembra che Dio nasconda la sua faccia.31 Di ritorno dalla regione di Tiro, passò per Sidone, dirigendosi verso il mare di Galilea in pieno territorio della Decàpoli. 32 E gli condussero un sordomuto, pregandolo di imporgli la mano. 33 E portandolo in disparte lontano dalla folla, gli pose le dita negli orecchi e con la saliva gli toccò la lingua; 34 guardando quindi verso il cielo, emise un sospiro e disse: «Effatà» cioè: «Apriti!». 35 E subito gli si aprirono gli orecchi, si sciolse il nodo della sua lingua e parlava correttamente. 36 E comandò loro di non dirlo a nessuno. Ma più egli lo raccomandava, più essi ne parlavano 37 e, pieni di stupore, dicevano: «Ha fatto bene ogni cosa; fa udire i sordi e fa parlare i muti!».Nel territorio della Decapoli (che significa dieci città) portano a Gesù un uomo sordo e muto, supplicandolo di imporgli le mani. Gesù conduce quest’uomo in disparte dalla folla, mette della saliva nelle orecchie e gli tocca la lingua; poi alzando gli occhi al cielo emette un sospiro e dice:»Effatà» cioè «Apriti». La citazione in lingua aramaica vuole riportarci la parola detta da Gesù, che parlava aramaico. Di fronte a questo avvenimento viene spontaneo il ricordo del testo di Isaia:» Dite agli smarriti di cuore: Coraggio! Non temete; ecco il vostro Dio. Allora si apriranno gli occhi ai ciechi e si schiuderanno gli orecchi ai sordi. Allora lo zoppo salterà come un cervo, griderà di gioia la lingua del muto» (Is 35,4–6).L’uomo diventa la parola a cui presta ascolto e dà risposta. Se ascolta Dio diventa Dio, se ascolta il demonio diventa demonio. Eva ha ascoltato il maligno e ha partorito tutto il male del mondo. Maria ha ascoltato Dio e ha partorito tutto il bene dell’umanità.Dio è parola, comunicazione e dono di sé. L’uomo è prima di tutto orecchio, e poi lingua. Ascoltando Dio è in grado di rispondergli: entra in dialogo con lui. La religione cristiana è la religione della parola e dell’ascolto, della comunicazione con Dio che ci parla. Per questo, essere sordi e muti (nel senso religioso) è il più grande dei mali.Con questo miracolo Gesù ci fa capire che cosa vuole operare nei suoi ascoltatori. Noi tutti siamo spiritualmente sordi, chi più chi meno; anche coloro che ascoltano la parola di Dio rischiano di essere dei sordi selettivi, ossia ascoltano quello che fa comodo e eliminano automaticamente tutto quello che può turbare il loro placido sonno. Gesù è il medico venuto a ridarci la capacità di dialogo con Dio e con i fratelli. Il cristiano, forse come tutti, è un fenomenale divoratore di tante chiacchiere, ma risulta sovente sordo e muto davanti alla Parola che lo fa uomo e figlio di Dio.Gesù è venuto per guarire il mutismo e la sordità dall’umanità per farla diventare il vero popolo di Dio, un popolo che ascolta e risponde a colui che gli dice:» Ascolta, Israele!» (Dt 6,4–5;); « Ascoltate!» (Mc 4,3); «Questi è il Figlio mio prediletto: ascoltatelo!» (Mc 9,7).Chi professa la fede cristiana è, di professione, un ascoltatore di Gesù.A parlare non si impara nulla, ad ascoltare gli stupidi si diventa stupidi, ad ascoltare i saggi si diventa saggi, ad ascoltare Dio si diventa Dio.
CAPITOLO 08
1 In quei giorni, essendoci di nuovo molta folla che non aveva da mangiare, chiamò a sé i discepoli e disse loro: 2 «Sento compassione di questa folla, perché già da tre giorni mi stanno dietro e non hanno da mangiare. 3 Se li rimando digiuni alle proprie case, verranno meno per via; e alcuni di loro vengono di lontano». 4 Gli risposero i discepoli: «E come si potrebbe sfamarli di pane qui, in un deserto?». 5 E domandò loro: «Quanti pani avete?». Gli dissero: «Sette». 6 Gesù ordinò alla folla di sedersi per terra. Presi allora quei sette pani, rese grazie, li spezzò e li diede ai discepoli perché li distribuissero; ed essi li distribuirono alla folla. 7 Avevano anche pochi pesciolini; dopo aver pronunziata la benedizione su di essi, disse di distribuire anche quelli. 8 Così essi mangiarono e si saziarono; e portarono via sette sporte di pezzi avanzati. 9 Erano circa quattromila. E li congedò.10 Salì poi sulla barca con i suoi discepoli e andò dalle parti di Dalmanùta.Marco riporta due moltiplicazioni dei pani (6,35–46; 8,1–9).Ciò che anzitutto impressiona in questi racconti è la folla: una folla numerosa, venuta a piedi da ogni parte, che segue Gesù giorni e giorni.Secondo alcuni, tanta folla farebbe sospettare la formazione di un movimento messianico di tipo politico che vedeva in Gesù un possibile capo. Ciò è verosimile: del resto Giovanni, a proposito del medesimo episodio, annota che le folle cercavano Gesù per farlo re (Gv 6,15).Il clima politico della Galilea di quel tempo era surriscaldato e bastava poco a suscitare fanatismi messianici. Scrive ad esempio Giuseppe Flavio: «Uomini ingannevoli e impostori, che sotto apparenza di ispirazione divina operavano innovazioni e sconvolgimenti, inducevano la folla ad atti di fanatismo religioso e la conducevano fuori nel deserto, come se là Dio avesse mostrato loro i segni della libertà imminente» (Guerra giudaica 2,259).In questa luce, nella prima moltiplicazione dei pani, acquista importanza l’annotazione che Gesù obbligò i discepoli ad allontanarsi, ed egli, dopo aver congedata la folla, si ritirò sulla montagna a pregare (6,45–46).Gesù non accondiscende alle attese politiche della folla, ma si allontana da essa, ritrovando nella preghiera la chiarezza della via messianica della croce e il coraggio per percorrerla.Questa seconda moltiplicazione dei pani avviene in pieno territorio pagano come prefigurazione dell’eucaristia universale, offerta in pienezza anche ai pagani. Le sette ceste di pezzi avanzati sono destinate alle settanta nazioni pagane della tradizione biblica ebraica (cf. Gen 10).Ancora una volta Gesù dona il pane e rinnova la sua misericordia. Non si stanca di noi, non si scoraggia per la nostra durezza di cuore. Insiste con il suo dono infinite volte. Tutta la storia è il tempo della pazienza di Dio.11 Allora vennero i farisei e incominciarono a discutere con lui, chiedendogli un segno dal cielo, per metterlo alla prova. 12 Ma egli, traendo un profondo sospiro, disse: «Perché questa generazione chiede un segno? In verità vi dico: non sarà dato alcun segno a questa generazione». 13 E lasciatili, risalì sulla barca e si avviò all’altra sponda.A questo punto la situazione di Gesù è veramente tragica e la sua immagine impressionante. È un uomo addolorato per il rifiuto dei farisei e meravigliato e deluso per il comportamento dei discepoli che ancora non capiscono.I primi sono totalmente chiusi alla fede. Se chiedono a Gesù un segno, un miracolo, non è perché vogliono credere in lui, ma per tendergli un tranello (v. 11). Gesù capisce la loro manovra, rifiuta il segno e li abbandona (vv. 12–13). È la rottura definitiva.La differenza tra i farisei e i discepoli sta nel fatto che questi ultimi non hanno deciso di farlo morire e non l’abbandonano. E questo non è poco. Per il resto sono uguali: il loro atteggiamento di incomprensione nei confronti di Gesù è colpevole. Hanno il cuore indurito perché si ostinano a non capire e non riflettono su ciò che vedono e odono (vv.17–18).Gesù si sforza di farli ragionare; ricorda loro le due moltiplicazioni dei pani, ma deve concludere con una amara constatazione: «E non capite ancora?» (v. 21). Sono ciechi e sordi davanti a Dio che si rivela.Gesù ci ha già dato il suo massimo segno donandoci se stesso nel suo pane. Non bisogna chiedergli altri segni, ma credere nel segno che ci ha dato. Oltre a questo non c’è più niente: è Dio stesso, tutto per noi. Non resta che riconoscere, adorare, gustare e viverne.Il discepolo, invece di chiedere segni, chiede la capacità di vedere quelli che Gesù gli ha già dato.14 Ma i discepoli avevano dimenticato di prendere dei pani e non avevano con sé sulla barca che un pane solo. 15 Allora egli li ammoniva dicendo: «Fate attenzione, guardatevi dal lievito dei farisei e dal lievito di Erode!». 16 E quelli dicevano fra loro: «Non abbiamo pane». 17 Ma Gesù, accortosi di questo, disse loro: «Perché discutete che non avete pane? Non intendete e non capite ancora? Avete il cuore indurito? 18 Avete occhi e non vedete, avete orecchi e non udite? E non vi ricordate, 19 quando ho spezzato i cinque pani per i cinquemila, quante ceste colme di pezzi avete portato via?». Gli dissero: «Dodici». 20 «E quando ho spezzato i sette pani per i quattromila, quante sporte piene di pezzi avete portato via?». Gli dissero: «Sette». 21 E disse loro: «Non capite ancora?».I discepoli sono talmente immersi nei pensieri terra–terra di ogni giorno, che non riescono a penetrare nelle severe parole di Gesù e continuano a manifestarsi l’un l’altro le loro preoccupazioni per il pane.Gesù interviene e parla loro in tono di tale rimprovero come non aveva mai fatto prima.Il loro cuore è indurito fin dal tempo della moltiplicazione dei pani (6,52); essi non hanno capito nulla dell’opera messianica di Gesù né hanno compreso il mistero della sua personalità mentre egli camminava sulle onde del lago. Tuttavia Gesù non abbandona nemmeno ora i suoi discepoli, ma cerca di portarli a riflettere e a capire.I discepoli devono stare attenti a non lasciarsi contagiare dalla mentalità dei farisei e di Erode. Gesù vuole che stiano lontani da questi due partiti: da quello dei farisei, la cui religione è più esteriore che profonda; da quello di Erode che è totalmente preso dalle cose del mondo e della politica. L’avvertimento è tutt’altro che fuori posto: Giuda ci cascherà dentro in pieno, purtroppo!Ma mentre Gesù diceva loro queste cose, essi pensavano ad altro: «E quelli dicevano tra loro: ‘Non abbiamo panÈ» (v. 16). È evidente la «distrazione» dei discepoli, la loro incapacità di ascoltare: Sono talmente immersi nella preoccupazione del pane che non afferrano altro. Non avvertono neppure l’urgenza e l’importanza di quanto Gesù sta dicendo. Si comportano come se egli non parlasse.«Non intendete e non capite ancora?» (v. 17). Il rimprovero di Gesù assume un’ampiezza insospettata e si risolve in una diagnosi completa delle malattie di cui sono afflitti i discepoli: scarsa intelligenza, cecità, sordità, durezza di cuore, sospetta perdita della memoria.In questi versetti, il martellamento delle domande incalzanti, che vanno verso il fortissimo e passano in rassegna tutti i sensi dell’uomo, fa capire ai discepoli che non hanno capito proprio nulla.Essi ricordano perfettamente i fatti. Rispondono senza alcuna esitazione e sanno ricordare benissimo ciò che è accaduto. Sono tutt’altro che stupidi, ma non comprendono il grande dramma che si sta svolgendo sotto i loro occhi.In questa circostanza i nodi vengono al pettine e Gesù coglie l’occasione per fare ai suoi discepoli un esame di coscienza piuttosto ruvido. Non è possibile leggere questo brano senza sentire il tono alto, altissimo della voce di Gesù, con una buona dose d’ira, di accoramento e di delusione. Il Maestro si trova davanti dodici discepoli che non sanno risolvere l’equazione ad un’incognita: e in questo caso l’incognita è Gesù.«Avete il cuore indurito?». La diagnosi di Gesù si concentra essenzialmente su una malattia: la durezza di cuore. Il cuore, nel linguaggio biblico, indica non tanto la sede della vita affettiva, quanto la fonte dei pensieri e della comprensione. Qui viene denunciata la mancanza d’intelligenza, l’incapacità di vedere la portata messianica di ciò che sta accadendo: è l’accecamento dello spirito. I discepoli sono duri di cuore perché non hanno l’intelligenza per capire chi è Gesù: e questa intelligenza si identifica, di fatto, con la fede.«Avete occhi e non vedete, avete orecchi e non udite?» Tutti questi interrogativi non sono una condanna, ma un invito accorato e costante a convertirsi, che richiama i rimproveri di Mosè (Dt 29, 3) e dei profeti (Ger 5,21; Ez 12,2) al popolo ribelle.Egli li rimanda alla loro esperienza passata. Come il ricordo dei benefici d’un tempo provocava Israele a uscire dal suo torpore e a tornare a Dio (cf. Sal 77,4.6.12.13; 105,5), così la memoria di quello che essi avevano fatto, distribuendo alle folle il pane che sazia in abbondanza, può richiamarli alla loro responsabilità e aiutarli a capire finalmente chi egli sia.La funzione di questo brano corrisponde alla prima fase del miracolo che segue: vuol farci vedere che non vediamo. Siamo come il cieco che scambia gli uomini per alberi.22 Giunsero a Betsàida, dove gli condussero un cieco pregandolo di toccarlo. 23 Allora preso il cieco per mano, lo condusse fuori del villaggio e, dopo avergli messo della saliva sugli occhi, gli impose le mani e gli chiese: «Vedi qualcosa?». 24 Quegli, alzando gli occhi, disse: «Vedo gli uomini, poiché vedo come degli alberi che camminano». 25 Allora gli impose di nuovo le mani sugli occhi ed egli ci vide chiaramente e fu sanato e vedeva a distanza ogni cosa. 26 E lo rimandò a casa dicendo: «Non entrare nemmeno nel villaggio».Gesù vuole aiutare i suoi discepoli ad aprirsi all’ascolto della verità, a vederci chiaro nella propria vita, a rendersi abili, a parlare correttamente della propria fede. Finché non si vede distintamente, come il cieco guarito, finché non si vede Gesù nella vera luce della sua identità non si è ancora adatti per l’annuncio del vangelo.Non credere significa diventare come i pagani, che somigliano ai loro idoli i quali «hanno bocca e non parlano, hanno occhi e non vedono, hanno orecchi e non odono…» (Sal 105,4–6).In tutta questa sezione del vangelo Gesù rimprovera più volte i suoi discepoli perché non capiscono o non vogliono vedere chiaramente la realtà.. Ma, mentre egli fa questi rimproveri, guarisce un sordo e un cieco, e la cosa diventa un segno della guarigione spirituale dei discepoli. Così essi diventeranno capaci di dire (finalmente!): «Tu sei il Cristo!» (Mc 8,29). Ma la loro guarigione non è completa. Infatti, si riveleranno altrettanto chiusi al nuovo insegnamento di Gesù sul cammino del Cristo verso la croce. Gesù avrà di nuovo a che fare con le loro orecchie tappate e i loro occhi ciechi, e la sua difficoltà a guarire fisicamente un sordomuto e un cieco manifesta appunto la difficoltà a guarire il cuore dei discepoli. Marco descrive questi due miracoli come segni di una guarigione interiore: guarigione della sordità e della cecità spirituale.La guarigione del cieco di Betsaida avviene in due tempi, ed è un fatto unico in tutto il Vangelo: si presta a simboleggiare il viaggio della fede, che avviene progressivamente e non senza esitazioni.Questa guarigione è un gesto profetico di Gesù e simboleggia lo schiudersi degli occhi dei suoi discepoli alla sua messianicità.Gesù è l’unica luce che dà la vista, che illumina ogni uomo (Gv 1,9). Il discepolo è un cieco che sa di esserlo, riconosce l’impossibilità di guarire da solo e lascia che il Signore agisca secondo la sua misericordia.27 Poi Gesù partì con i suoi discepoli verso i villaggi intorno a Cesarèa di Filippo; e per via interrogava i suoi discepoli dicendo: «Chi dice la gente che io sia?». 28 Ed essi gli risposero: «Giovanni il Battista, altri poi Elia e altri uno dei profeti». 29 Ma egli replicò: «E voi chi dite che io sia?». Pietro gli rispose: «Tu sei il Cristo». 30 E impose loro severamente di non parlare di lui a nessuno.31 E cominciò a insegnar loro che il Figlio dell’uomo doveva molto soffrire, ed essere riprovato dagli anziani, dai sommi sacerdoti e dagli scribi, poi venire ucciso e, dopo tre giorni, risuscitare. 32 Gesù faceva questo discorso apertamente. Allora Pietro lo prese in disparte, e si mise a rimproverarlo. 33 Ma egli, voltatosi e guardando i discepoli, rimproverò Pietro e gli disse: «Lungi da me, satana! Perché tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini».L’episodio comincia con una domanda:» Chi dice la gente che io sia?». Le risposte che danno i discepoli corrispondono a quello che pensa e dice la gente. Sono risposte positive, che esprimono rispetto e stima per Gesù, ma rimangono incomplete perché cercano di spiegare il mistero di Gesù accostandolo ad altri personaggi pur grandi della storia della salvezza. Tutte queste risposte non riescono ad esprimere la novità e l’unicità della persona del Cristo.Gesù pone ai discepoli una seconda domanda, diretta, personale:» E voi, chi dite che io sia?». Risponde Pietro: «Tu sei il Cristo». La risposta corrisponde a verità, ma va chiarita nel suo contenuto. È per questo che Gesù proibisce ai discepoli di parlare di lui alla gente e inizia a svelare loro la sua vera messianicità: quella del Cristo che deve soffrire e morire. Egli non è il liberatore nel senso voluto dai giudei, ma il Salvatore nel senso voluto da Dio. Il Cristo «deve» percorrere il cammino che lo porterà alla croce (v. 31) per fare il sacrificio della propria vita per la salvezza di tutti. Gesù è il Figlio dell’uomo incamminato verso la croce. Da questo punto in avanti, il tema della croce e della risurrezione è, in un certo modo, l’unico tema trattato, perché tutto gira attorno ad esso. Gesù è il Messia sofferente, il Servo di Dio disprezzato, abbandonato dagli uomini e destinato ad una morte infame (cf. Is 53).Siccome l’idea che i discepoli hanno sul Messia è insufficiente, Gesù incomincia un nuovo insegnamento, una nuova rivelazione (vv. 31–32). E proprio Pietro, che aveva proclamato con sicurezza: «Tu sei il Cristo», si oppone violentemente alla nuova rivelazione di Gesù. Il Messia che lui e i suoi compagni attendono è uno che all’occorrenza uccide gli altri, non uno che mette nel suo programma la propria sconfitta e la propria morte. Ma Gesù è ilCristo come lo vuole Dio, non come lo vorrebbero gli uomini. Egli è venuto per cambiare il mondo, e questo richiede, come prima cosa, il capovolgimento del modo di pensare degli uomini e il cambio di direzione per ritornare a Dio (cf. Mc 1,15).E qui viene spontanea una considerazione. Opponendosi alla passione e morte di Gesù, Pietro crede di fare il vero bene di Gesù e di tutti, di dimostrargli un amore grande e di dargli un consiglio eccezionale. Di fatto, però, svolge il ruolo di satana che tenta di distogliere Gesù dall’obbedienza al Padre. Il diavolo tentatore prova nuovamente il colpo che non gli era riuscito nel deserto (cf. Mc 1,12–13): Gesù, che non aveva ceduto alla tentazione del nemico, forse cederà alle insistenze del miglior amico. Ma Gesù resiste a viso aperto. Quante azioni sataniche si compiono «a fin di bene, per amore,...», ma in direzione opposta a quella insegnata e percorsa da Gesù!34 Convocata la folla insieme ai suoi discepoli, disse loro: «Se qualcuno vuol venire dietro di me rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. 35 Perché chi vorrà salvare la propria vita, la perderà; ma chi perderà la propria vita per causa mia e del vangelo, la salverà. 36 Che giova infatti all’uomo guadagnare il mondo intero, se poi perde la propria anima? 37 E che cosa potrebbe mai dare un uomo in cambio della propria anima? 38 Chi si vergognerà di me e delle mie parole davanti a questa generazione adultera e peccatrice, anche il Figlio dell’uomo si vergognerà di lui, quando verrà nella gloria del Padre suo con gli angeli santi».La teoria del vangelo è molto chiara. Dio è amore che dona la vita e giunge alla risurrezione attraverso la povertà, l’umiltà e l’umiliazione della morte in croce. L’uomo è egoismo che cerca di salvarsi e produce morte attraverso la ricerca dell’avere, del potere e dell’apparire. Questi due modi di essere e di comportarsi sono inconciliabili tra loro. Quando il cristiano, «a fin di bene», vuole costruire il regno di Dio con il materiale scartato dal Cristo (avere, potere, apparire), in realtà costruisce il regno di satana. Indossa la divisa di Cristo, ma gioca nella squadra avversaria e, in questo modo, gli è più facile far vincere il suo vero padrone, il diavolo. Anche su questo Gesù ci ha preavvisati:» Guardatevi dai falsi profeti, che vengono a voi in veste di pecore, ma dentro sono lupi rapaci» (Mt 7,15). I falsi profeti sono i cristiani che dicono e fanno diversamente da quello che insegna il vangelo. Il vero cristiano è colui che segue Gesù crocifisso, rinnega se stesso, prende la sua croce e lo segue, povero, umile e umiliato, verso il Calvario per morire e risuscitare con lui.Seguire Cristo è una scelta libera perché è una scelta d’amore; e non vi può essere amore senza libertà. Ma seguire Gesù è anche una scelta scandalosa: significa croce assicurata per tutti, indistintamente. Ed è su questo punto centrale e decisivo che avviene lo scontro tra la vera fede o il rifiuto di essa.La vocazione definitiva del cristiano è la partecipazione alla morte e alla risurrezione di Cristo per la salvezza propria e altrui.Pietro aveva proclamato che Gesù era il Cristo e sembrava quindi un credente; in realtà non accettava il significato più profondo della messianicità di Cristo: la croce.La fede è un modo di vivere, non di teorizzare; un modo di vivere e di morire come Cristo. Ed è la morte il vertice della vita, perché liberandoci completamente dall’egoismo, ci rende capaci del più grande e definitivo atto d’amore per Dio.La croce che dobbiamo prendere e portare è la lotta continua contro la nostra falsa autoaffermazione. La croce è il supplizio degli schiavi. Il cristiano, come il Cristo, deve vivere come servo di tutti e padrone di nessuno.Rinnegare se stessi è la piena realizzazione di se stessi; significa vincere il falso io, l’egoismo, radice di tutti i mali. L’uomo sentendosi piccolo, insignificante e stupido, vuole affermarsi facendosi ricco, potente e orgoglioso. Ma è un inganno. Egli infatti si realizza solo quando diventa come il suo Dio, di cui è immagine. E Dio è amore, dono, servizio, povertà, umiltà.La salvezza dalla morte dipende dalla nostra presa di posizione nei confronti di Gesù e del suo vangelo. Il nostro destino eterno è legato alla nostra fedeltà o infedeltà alla sua parola.Prendere la propria croce significa fare proprio il destino di Gesù e renderlo visibile di fronte agli uomini: un destino di morte e risurrezione.Salvare la propria vita significa «vergognarsi di Gesù e delle sue parole davanti a questa generazione adultera e peccatrice» (v. 38): rinnegare lui anziché rinunciare a se stessi, preferire la propria vita alla sua, i propri progetti e interessi personali all’impegno per il suo vangelo e per il suo Regno.La vita è il bene supremo dell’uomo: non ha prezzo (vv. 36–37). Ora chi ama la propria vita veramente, deve metterla al sicuro in Gesù. «Dio ci ha dato la vita eterna, e questa vita è nel suo Figlio. Chi ha il Figlio ha la vita; chi non ha il Figlio di Dio, non ha la vita» (1Gv 5,11–12).Tra gli ostacoli che impediscono all’uomo di prendere la sua decisione in favore di Cristo c’è la vergogna. La vergogna è la paura di essere derisi, emarginati e odiati (cf. Gv 15,18–25; 16,20). Il cristiano autentico deve avere il coraggio di essere «diverso dal mondo» per essere «simile a Dio». Il giorno del giudizio finale tutti saranno giudicati secondo il vangelo di Cristo e non secondo le massime del mondo. San Paolo ci ricorda: «Certa è questa parola: se moriamo con lui, vivremo anche con lui; se con lui perseveriamo, con lui anche regneremo; se lo rinneghiamo, anch’egli ci rinnegherà» (2Tim 2,11–12).«E diceva loro: ‘In verità vi dico: vi sono alcuni dei presenti che non morranno senza aver visto il regno di Dio venire con potenza’ « (4,1). Non è una promessa di sfuggire alla morte fisica, ma una certezza data al discepolo che, dopo aver condiviso con Cristo la sofferenza e la morte, sperimenterà in modo decisivo la potenza della sua risurrezione: «Se infatti siamo stati completamente uniti a lui con una morte simile alla sua, lo saremo anche con la sua risurrezione» (Rm 6,5).RITORNA ▲ SOMMARIO
CAPITOLO 09
1 E diceva loro: «In verità vi dico: vi sono alcuni qui presenti, che non morranno senza aver visto il regno di Dio venire con potenza».2 Dopo sei giorni, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li portò sopra un monte alto, in un luogo appartato, loro soli. Si trasfigurò davanti a loro 3 e le sue vesti divennero splendenti, bianchissime: nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche. 4 E apparve loro Elia con Mosè e discorrevano con Gesù. 5 Prendendo allora la parola, Pietro disse a Gesù: «Maestro, è bello per noi stare qui; facciamo tre tende, una per te, una per Mosè e una per Elia!». 6 Non sapeva infatti che cosa dire, poiché erano stati presi dallo spavento. 7 Poi si formò una nube che li avvolse nell’ombra e uscì una voce dalla nube: «Questi è il Figlio mio prediletto; ascoltatelo!». 8 E subito guardandosi attorno, non videro più nessuno, se non Gesù solo con loro.9 Mentre scendevano dal monte, ordinò loro di non raccontare a nessuno ciò che avevano visto, se non dopo che il Figlio dell’uomo fosse risuscitato dai morti. 10 Ed essi tennero per sé la cosa, domandandosi però che cosa volesse dire risuscitare dai morti. 11 E lo interrogarono: «Perché gli scribi dicono che prima deve venire Elia?». 12 Egli rispose loro: «Sì, prima viene Elia e ristabilisce ogni cosa; ma come sta scritto del Figlio dell’uomo? Che deve soffrire molto ed essere disprezzato. 13 Orbene, io vi dico che Elia è già venuto, ma hanno fatto di lui quello che hanno voluto, come sta scritto di lui».Nella narrazione della trasfigurazione ritroviamo i tre testimoni della risurrezione della figlia di Giairo: Pietro, Giacomo e Giovanni. Li troveremo anche nel Getsemani. C’è uno stretto legame tra questi tre episodi.Il primo manifesta il potere di Gesù sulla morte. La trasfigurazione è un’anticipazione della gloria della risurrezione. L’agonia, che è il contrasto totale con i primi due episodi, mostra in qual modo Gesù cammina verso la gloria: accettando di entrare totalmente nelle vedute del Padre (cf. 14,36).Anche qui, come nel battesimo, si fa sentire la voce del Padre che parla dalla nube. Ma questa volta non si rivolge soltanto a Gesù (cf. 1,11), ma ai tre discepoli. Il titolo di «Figlio mio prediletto» che richiama allo stesso tempo la regalità del Messia (cf. Sal 2,7) e il destino del Servo di Dio (cf. Is 42,1), conferma la verità di ciò che Pietro non ha ancora accettato: che la glorificazione del Messia si realizza attraverso la sofferenza.In più, alla rivelazione fa seguito un comando: «Ascoltatelo!». La parola del Padre viene ad appoggiare l’insegnamento di Gesù sulla sua passione e risurrezione. In questa prospettiva, la trasfigurazione appare come l’anticipata manifestazione della gloria di Cristo. Dal racconto della trasfigurazione dobbiamo imparare che solo nella luce della risurrezione si comprende il mistero della croce.La trasfigurazione, e non la sfigurazione, è il punto di arrivo dell’uomo e dell’universo. Il nostro volto non è quello disfatto dallo sfacelo della morte, ma quello trasfigurato della risurrezione.La trasfigurazione corrisponde alla vita nuova che il battesimo ci conferisce attraverso la croce: un’esistenza pasquale, passata dall’egoismo all’amore, dalla tristezza alla gioia, dall’inquietudine alla pace. Sul nostro volto deve brillare il riflesso del volto del Risorto, che è il volto stesso del Padre.Rispondendo alla domanda sulla venuta di Elia (v. 11), Gesù riconduce i suoi discepoli alla prospettiva realistica della passione, che questa scena della trasfigurazione illumina, ma non attenua in nessun modo.Chi vuole intendere la risurrezione di Gesù, deve entrare prima nel mistero della sua passione. La sofferenza del giusto sconfitto, che a noi fa problema, per Gesù è la soluzione del problema: il male lo vince chi non lo fa e porta su di sé il male degli altri.14 E giunti presso i discepoli, li videro circondati da molta folla e da scribi che discutevano con loro. 15 Tutta la folla, al vederlo, fu presa da meraviglia e corse a salutarlo. 16 Ed egli li interrogò: «Di che cosa discutete con loro?». 17 Gli rispose uno della folla: «Maestro, ho portato da te mio figlio, posseduto da uno spirito muto. 18 Quando lo afferra, lo getta al suolo ed egli schiuma, digrigna i denti e si irrigidisce. Ho detto ai tuoi discepoli di scacciarlo, ma non ci sono riusciti». 19 Egli allora in risposta, disse loro: «O generazione incredula! Fino a quando starò con voi? Fino a quando dovrò sopportarvi? Portatelo da me». 20 E glielo portarono. Alla vista di Gesù lo spirito scosse con convulsioni il ragazzo ed egli, caduto a terra, si rotolava spumando. 21 Gesù interrogò il padre: «Da quanto tempo gli accade questo?». Ed egli rispose: «Dall’infanzia; 22 anzi, spesso lo ha buttato persino nel fuoco e nell’acqua per ucciderlo. Ma se tu puoi qualcosa, abbi pietà di noi e aiutaci». 23 Gesù gli disse: «Se tu puoi! Tutto è possibile per chi crede». 24 Il padre del fanciullo rispose ad alta voce: «Credo, aiutami nella mia incredulità». 25 Allora Gesù, vedendo accorrere la folla, minacciò lo spirito immondo dicendo: «Spirito muto e sordo, io te l’ordino, esci da lui e non vi rientrare più». 26 E gridando e scuotendolo fortemente, se ne uscì. E il fanciullo diventò come morto, sicché molti dicevano: «E’ morto». 27 Ma Gesù, presolo per mano, lo sollevò ed egli si alzò in piedi.28 Entrò poi in una casa e i discepoli gli chiesero in privato: «Perché noi non abbiamo potuto scacciarlo?». 29 Ed egli disse loro: «Questa specie di demòni non si può scacciare in alcun modo, se non con la preghiera».Con questo episodio Marco ci istruisce su un’esigenza fondamentale per seguire Gesù: la preghiera. I discepoli, con tutta la loro buona volontà, non sono riusciti a scacciare il demonio da un ragazzo. Eppure Gesù li aveva scelti proprio perché «stessero con lui, per mandarli a predicare e perché avessero il potere di scacciare i demoni» (3,14–15). E quando erano andati in missione «predicavano che la gente si convertisse, scacciavano molti demoni…» (6,12–13). Ma ora non riescono! Perché? Gesù risponde con una frase che illumina non solo la situazione in questione, ma anche molte pagine della storia della Chiesa: «Questa specie di demoni non si può scacciare in nessun modo, se non con la preghiera» (9,29).Solo un cristiano che prega sarà in grado di superare vittoriosamente il potere di satana sul mondo.Ai discepoli che chiedono il motivo della loro impotenza, Gesù ricorda l’importanza assoluta della preghiera. E’ solo con la preghiera fiduciosa che possiamo riempire la nostra debolezza con la potenza di Dio. Dobbiamo convincerci che la nostra preghiera è più potente di quanto pensiamo.La terapia dei nostri mali e della nostra morte è lasciarci toccare da Gesù che è il medico e la medicina: e questo atteggiamento è la fede. Ma questa ci manca. Sia chi crede di credere, sia chi crede di non credere è invitato a ripetere l’invocazione del padre: «Aiuta la mia incredulità» (v. 24).La fede è onnipotente perché accoglie la forza di Dio che viene in nostro aiuto e ha compassione di noi.30 Partiti di là, attraversavano la Galilea, ma egli non voleva che alcuno lo sapesse. 31 Istruiva infatti i suoi discepoli e diceva loro: «Il Figlio dell’uomo sta per esser consegnato nelle mani degli uomini e lo uccideranno; ma una volta ucciso, dopo tre giorni, risusciterà». 32 Essi però non comprendevano queste parole e avevano timore di chiedergli spiegazioni.33 Giunsero intanto a Cafarnao. E quando fu in casa, chiese loro: «Di che cosa stavate discutendo lungo la via?». 34 Ed essi tacevano. Per la via infatti avevano discusso tra loro chi fosse il più grande. 35 Allora, sedutosi, chiamò i Dodici e disse loro: «Se uno vuol essere il primo, sia l’ultimo di tutti e il servo di tutti». 36 E, preso un bambino, lo pose in mezzo e abbracciandolo disse loro:37 «Chi accoglie uno di questi bambini nel mio nome, accoglie me; chi accoglie me, non accoglie me, ma colui che mi ha mandato».Le vie di Gesù non sono quelle che solitamente percorrono gli uomini. Egli, sfuggendo alla folla, è deciso a percorrere il cammino di umiliazione tracciato per lui dal Padre. I suoi discepoli, preoccupati dell’onore, sognano e seguono altre strade, talmente estranee a quella di Gesù, che essi stessi ne avvertono il disagio. Mentre Gesù cammina verso la massima umiliazione, quella della croce, essi si preoccupano di essere i primi e i più grandi.Le parole di Gesù manifestano la sua disponibilità a vivere fino in fondo il suo destino di morte e risurrezione. I discepoli, invece, sembrano vivere in un altro mondo. Essi sanno già che seguire Gesù significa dimenticare se stessi, prendere la propria croce e seguirlo (Mc 8,34), ma hanno paura. Il loro non capire, in realtà, è un non voler capire. Questa istruzione che Gesù offre ai suoi apostoli è il centro del suo insegnamento e della rivelazione: è il mistero di Dio che si consegna nelle mani dell’uomo.La parola «consegnare» unisce i vari episodi del racconto della passione: Giuda lo consegna ai capi e ai soldati (Mc 14,10.44), i capi a Pilato (Mc 15,1) e Pilato ai crocifissori (15,15). Ma il paradosso è che lo stesso Padre lo consegna, e Gesù stesso si consegna a noi. Gesù che si dona a chi lo rifiuta e lo odia, sapendo che l’avrebbero torturato e ucciso, è la rivelazione totale e definitiva di un Dio che è amore incondizionato e nient’altro che amore incondizionato. Di fronte alla rivelazione di un amore così grande, di Dio in persona che si consegna nelle mani degli uomini che egli ama, i discepoli non compresero. Non compresero che Dio è un amore così grande, che sorpassa infinitamente ogni aspettativa e immaginazione umana.Le questioni di precedenza e di eccellenza, ovviamente, interessano e appassionano gli apostoli più dell’annuncio della passione, morte e risurrezione ripetuto da Gesù per la seconda volta. La sete di potere, l’arrivismo, il desiderio di essere primi, di sentirsi superiori agli altri e di dominarli è da sempre il cancro dell’umanità. Annunciare la Parola a persone immerse in queste faccende è come gettare il seme tra le spine: «Le preoccupazioni del mondo e l’inganno della ricchezza e tutte le altre bramosie soffocano la Parola e questa rimane senza frutto» (Mc 4,19).Non è male aspirare ai posti di governo nella Chiesa, anzi, può essere segno di un dono dello Spirito (cf. 1Cor 12,28). Ma è male fare della carica una questione di prestigio, di superbia: essa è unicamente una possibilità di servire di più e meglio. La sete di potere nella Chiesa rende tutti, capi o semplici fedeli, identici ai capi di questo mondo che scaricano sugli altri i pesi e i sacrifici (cf. Mt 23,4) e mandano sulla croce gli altri invece di andarvi loro, seguendo l’esempio di Cristo. Gente siffatta è del tutto incapace (e per nulla credibile) di testimoniare un vero annuncio della passione, morte e risurrezione di Cristo vissute in prima persona e sulla propria pelle.I discepoli non comprendono la parola di Dio perché hanno in testa la parola del diavolo. La parola di Gesù è amore e umiltà, quella del demonio è egoismo e protagonismo. Chi cerca il proprio io, perde se stesso, gli altri e Dio. Dopo la prima predizione della sua passione, Gesù invitò ogni discepolo a portare la «propria» croce. Questa croce è il rinnegamento del proprio falso io (Mc 8,34), la lotta contro la stupidità e l’orgoglio, che portano all’autoaffermazione a spese di tutto e di tutti.Gesù sa che ognuno vuole e deve affermarsi. Questo desiderio di grandezza l’ha posto Dio stesso nell’uomo. Chi vi rinuncia, rinuncia ad essere uomo. Ma è proprio per questo che Gesù ci dà i criteri della vera realizzazione. Alla brama di primeggiare nell’avere, nel potere e nell’apparire, egli sostituisce il desiderio di primeggiare nella povertà, nell’umiltà e nell’umiliazione: in altre parole, nel servire e nell’amare fino a morire per i propri amici e per i propri nemici.Questa è la grandezza di Dio e questa dev’essere la grandezza dell’uomo fatto a sua immagine e somiglianza. Egli è amore, e non afferma se stesso a spese dell’altro, ma lo fa crescere a sue spese; non si serve dell’altro, ma lo serve; non lo spoglia di quello che ha, ma spoglia se stesso a favore dell’altro: si spoglia anche della sua stessa vita, perché ama l’altro più che se stesso e lo considera il proprio tutto. Alla concorrenza per essere i più grandi, egli sostituisce il gareggiare per diventare i più piccoli (Rm 12,10; Fil 2,3).Il protagonismo è il criterio supremo d’azione di chi non si sente amato, non si ama e non ama. Per questo protagonismo l’uomo sacrifica la sua vita agli idoli dell’avere, del potere e dell’apparire sempre di più, distruggendo la propria realtà di immagine di Dio. Quando Adamo volle occupare il posto di Dio, fece l’errore di ignorare che Dio non sta al primo posto, ma all’ultimo. E, così, si trovò fallito come uomo senza essere diventato Dio.«Se uno vuol essere il primo, sia l’ultimo di tutti e il servo di tutti» (v. 35): questa è la norma fondamentale del nuovo popolo di Dio. Il primato dell’amore soppianta quello dell’egoismo.La libertà che ci rende simili a Dio, consiste nel diventare schiavi, liberamente e per amore, gli uni degli altri (Gal 5,13).38 Giovanni gli disse: «Maestro, abbiamo visto uno che scacciava i demòni nel tuo nome e glielo abbiamo vietato, perché non era dei nostri». 39 Ma Gesù disse: «Non glielo proibite, perché non c’è nessuno che faccia un miracolo nel mio nome e subito dopo possa parlare male di me. 40 Chi non è contro di noi è per noi.41 Chiunque vi darà da bere un bicchiere d’acqua nel mio nome perché siete di Cristo, vi dico in verità che non perderà la sua ricompensa.42 Chi scandalizza uno di questi piccoli che credono, è meglio per lui che gli si metta una macina da asino al collo e venga gettato nel mare. 43 Se la tua mano ti scandalizza, tagliala: è meglio per te entrare nella vita monco, che con due mani andare nella Geenna, nel fuoco inestinguibile. 44. 45 Se il tuo piede ti scandalizza, taglialo: è meglio per te entrare nella vita zoppo, che esser gettato con due piedi nella Geenna. 46. 47 Se il tuo occhio ti scandalizza, cavalo: è meglio per te entrare nel regno di Dio con un occhio solo, che essere gettato con due occhi nella Geenna, 48 dove il loro verme non muore e il fuoco non si estingue. 49 Perché ciascuno sarà salato con il fuoco. 50 Buona cosa il sale; ma se il sale diventa senza sapore, con che cosa lo salerete? Abbiate sale in voi stessi e siate in pace gli uni con gli altri».Riportando l’episodio dell’esorcista estraneo al gruppo dei discepoli, il vangelo ci dà un insegnamento importante. In tutti i tempi, molti cristiani hanno creduto di avere il monopolio di Gesù e, di conseguenza, hanno corso il rischio di essere intolleranti. Il primo dovere di coloro che hanno autorità è quello di non proibire di fare il bene. Il bene, sotto ogni forma, non è monopolio di chi ha il potere o dei cristiani rispetto agli altri. Fare il bene, scacciare i demoni è un diritto e un dovere che compete ad ogni uomo. Gesù e lo Spirito santo sono presenti ovunque si fa il bene e quindi anche fuori della comunità visibile della Chiesa.Dietro la rimostranza di Giovanni si vede con chiarezza l’egoismo di gruppo, la paura della concorrenza, che spesso si maschera di fede, ma in realtà è una delle sue più radicali smentite. Molti, troppi puntigliosi sostenitori di Dio (?) in realtà sostengono se stessi o gli interessi del loro gruppo.Nel brano precedente del vangelo (Mc 9,33–37) i discepoli si dividevano tra loro in nome del proprio io. Qui si dividono dagli altri nel nome del proprio noi. Il proprio nome, individuale o collettivo, è principio di divisione; solo il «Nome» di Gesù è fattore di unità tra tutti. L’egoista è vittima dell’invidia, che è figlia dell’egoismo e madre dell’orgoglio. Essa trasforma la vita in un inferno perché produce una sofferenza proporzionale al bene invidiato, fino a una sofferenza infinita davanti al Bene infinito, Dio. Per questo la Bibbia ci insegna: «La morte è entrata nel mondo per invidia del diavolo» (Sap 2,24). L’amore è dono, l’invidia, al contrario, è il voler possedere tutto e tutti, e quindi distruggere la vita di tutto e di tutti.Egoismo, invidia, orgoglio possono essere sia in forma personale che in forma collettiva. Il peccato originale del singolo è mettere il proprio io al posto di Dio, il peccato originale del gruppo è mettere al posto di Dio il proprio noi. La Chiesa non è composta da chi segue noi, ma da chi segue Cristo, con noi o senza di noi.La motivazione portata da Gesù: «Non glielo proibite, perché non c’è nessuno che faccia un miracolo nel mio nome e subito dopo possa parlare male di me» (v. 39) non è opportunistica, ma vuol far capire ai discepoli quanto sia irragionevole il loro atteggiamento. Egli dà come direttiva alla comunità la tolleranza e la magnanimità, e vuole che i suoi discepoli abbiano uno spirito aperto, che si elevi al di sopra della gretta mentalità di gruppo. Il vero cristiano, che è figlio di Dio, non vede negli altri dei nemici da combattere, ma dei fratelli da accogliere e da amare.Gesù Cristo è presente ovunque si fa qualcosa di buono, dentro o fuori della Chiesa visibile. Anche un bicchiere d’acqua dato a un povero cristiano, non resterà senza ricompensa. Questa presenza di Cristo, anche fuori della Chiesa ufficiale è per la comunità cristiana un costante richiamo: un richiamo al servizio e alla disponibilità verso tutti. Cristo ci chiama tutti a uscire con coraggio dalle nostre situazioni di comodo per incontrarlo in ogni uomo, cattivo o buono.Al tempo di Gesù, c’erano i maestri della legge che con il peso della loro autorità e con la minaccia delle loro scomuniche (cf. Gv 9,22; 12,42) cercavano di impedire alle persone semplici di seguire Gesù.. Lo scandalo, di cui parla il vangelo, è tutto ciò che impedisce a qualcuno di seguire Dio per giungere alla salvezza. Per un uomo che svia gli altri dalla fede in Cristo sarebbe meglio, secondo la parola di Gesù, che fosse gettato in mare con una grossa pietra attaccata al collo. Piuttosto che far perdere la fede anche a uno solo, sarebbe meglio morire. Questa espressione ci richiama le parole pronunciate da Gesù nei confronti di Giuda: «Meglio sarebbe per lui, se non fosse nato»(Mc 14,21). Frasi di questo genere non vanno prese come sentenze di condanna diretta e immediata, ma piuttosto come delle espressioni che servono a far capire meglio la mostruosità dell’azione. Nell’applicare queste parole di Gesù, la comunità cristiana non intese limitarle solo ai bambini, ma a tutti i fedeli della comunità che venivano tentati a rinunciare alla fede. E’ sempre una cosa estremamente grave mettere in pericolo o distruggere la fede nel cuore dei semplici.La serie di sentenze riguardanti le membra del corpo divenute occasione di caduta morale, mostra quanto sia radicale l’esigenza di Gesù dal punto di vista etico. Per lui l’argomento della salvezza è così grave, che bisogna compiere ogni sforzo per entrare nel regno di Dio (cf. Lc 13,24). Quando è in gioco la nostra salvezza eterna, non ci si può accontentare delle mezze misure.«Il fuoco inestinguibile» e «il verme che non muore» (v. 48) sono due modi di dire che si ricollegano all’Antico Testamento (Is 66,24). Nel testo di Isaia si parla degli uomini giudicati da Dio, i cui cadaveri ammassati nella valle dell’Hinnon, situata a sud–ovest di Gerusalemme, sono abbandonati privi di sepoltura alla corruzione (verme) e al fuoco distruttore. Dal nome della valle di Hinnon (in ebraico ge–Hinnon) deriva la parola Geenna. Era la discarica di Gerusalemme.Il «non entrare nella vita», il «non entrare nel regno di Dio» significa il fallimento del fine ultimo della vita, il non entrare nella vita eterna di Dio: è il fallimento totale dell’esistenza, è il diventare «rifiuti» da gettare nella discarica per essere bruciati, perché inutili, ingombranti e maleodoranti.C’è qui un invito pressante a scoprire l’assoluta importanza di seguire Gesù per non perdere irrimediabilmente il dono della vita presente e futura.«Ciascuno sarà salato col fuoco» (v. 49). Il fuoco che sala si riferisce sia al castigo che punisce i peccatori conservandoli, sia al fuoco che purifica i fedeli per farne vittime gradite a Dio (cf. Lv 2,13 cui fa allusione un’aggiunta «e ogni vittima sarà salata col sale»). Il sale e il fuoco fanno pensare alla purificazione che i discepoli devono attuare attraverso la persecuzione e la sofferenza. Può essere una spiritualizzazione di Lv 2,13: similmente ai sacrifici dell’Antico Testamento, anche il sacrificio di sé dei cristiani dev’essere salato col fuoco dello Spirito Santo (cf. Mt 18,3; Mc 8,35; Gv 3,5).«Abbiate sale in voi stessi e siate in pace gli uni con gli altri» (v. 50). E’ un’allusione alla disputa sulla vera grandezza (9,33–34) che aveva occasionato tutta questa seconda parte del capitolo. L’amore fraterno esclude atteggiamenti di rivalità nel servizio del vangelo. La sapienza di Cristo è principio di pace gli uni con gli altri.
CAPITOLO 10
1 Partito di là, si recò nel territorio della Giudea e oltre il Giordano. La folla accorse di nuovo a lui e di nuovo egli l’ammaestrava, come era solito fare. 2 E avvicinatisi dei farisei, per metterlo alla prova, gli domandarono: «E’ lecito ad un marito ripudiare la propria moglie?». 3 Ma egli rispose loro: «Che cosa vi ha ordinato Mosè?». 4 Dissero: «Mosè ha permesso di scrivere un atto di ripudio e di rimandarla». 5 Gesù disse loro: «Per la durezza del vostro cuore egli scrisse per voi questa norma. 6 Ma all’inizio della creazione Dio li creò maschio e femmina; 7 per questo l’uomo lascerà suo padre e sua madre e i due saranno una carne sola. 8 Sicché non sono più due, ma una sola carne. 9 L’uomo dunque non separi ciò che Dio ha congiunto». 10 Rientrati a casa, i discepoli lo interrogarono di nuovo su questo argomento. Ed egli disse: 11 «Chi ripudia la propria moglie e ne sposa un’altra, commette adulterio contro di lei; 12 se la donna ripudia il marito e ne sposa un altro, commette adulterio».Da quando gli uomini si sono ribellati a Dio hanno continuamente sperimentato il male della divisione e non riescono più a capire un discorso serio sull’unità. Ma il cristiano deve capire. Se egli crede che Cristo è morto per riunire insieme i figli di Dio che erano dispersi (Gv 11,52), e fare dell’umanità una sola grande famiglia, deve trarne le conseguenze ad ogni livello, anche a quello matrimoniale.Al tempo di Gesù, il divorzio era ammesso sulla base di un testo del Deuteronomio, 24,1: «Quando un uomo ha preso una donna e ha vissuto con lei da marito, se poi avviene che essa non trovi grazia ai suoi occhi, perché egli ha trovato in lei qualche cosa di vergognoso, scriva per lei un libello di ripudio e glielo consegni in mano e la mandi via da casa».Per capire bene la legge del Deuteronomio (che in realtà è una permissione) e non degradare la parola di Dio, dobbiamo fare un po’ di storia.Come la legge del taglione (che consiste nell’infliggere al colpevole lo stesso danno da lui inflitto alla vittima: Es 21,23–25; Lv 24,17–20; Dt 19,18–21) tendeva a limitare gli eccessi della vendetta (cf. Gen 4,23–24), così la legge del divorzio è una legge restrittiva. All’inizio, l’uomo sposato, in Israele, godeva il diritto quasi assoluto di ripudiare a suo arbitrio la sua sposa. Il Deuteronomio 24,1 limita appunto questo barbaro arbitrio: è un primo argine per riportare il matrimonio nell’alveo voluto da Dio all’inizio della creazione (Gen 1,24; 2,4). E, come la legge del taglione sarà superata dal comandamento dell’amore (cfr Mt 5,38–48), così la legge del divorzio, «permesso per la durezza del cuore», cioè per colpa dell’egoismo, sarà superata dal comandamento dell’indissolubilità del matrimonio.Nell’Antico Testamento viene lodata la fedeltà coniugale (Pr 5,15–20), e il divorzio è considerato riprovevole, sebbene in alcuni casi venisse tollerato «per la durezza di cuore». Il legislatore non solo pone limiti al divorzio, ma cerca di renderne difficile l’attuazione: la dote pagata ai familiari della sposa non viene restituita, e se l’uomo voleva contrarre nuove nozze doveva sobbarcarsi l’onere di un nuovo contributo.I profeti cercano di limitare la possibilità di ripudio della sposa ai casi di adulterio (Os 2,4; Ger 3,8). Malachia è colui che difende con maggiore chiarezza l’indissolubilità del vincolo matrimoniale: Dio in persona, per mezzo del matrimonio, fa dell’uomo e della donna una carne sola, una sola vita; l’uomo che ripudia la propria moglie si carica di una grande responsabilità davanti a Dio che detesta il ripudio (Ml 2,14–16). Tuttavia, l’insegnamento positivo dell’assoluta indissolubilità del matrimonio lo troviamo solo nel Nuovo Testamento.Gesù indica Gen 1,27 e 2,24 come la ragione per la quale il matrimonio è indissolubile. Egli si richiama alla volontà del creatore: il Dio unico crea l’uomo a sua immagine, fondando l’unità indissolubile del matrimonio. E’ Dio stesso che unisce l’uomo e la donna. La sua parola creatrice opera la «congiunzione» dei sessi. Così dunque la posizione di Gesù è senza ambiguità: rifiutando decisamente la poligamia, condanna contemporaneamente il divorzio seguito da seconde nozze, qualunque ne sia il motivo, fondandosi sui valori originari dell’unione coniugale indissolubile. Così le interpretazioni rabbiniche si trovano definitivamente scavalcate nel senso già indicato dal profeta Malachia, per il quale ripudiare la propria moglie equivale a rompere l’alleanza di Dio col suo popolo, perché questa si incarna nell’unione degli sposi (Ml 2,13–16). Gesù non è venuto per abolire la Legge e i Profeti, ma per dare compimento (Mt 5,17).Con il dono del suo Spirito, Gesù ci libera dalla durezza di cuore e ci rende nuovamente capaci di vivere ciò che era «in principio». Il discepolo scopre in Gesù la vera dignità dell’uomo: essere partner di Dio che lo ama infinitamente. Egli vive il matrimonio come immagine di questo grande mistero.Presso molti popoli, anche ai nostri giorni, l’uomo acquista la donna comprandola dalla sua famiglia; essa diventa sua proprietà che può abbandonare quando non gli serve più. Chiaramente questo tipo di rapporto fondato sul possesso non è secondo il disegno di Dio, perché il rapporto tra Dio e l’umanità, di cui il matrimonio è segno o sacramento, è un rapporto di amore, non di possesso. L’uomo può possedere le cose e gli animali, non un altro uomo.Al di là della forma, anche presso di noi il matrimonio è spesso un possesso, una compravendita di mutue relazioni, una prostituzione reciproca. Il matrimonio, invece che amore e servizio, diventa egoismo e sopraffazione. Si sta insieme finché dura l’interesse del più forte. Quando cessa l’interesse, ossia l’egoismo, l’uso dell’altro, la strumentalizzazione, cessa tutto. Tutto questo succede perché l’uomo e la donna sono malati di durezza di cuore. Il cuore dell’uomo è indurito, è egoista, non è capace di amare: questo è il suo peccato, il suo fallimento a tutti i livelli. Solo con Cristo, la creazione raggiunge il suo fine: torna ad essere come Dio l’ha pensata fin dall’inizio. Anche il matrimonio trova il suo significato esclusivamente in Cristo. Fuori di lui non esiste nulla e nulla ha senso (cf. Ef 1,4; Col 1,16–17).13 Gli presentavano dei bambini perché li accarezzasse, ma i discepoli li sgridavano. 14 Gesù, al vedere questo, s’indignò e disse loro: «Lasciate che i bambini vengano a me e non glielo impedite, perché a chi è come loro appartiene il regno di Dio. 15 In verità vi dico: Chi non accoglie il regno di Dio come un bambino, non entrerà in esso». 16 E prendendoli fra le braccia e ponendo le mani sopra di loro li benediceva.C’è ancora una completa divergenza tra Gesù e i discepoli nell’idea che si fanno della sua missione. Devono imparare che il regno di Dio non è in mano alle persone che contano, che le preferenze di Dio sono rivolte a coloro che sono considerati insignificanti, come i bambini, a coloro che sanno attendere e accogliere tutto da lui, senza pretese, alla maniera dei piccoli. La reazione violenta di Gesù (si indignò), dà ragione all’ardire dei bambini e dei loro genitori e torto all’ottusità dei discepoli.«Lasciate che i bambini vengano a me e non glielo impedite». Questa frase ci richiama l’altra: «Chi scandalizza (impedisce, mette ostacolo) uno di questi piccoli che credono, è meglio per lui che gli si metta una macina da asino al collo e venga gettato nel mare» (Mc 9,42). Questo riferimento spiega ulteriormente l’indignazione di Gesù verso i discepoli: aveva appena finito la lezione ed essi dimostrano con i fatti che, ancora una volta, non avevano capito o non avevano voluto capire niente.«Perché a chi è come loro appartiene il regno di Dio». Soltanto i bambini sono in grado di chiamare Dio «Abbà», «Papà», «Babbo» con fiducia infantile e sentirsi al sicuro sotto la sua protezione, consci del suo illimitato amore. I bambini quindi sono quelli di ogni età che sentono in questo modo nei confronti di Dio e vivono «l’infanzia spirituale».«E prendendoli tra le braccia e ponendo le mani sopra di loro, li benediceva». L’umanità di Gesù è autentica, profonda e senza artifici. Nel suo modo di fare rivela un cuore delicato, sensibile e incline alla bontà.Il vero discepolo è colui che sa di non possedere nulla e di ricevere tutto dal Padre, come un bambino. E’ totalmente dipendente da Dio. E ciò non solo non gli dispiace, ma lo fa totalmente felice.Il Regno non è un prodotto da costruire, ma un dono da accogliere, che c’è già. E’ Gesù, il Figlio nel quale anche noi diventiamo figli del Padre e fratelli di tutti.17 Mentre usciva per mettersi in viaggio, un tale gli corse incontro e, gettandosi in ginocchio davanti a lui, gli domandò: «Maestro buono, che cosa devo fare per avere la vita eterna?». 18 Gesù gli disse: «Perché mi chiami buono? Nessuno è buono, se non Dio solo. 19 Tu conosci i comandamenti: Non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non dire falsa testimonianza, non frodare, onora il padre e la madre».20 Egli allora gli disse: «Maestro, tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia giovinezza». 21 Allora Gesù, fissatolo, lo amò e gli disse: «Una cosa sola ti manca: và, vendi quello che hai e dallo ai poveri e avrai un tesoro in cielo; poi vieni e seguimi». 22 Ma egli, rattristatosi per quelle parole, se ne andò afflitto, poiché aveva molti beni.23 Gesù, volgendo lo sguardo attorno, disse ai suoi discepoli: «Quanto difficilmente coloro che hanno ricchezze entreranno nel regno di Dio!». 24 I discepoli rimasero stupefatti a queste sue parole; ma Gesù riprese: «Figlioli, com’è difficile entrare nel regno di Dio! 25 E’ più facile che un cammello passi per la cruna di un ago, che un ricco entri nel regno di Dio». 26 Essi, ancora più sbigottiti, dicevano tra loro: «E chi mai si può salvare?». 27 Ma Gesù, guardandoli, disse: «Impossibile presso gli uomini, ma non presso Dio! Perché tutto è possibile presso Dio».28 Pietro allora gli disse: «Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito». 29 Gesù gli rispose: «In verità vi dico: non c’è nessuno che abbia lasciato casa o fratelli o sorelle o madre o padre o figli o campi a causa mia e a causa del vangelo, 30 che non riceva già al presente cento volte tanto in case e fratelli e sorelle e madri e figli e campi, insieme a persecuzioni, e nel futuro la vita eterna. 31 E molti dei primi saranno ultimi e gli ultimi i primi».Questo brano di vangelo ci insegna il vero atteggiamento del cristiano nei confronti della proprietà, della povertà e della ricchezza. Il comportamento da tenere nei confronti dei beni terreni va visto in ordine a Gesù: se facilitano o impediscono il seguire Gesù. Dall’esempio presentato da questo brano di vangelo impariamo quanto le ricchezze esercitano un pericoloso potere perfino su persone serie e impegnate. Inoltre, sull’esempio di Pietro e dei primi discepoli che per Gesù hanno abbandonato tutto, siamo incoraggiati a camminare sulla via del distacco e della povertà. Non a tutti, forse, è indispensabile alleggerirsi dei propri averi; tutti però devono ascoltare l’appello a una totale dedizione, che Gesù rivolge a ciascuno, sia pure in modo diverso. Si tratta di fare spazio a Gesù. Rinunciare a se stessi per seguire Gesù significa concretamente togliere di mezzo gli idoli che occupano lo spazio e il tempo della nostra vita, e sono di ostacolo sulla via del regno di Dio.L’uomo di cui parla il vangelo è un osservante della legge (v. 20), ma il seguire Gesù è molto di più che il semplice adempimento della legge. Anche il giusto ha un distacco da fare e non è detto che sempre lo faccia. Il peccatore pubblico Levi (cf. Lc 5,27–28) accettò l’invito, l’uomo ricco, giusto e osservante lo rifiutò. Una vocazione mancata a causa della schiavitù delle ricchezze. Queste perciò non sono innocue, ma tendono a rendere l’uomo schiavo. Quando questo avviene, le ricchezze comandano e l’uomo obbedisce. L’avidità di ricchezza è vera idolatria (cf. Col 3,5) e l’attaccamento al denaro è la radice di tutti i mali (cfr 1Tm 6,10). Il denaro è un ottimo servo, ma un pessimo padrone. Rifiutando la libertà che gli viene offerta, questo tale se ne va rattristato. Questa tristezza è segno che la grazia l’ha toccato: la sua ricchezza si oppone attualmente al progresso spirituale, ma la misericordia di Dio l’ha reso cosciente di ciò, facendogli capire che, con le sue azioni e osservanze, non può ottenere in eredità la vita eterna. La tristezza che lo invade è dono dell’amore del Dio buono (v.18) che incessantemente lo chiama. Fino a questo punto l’attaccamento ai suoi beni lo rende cieco: non vede il suo vero bene che è Dio presente in Gesù.. Nell’alternativa o Dio o mammona, sceglie mammona, ossia le cose che possiede. Alla fine, invece della gioia di chi ha trovato il tesoro (cf. Mt 13,44), ha la tristezza di chi l’ha perduto.E’ difficile entrare nel regno di Dio per coloro che hanno ricchezze (v. 23) e anche per gli altri (v. 24). Un giorno Gesù aveva parlato di quelli che ricevono il seme della Parola tra le spine: «Sono coloro che hanno ascoltato la parola, ma sopraggiungono le preoccupazioni del mondo e l’inganno della ricchezza e tutte le altre bramosie, soffocano la parola e questa rimane senza frutto» (Mc 4,18–19). Le ricchezze, ma non solo le ricchezze, possono preoccupare e ingannare l’uomo e soffocare la parola di Dio nel suo cuore.Tutti siamo troppo grandi per entrare nel regno di Dio dove entrano solo i piccoli e i bambini: siamo cammelli che tentano buffamente di passare per la cruna di un ago. Riconoscere questa nostra impossibilità è già un buon punto di partenza per diventare piccoli.Salvarsi non è né facile né difficile: è assolutamente impossibile all’uomo. Solo Dio può salvarci. Il mestiere di Dio è fare ciò che è impossibile all’uomo. A noi non resta che chiedere, nonostante le nostre resistenze contrarie, questa salvezza impossibile che solo Dio può donarci.Non si sceglie la povertà per se stessa, non si lasciano le persone più care per il gusto di lasciarle: ciò sarebbe irragionevole, sarebbe un vero male. Se si sceglie di lasciare tutto e tutti è per qualcosa di più grande e soprattutto per Qualcuno più grande: per seguire Gesù e dedicare ideali, mente e cuore all’annuncio del vangelo. Sono queste le finalità che danno un senso alla povertà e al distacco. Nella povertà Gesù propone all’uomo la rinuncia al dio di questo mondo. La povertà è essenziale per seguire Cristo ed è indispensabile per avere la vita eterna (v. 17).In origine con l’espressione «il centuplo», forse, si intendeva la vita eterna, ma la comunità cristiana scorgeva questo centuplo già nel fatto che i discepoli di Cristo, rinunciando alla casa, alla famiglia e alle proprietà, ritrovavano una nuova famiglia e una casa nella comunità. Sebbene i credenti possano trovare una certa compensazione nei numerosi «fratelli, sorelle, madri e figli», come pure nell’assistenza materiale che ricevono in seno alla comunità, devono tuttavia sapere che quaggiù siamo ancora nel tempo delle persecuzioni, delle tribolazioni, della croce. Anche il fare della comunità la propria casa può nascondere delle insidie. Chi cerca nella comunione con i fratelli e le sorelle di fede una reale compensazione in cambio di ciò che ha lasciato, non ha ancora compreso la chiamata a seguire Gesù fino alla croce. Gesù si separò perfino dai discepoli più cari, morendo solo e abbandonato, per la salvezza di tutti. La comunità non è in primo luogo un rifugio per le persone sole, ma uno spazio dove si raccolgono coloro che rinunciano ai propri desideri per amore di Gesù e si mettono al servizio degli altri uomini. Essa non costituisce un cantuccio tranquillo e appartato dal mondo, ma un punto di partenza per andare verso il mondo.Le persecuzioni sono i test di fedeltà a Cristo e al vangelo. Il giorno in cui la comunità cristiana non fosse più perseguitata si potrebbero fare solo due ipotesi: o tutti sono diventati definitivamente cristiani, compreso il diavolo, o i cristiani non sono più tali.32 Mentre erano in viaggio per salire a Gerusalemme, Gesù camminava davanti a loro ed essi erano stupiti; coloro che venivano dietro erano pieni di timore. Prendendo di nuovo in disparte i Dodici, cominciò a dir loro quello che gli sarebbe accaduto: 33 «Ecco, noi saliamo a Gerusalemme e il Figlio dell’uomo sarà consegnato ai sommi sacerdoti e agli scribi: lo condanneranno a morte, lo consegneranno ai pagani, 34 lo scherniranno, gli sputeranno addosso, lo flagelleranno e lo uccideranno; ma dopo tre giorni risusciterà».35 E gli si avvicinarono Giacomo e Giovanni, i figli di Zebedèo, dicendogli: «Maestro, noi vogliamo che tu ci faccia quello che ti chiederemo». 36 Egli disse loro: «Cosa volete che io faccia per voi?». Gli risposero: 37 «Concedici di sedere nella tua gloria uno alla tua destra e uno alla tua sinistra». 38 Gesù disse loro: «Voi non sapete ciò che domandate. Potete bere il calice che io bevo, o ricevere il battesimo con cui io sono battezzato?». Gli risposero: «Lo possiamo». 39 E Gesù disse: «Il calice che io bevo anche voi lo berrete, e il battesimo che io ricevo anche voi lo riceverete. 40 Ma sedere alla mia destra o alla mia sinistra non sta a me concederlo; è per coloro per i quali è stato preparato».41 All’udire questo, gli altri dieci si sdegnarono con Giacomo e Giovanni. 42 Allora Gesù, chiamatili a sé, disse loro: «Voi sapete che coloro che sono ritenuti capi delle nazioni le dominano, e i loro grandi esercitano su di esse il potere. 43 Fra voi però non è così; ma chi vuol essere grande tra voi si farà vostro servitore, 44 e chi vuol essere il primo tra voi sarà il servo di tutti. 45 Il Figlio dell’uomo infatti non è venuto per essere servito, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti».Questo brano è l’ultima delle tre predizioni che scandiscono la terza parte del vangelo. Ormai, appare all’orizzonte la meta. Il discorso è dettagliato, chiaro ed esplicito. Il viaggio a Gerusalemme ha come termine la consegna del Figlio dell’uomo.C’è tutta una serie di sette verbi messi in fila con la semplice congiunzione «e». Sei – il numero dell’uomo – descrivono la nostra azione: condannare, consegnare, schernire, sputacchiare, flagellare, uccidere. E’ come la somma di tutto il male, che raggiunge il culmine nell’uccisione di Dio. Ma la parola definitiva non spetta a noi, ma a Dio: «dopo tre giorni risusciterà». Dio che ha detto la prima parola (Gen 1), si riserva di dire anche l’ultima (escatologia). Egli ci lascia liberi, ma ingloba la nostra azione nella sua, offrendoci un dono impensabile.Gesù, il Cristo sofferente, il Figlio di Dio ucciso e risorto, umiliato e innalzato, è il mistero della nostra fede. La croce di Gesù non è un incidente di percorso, da dimenticare nella risurrezione. Cristo fu esaltato proprio per la sua obbedienza fino alla morte, e alla morte di croce (Fil 2,8–9). Qui è il mistero di Dio.La reazione dei discepoli alla terza predizione della Passione è peggiore delle precedenti. Dopo la prima ci fu un forte diverbio tra Gesù e Pietro, il quale pensa secondo gli uomini e non secondo Dio (Lc 8,32–33). Dopo la seconda ci fu l’incomprensione e il mutismo da parte di tutti gli apostoli, intenti a litigare su chi fosse il più grande (Lc 9,32–33). Dopo la terza ci si aspetterebbe un minimo di comprensione. Ma è come se Gesù non avesse detto nulla. Anzi, due dei prediletti, Giacomo e Giovanni, invece di ascoltarlo e fare la sua volontà, vogliono che lui li ascolti e faccia la loro. E’ il capovolgimento del rapporto fondamentale della fede.Certe verità e certe conseguenze delle proprie scelte di vita sono dure da accettare. Ci si dichiara completamente disponibili a Dio, ma in realtà si continua ad avere i propri programmi e interessi personali e sogni di grandezza umana. Giacomo e Giovanni non pretendono di avere il posto di Gesù, ma vogliono essere i primi due dopo di lui. Un simile modo di agire in una comunità può solo suscitare rancori, gelosie, contrasti e divisioni.Gesù ritorna sul dovere dell’umiltà e del servizio e pone se stesso come modello da imitare. Egli non si mette nella logica dei grandi di questo mondo: non è venuto per essere servito, ma per servire e dare la sua vita per la salvezza di tutti. Egli riprende il discorso della croce e ne precisa il significato. Essa è: «servire e dare la propria vita in riscatto per tutti». Il termine «riscatto» rievoca un contesto giuridico: quando un uomo cade in schiavitù, o viene rapito e sequestrato, e non può pagare il riscatto, tocca al suo parente più prossimo pagare al suo posto. E’ quanto ha fatto Dio nei confronti d’Israele, liberandolo dalla schiavitù dell’Egitto e da tutte le schiavitù successive. In primo piano non c’è la giustizia, ma la solidarietà: il parente più prossimo non deve prendere le distanze, ma sentirsi coinvolto fino al punto di sostituirsi al parente caduto in schiavitù, fino a pagare per la sua liberazione, per la sua salvezza. Ecco la logica della croce: l’ostinata solidarietà di Dio rivelatasi a noi in Cristo.Il cammino della croce non è in primo luogo soffrire, ma servire e dare la vita per tutti. Il discepolo quindi deve seguire il Cristo, servo sofferente di Dio, fino al dono totale della vita per tutti: «Da questo abbiamo conosciuto l’amore: Egli ha dato la sua vita per noi; quindi anche noi dobbiamo dare la vita per i fratelli» (1Gv 3,16). Di conseguenza, nella Chiesa c’è una sola regola uguale per tutti: servire e dare la vita. E l’autorità dev’essere capita ed esercitata come situazione in cui la logica della croce si fa più chiara, più esplicita e più convincente.È giusto voler stare vicini al Signore, è bene desiderare di essere come Dio. Il male sta nel fatto che non conosciamo il vero Dio e crediamo di essere come lui proprio in quello che lui non è assolutamente. L’essenza di Dio, la sua Gloria, è l’amore che si fa servo e ultimo di tutti. Si sta vicino a Gesù, non cercando i primi posti, ma l’ultimo, perché egli si è fatto ultimo di tutti. La Gloria, sinonimo di Dio, in ebraico significa «peso». Il suo eccessivo amore, dall’alto dei cieli l’ha fatto scendere fino a noi, al di sotto di tutti noi: «Cristo Gesù, pur essendo di natura divina, non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio; ma spogliò se stesso, assumendo la condizione di servo e divenendo simile agli uomini; apparso in forma umana, umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce» (Fil 2,5–8). Ogni nostra esaltazione è vanagloria, vuoto, assenza di peso: la massima dissomiglianza da Dio. La sua «gloria» è l’abbassamento fino alla morte di croce, esaltazione dell’amore e fine di ogni vanagloria. Alla sua destra e alla sua sinistra, al posto di Giacomo e di Giovanni, saranno intronizzati due malfattori, fratelli e rappresentanti di tutti noi.«Voi sapete che coloro che sono ritenuti capi delle nazioni le dominano, e i loro grandi esercitano su di esse il potere» (v. 42). Questa situazione è ancora attuale. Simile spettacolo si ripete a tutti i livelli, dove ci sono uomini che danno egoisticamente la scalata al potere e abusano della loro autorità. L’istinto del dominare è profondamente presente nel cuore dell’uomo e lo corrompe. Gesù non è un rivoluzionario politico, ma mira a rivoluzionare i suoi discepoli nell’intimo del loro spirito, imponendo loro una legge fondamentale che non solo vieta il dominio, ma imprime alla loro comunità una fisionomia completamente nuova. Per essi vale il paradossale principio: «Chi si esalta sarà umiliato e chi si umilia sarà esaltato» (Lc 18,14). Questo principio è stato sperimentato nella vita di Cristo e ha funzionato: «Umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce. Per questo Dio l’ha esaltato e gli ha dato un nome che è al di sopra di ogni altro nome» (Fil 2,8–9).La morte di Gesù è l’atto più grande con il quale egli attua il suo servizio in favore degli uomini. Come Dio accolse il sacrificio del suo Figlio, così egli richiede a tutti coloro che entrano in alleanza con lui, la disponibilità all’identico servizio sull’esempio di Cristo.46 E giunsero a Gerico. E mentre partiva da Gerico insieme ai discepoli e a molta folla, il figlio di Timèo, Bartimèo, cieco, sedeva lungo la strada a mendicare. 47 Costui, al sentire che c’era Gesù Nazareno, cominciò a gridare e a dire: «Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me!». 48 Molti lo sgridavano per farlo tacere, ma egli gridava più forte: «Figlio di Davide, abbi pietà di me!».49 Allora Gesù si fermò e disse: «Chiamatelo!». E chiamarono il cieco dicendogli: «Coraggio! Alzati, ti chiama!». 50 Egli, gettato via il mantello, balzò in piedi e venne da Gesù. 51 Allora Gesù gli disse: «Che vuoi che io ti faccia?». E il cieco a lui: «Rabbunì, che io riabbia la vista!». 52 E Gesù gli disse: «Va’, la tua fede ti ha salvato». E subito riacquistò la vista e prese a seguirlo per la strada.Il lettore del vangelo sa ormai che le folle seguono Gesù, ma senza una fede profonda e con gli occhi chiusi nei confronti della sua missione. Il cieco Bartimeo, invece, crede in lui come figlio di Davide, con fede salda e imperturbabile, anche se i numerosi presenti tentano sgarbatamente di farlo tacere. Egli crede nella bontà e nella potenza di Gesù nelle quali cerca il soccorso di Dio.Il cieco è un emarginato. La sua professione di mendicante dimostra chiaramente che non può far nulla da sé e deve attendere tutto dagli altri. La molta folla intorno a Gesù è l’immagine della comunità che spesso non accoglie gli emarginati, ma li sgrida, li zittisce e li colpevolizza, credendo oltretutto di far bene. Ma Gesù impartisce un ordine chiaro: «Chiamatelo!». Nella preghiera del cieco, Gesù riconosce la fede, condizione necessaria per essere aggregato alla comunità che sale a Gerusalemme e alla croce. Appena acquistò la vista, divenne discepolo. Per seguire Gesù bisogna vedere bene e vederci chiaro.La domanda di Gesù: «Che vuoi che io ti faccia?» è la stessa che egli aveva rivolto a Giacomo e Giovanni (cf. Mc 10,36). La loro richiesta di posti d’onore contrasta con l’umile richiesta di Bartimeo: essi chiedevano di progredire nella cecità della loro superbia, egli chiede di avere la luce della fede che scruta nel Cristo crocifisso l’umiltà e la profondità di Dio.A questo punto del vangelo, Gesù rivolge anche a noi la stessa domanda che ha fatto al cieco: «Che vuoi che io faccia per te ?». E noi dobbiamo fare nostra la sua risposta: «Maestro, che io riabbia la vista !». Fine di tutta la catechesi di Gesù è portarci qui, dove si compie l’ultimo miracolo, quello definitivo: la guarigione dalla cecità e la vista della fede.Gesù è la luce del mondo (cf. Gv 8,12), il figlio di Davide che esercita la sua regalità usando misericordia, il Signore che dà la vista ai ciechi (Sal 146,8). L’invocazione del suo nome è la nostra salvezza (cf. At 2,21). Gesù significa «Dio salva». Egli ci salva perché è tutto misericordia rivolta alla nostra miseria.«Figlio di Davide, abbi misericordia di me» (v. 48). Questa espressione contiene tutta la preghiera, perché contiene tutto Dio. La misericordia è l’essenza di Dio. Egli non è misericordioso: è misericordia. Egli non ama i suoi figli in proporzione dei loro meriti, ma della loro miseria. E li ama uno ad uno (cf. Gal 2,30; 1Tim 1,15). Io, in persona, sono amato totalmente dal Padre in Gesù. L’amore non si divide, si moltiplica. L’amore di un padre non si divide per il numero dei figli, ma è tutto intero per ciascuno.Gettando il mantello, che era tutto per lui, questo povero segue Gesù, a differenza del ricco che, attaccato ai suoi beni, si allontanò triste (cf. Mc 10,22).
CAPITOLO 11
1 Quando si avvicinarono a Gerusalemme, verso Bètfage e Betània, presso il monte degli Ulivi, mandò due dei suoi discepoli 2 e disse loro: «Andate nel villaggio che vi sta di fronte, e subito entrando in esso troverete un asinello legato, sul quale nessuno è mai salito. Scioglietelo e conducetelo. 3 E se qualcuno vi dirà: Perché fate questo?, rispondete: Il Signore ne ha bisogno, ma lo rimanderà qui subito». 4 Andarono e trovarono un asinello legato vicino a una porta, fuori sulla strada, e lo sciolsero. 5 E alcuni dei presenti però dissero loro: «Che cosa fate, sciogliendo questo asinello?». 6 Ed essi risposero come aveva detto loro il Signore. E li lasciarono fare. 7 Essi condussero l’asinello da Gesù, e vi gettarono sopra i loro mantelli, ed egli vi montò sopra. 8 E molti stendevano i propri mantelli sulla strada e altri delle fronde, che avevano tagliate dai campi. 9 Quelli poi che andavano innanzi, e quelli che venivano dietro gridavano:Osanna! Benedetto colui che viene nel nome del Signore!10 Benedetto il regno che viene, del nostro padre Davide!Osanna nel più alto dei cieli!11 Ed entrò a Gerusalemme, nel tempio. E dopo aver guardato ogni cosa attorno, essendo ormai l’ora tarda, uscì con i Dodici diretto a Betània.I capitoli 11–13 presentano un dramma che da gran tempo era nell’aria. Fino da 3,6, infatti, Marco aveva rivelato il complotto dei farisei e degli erodiani per fare morire Gesù. In 3,22, degli scribi «discesi da Gerusalemme» lo avevano accusato di essere posseduto da Beelzebul e in 7,1 egli si era opposto a dei «farisei e scribi venuti da Gerusalemme» per certe questioni di purità. La città di Gerusalemme appare, dunque, come la roccaforte dell’opposizione.Gerusalemme e il tempio sono il cuore dell’ebraismo: è qui che dovrebbe avvenire l’accoglienza ed invece è qui che si consuma il rifiuto. Tutta la sezione è imperniata sulla contrapposizione fra la salvezza offerta da Gesù a Gerusalemme e la sorte dolorosa che Gerusalemme riserva a Gesù.Ci troviamo di fronte a due delusioni. Gesù è deluso: nel tempio cerca qualcosa che non trova (11,11). Ma anche Gerusalemme è delusa: aspettava un Messia tutto diverso da questo. Sono due delusioni di vecchia data. Sono note le lamentele di Israele contro Dio lungo tutta la storia della salvezza, e nelle pagine bibliche risuona, puntualmente, anche la delusione di Dio (cf. Is 5,3–7). Due delusioni che nascono da motivi opposti. Israele vorrebbe la libertà senza pagarne il prezzo e, soprattutto, vorrebbe un Dio a immagine dei propri desideri. Dio vorrebbe fare di Israele un popolo suo testimone. Ciò che non cessa mai di sorprendere è l’ostinazione di Dio in questa impresa: si ostina a costruire con materiale tanto friabile, con mattoni così refrattari allo scopo.Il monte degli Ulivi ci fa pensare alla visione di Zaccaria che descrive la venuta di Iahvè, in occasione dello scontro escatologico fra Gerusalemme e le nazioni: «In quel giorno i suoi piedi si poseranno sopra il monte degli Ulivi che sta di fronte a Gerusalemme ad oriente» (Zc 14,4). Gerusalemme attende la visita di Dio e la lotta decisiva della storia. È dunque un contesto di giudizio che dà la tonalità a tutta la sezione.Gesù prepara il suo ingresso a Gerusalemme con la stessa cura con cui preparerà la celebrazione pasquale (14,12–16). Questi due passi sono paralleli: invio di due discepoli con precise istruzioni, ed esecuzione della loro missione secondo il programma prestabilito.Il Messia si presenta con modestia come re di pace universale. Matteo 21,5 cita esplicitamente Zc 9,9. Parlando di un puledro legato, forse l’evangelista pensa alla benedizione di Giacobbe riguardante Giuda: «Non sarà tolto lo scettro da Giuda né il bastone del comando tra i suoi piedi, finché verrà colui al quale esso appartiene e a cui è dovuta l’obbedienza dei popoli. Egli lega alla vite il suo asinello e a scelta vite il figlio della sua asina ...» (Gen 49,10–11). Questo testo è stato interpretato in senso messianico dalla tradizione rabbinica. Infine, il fatto che l’animale non sia mai stato montato denota che deve servire per un uso religioso (cf 1Sam 6,7; 2Re 2,20; Nm 19,2; Dt 21,3).Gesù si designa come «Signore», titolo che Marco gli attribuisce con parsimonia nel resto del vangelo (7,28; 12,36–37). In questo modo intende manifestare la consapevolezza che Gesù ha di realizzare la profezia messianica di Zaccaria.All’iniziativa del Maestro, si aggiunge un gesto dei discepoli, ispirato all’antico rituale d’intronizzazione regale: così, in occasione della consacrazione di Ieu, i dignitari stesero i mantelli sul percorso (2Re 9,13), riconoscendo in lui l’eletto di Iahvè. Questo segno di vassallaggio esprimeva la sottomissione, ma anche la speranza di beneficiare della saggia amministrazione del re e di condividerne la sua gloria.Questa allusione al salmo 118,27, che descrive la solenne processione della festa delle capanne o dei tabernacoli (Lv 23,40), sottolinea la natura religiosa, più che politica, di questa accoglienza fatta a Gesù.Rievocando la marcia d’Israele nel deserto e il periodo del suo fidanzamento con Dio (Lv 23,42; Ger 2,2), la festa delle capanne celebrava la regalità universale di Iahvè ed esaltava la speranza del Re–Messia. Il profeta Zaccaria aveva annunciato che il Regno di Dio si sarebbe esteso a tutte le genti, le quali si sarebbero recate ogni anno a Gerusalemme per partecipare alla festa delle capanne (Zc 14,16–19). Anche l’acclamazione della folla, tratta dal salmo 118, assume un accento messianico.L’espressione ebraica hoshia’–na (in aramaico hosa’–na) è originariamente un’invocazione di aiuto nelle difficoltà: «aiuto, ti prego!» o «salva, ti preghiamo!» (2Sam 14,4; 2Re 6,26), ma, in questo brano evangelico, sembra diventata un grido di acclamazione senza alcun riferimento al suo significato originale.L’espressione «colui che viene» richiama la proclamazione di Giovanni Battista (1,7; Mt 11,2) ed evoca la benedizione di Giacobbe per suo figlio Giuda (Gen 49,10) e la profezia di Zaccaria che fa allusione anche al Re–Messia che viene verso la figlia di Sion (Zc 9,9).L’espressione «il regno che viene, del nostro padre Davide» equivale a proclamare Gesù re discendente di Davide (cf. 10,47–48).«Osanna nel più alto dei cieli!» significa: Osanna a Dio! Sottolinea la natura religiosa di questo evento e relega nello sfondo qualsiasi motivo politico. Qualcuno ha tradotto «Osanna nel più alto dei cieli» con «Salvaci dal romano». La vocalizzazione delle consonanti ebraiche lo permette. Forse qualche zelota lo avrà gridato con questo significato. L’espressione «Benedetto il regno che viene, del nostro padre Davide!» non poteva non avere un senso politico. Non sembra che tutto questo però sia nella linea intesa da Marco in tutto il suo vangelo.Tutti questi collegamenti con l’Antico Testamento contribuiscono a presentare l’ingresso di Gesù in Gerusalemme come la celebrazione liturgica dell’intronizzazione del Figlio di Davide. Gesù è l’erede autentico della promessa fatta da Dio a Davide per mezzo del profeta Natan (2Sam 7,12–16; 23,5; cf. Lc 1,32–33) e ripresa da Isaia (7,13–14). Egli la realizza instaurando definitivamente il Regno atteso, in modo ben diverso, tuttavia, da come si sperava, poiché il Messia entra nella città di Davide per morirvi.Il seguito naturale dell’ingresso trionfale di Gesù sembrerebbe la cacciata dei profanatori dal tempio e l’attacco contro le autorità giudaiche. Marco, invece, interrompe questa sequenza, inserendo nel racconto della purificazione del tempio la maledizione della pianta di fico: entrambi i gesti simboleggiano il giudizio di Dio contro Israele.L’espressione «dopo aver guardato ogni cosa attorno» non è lo sguardo di un turista curioso, ma quello di un giudice che penetra le intenzioni e discerne le situazioni con verità. In questo caso bisogna vederci lo sguardo di chi sta preparando il colpo per l’indomani: la cacciata dei mercanti!«Uscì con i Dodici diretto a Betania». Questo ritorno a Betania, nonostante l’ora tarda, è una misura di prudenza presa da Gesù che si sentiva spiato, anzi braccato, entro le mura della città.In questo episodio è l’unica volta che Gesù chiama se stesso «Signore», ed è l’unica volta che dice di avere bisogno: ha bisogno di un asino.Questo episodio sintetizza quanto Gesù ha fatto finora e farà in seguito, illuminando il suo modo di realizzare il Regno.Ci si aspettava che il Signore venisse con gloria e potenza, prendendo il dominio su tutto. Ma la sua gloria è l’umiltà, la sua potenza è l’amore, il suo dominio è il servizio. Non viene con il cavallo, come il re che tiene il potere. Non viene con il carro da guerra, come chi desidera conquistare il potere. «Umile, cavalca un asino, un puledro figlio di asina» (Zc 9,9).Le caratteristiche dell’asinello, vero protagonista del racconto, sono le stesse del messianismo di Gesù. Il somaro, che porta la soma degli altri, è un’immagine di Gesù, che porta i nostri pesi e ci comanda di fare altrettanto: «Portate i pesi gli uni degli altri, così adempirete la legge di Cristo» dice Paolo in Gal 6,2. Questo essere schiavi per amore, somari per amore, è la vera libertà (Gal 5,13–14).Gesù è il Re che libera. È Re in quanto servo. È Signore in quanto schiavo. Il suo Regno in terra viene nell’essere servi e schiavi gli uni degli altri per amore.Servire è regnare, e regnare è servire.12 La mattina seguente, mentre uscivano da Betània, ebbe fame. 13 E avendo visto di lontano un fico che aveva delle foglie, si avvicinò per vedere se mai vi trovasse qualche cosa; ma giuntovi sotto, non trovò altro che foglie. Non era infatti quella la stagione dei fichi. 14 E gli disse: «Nessuno possa mai più mangiare i tuoi frutti». E i discepoli l’udirono.15 Andarono intanto a Gerusalemme. Ed entrato nel tempio, si mise a scacciare quelli che vendevano e comperavano nel tempio; rovesciò i tavoli dei cambiavalute e le sedie dei venditori di colombe 16 e non permetteva che si portassero cose attraverso il tempio. 17 Ed insegnava loro dicendo: «Non sta forse scritto: La mia casa sarà chiamata casa di preghiera per tutte le genti? Voi invece ne avete fatto una spelonca di ladri!».18 L’udirono i sommi sacerdoti e gli scribi e cercavano il modo di farlo morire. Avevano infatti paura di lui, perché tutto il popolo era ammirato del suo insegnamento. 19 Quando venne la sera uscirono dalla città.20 La mattina seguente, passando, videro il fico seccato fin dalle radici. 21 Allora Pietro, ricordatosi, gli disse: «Maestro, guarda: il fico che hai maledetto si è seccato». 22 Gesù allora disse loro: «Abbiate fede in Dio! 23 In verità vi dico: chi dicesse a questo monte: Lèvati e gettati nel mare, senza dubitare in cuor suo ma credendo che quanto dice avverrà, ciò gli sarà accordato. 24 Per questo vi dico: tutto quello che domandate nella preghiera, abbiate fede di averlo ottenuto e vi sarà accordato. 25 Quando vi mettete a pregare, se avete qualcosa contro qualcuno, perdonate, perché anche il Padre vostro che è nei cieli perdoni a voi i vostri peccati».La maledizione del fico è un fatto parabolico: la parabola viene tradotta in un gesto esemplare che la rende viva e comprensibile non solo alle orecchie, ma anche agli occhi. È un fatto parabolico che esprime plasticamente il giudizio di Dio su Israele. L’informazione «non era quella la stagione dei fichi» (11,13) rende assurda la pretesa di Gesù.. Marco non cerca di nascondere la stranezza del gesto, anzi la sottolinea. E noi dobbiamo capire subito che, se Gesù si fosse limitato a maledire un fico che non poteva avere dei frutti perché non era la stagione giusta, il suo gesto potrebbe sembrare non solo strano, ma demenziale. Non è dunque su questo piano che va cercato il senso. Nell’Antico Testamento, il fico e la vigna rappresentano il popolo d’Israele (Is 5,1–7; 28,4; Os 9,10 Ger 8,13). Vogliamo citare due versetti del profeta Michea che descrivono il senso preciso della fame di Gesù (Mc 11,12): «Ahimè! Sono diventato come uno spigolatore d’estate, come un racimolatore dopo la vendemmia! Non un grappolo da mangiare, non un fico per la mia voglia. L’uomo pio è scomparso dalla terra, non c’è più un giusto tra gli uomini» (Mi 7,1–2). Non è dunque la sterilità del fico che interessa, ma quella d’Israele.E Israele non ha scuse: è già stato più volte rimproverato e dovrebbe sapere quali sono i frutti che Dio vuol cogliere. Marco ce lo dice attraverso l’episodio del tempio e le parole sulla fede.Dunque il simbolismo di base parte dalla parola «frutto» (v. 13). Quell’albero che si rivela senza frutto è il simbolo del tempio, centro religioso del popolo d’Israele, in cui Gesù è venuto a cercare i frutti che non ha trovato. Poco più avanti, la parabola del figlio unico, inviato a raccogliere i frutti della vigna, confermerà il simbolismo (12,1–11). Ripetiamo dunque: non è la sterilità del fico che viene giudicata, ma la sterilità di Gerusalemme e del suo culto. Come i discepoli «videro il fico seccato dalle radici» (11,20), così vedranno il tempio distrutto fin dalle fondamenta: «Non rimarrà qui pietra su pietra che non sia distrutta» (13,2).«Entrato nel tempio, si mise a scacciare quelli che vendevano e comperavano...». Gesù entra di nuovo a Gerusalemme e nel tempio, e ne prende possesso con un gesto profetico significativo della sua autorità messianica. Già i profeti erano insorti contro il culto ipocrita dei praticanti assidui nella frequenza del tempio, ma incuranti della religione autentica (Is 1,11–17; 29,13–14; Ger 7,1–11). Come aveva fatto Neemia in occasione del suo viaggio di ispezione a Gerusalemme (Ne 13,7–9), Gesù purifica la casa di Dio e ne scaccia i venditori che hanno trasformato l’atrio del tempio in luogo di commercio. Questo gesto è un insegnamento e un adempimento della Scrittura. Si pensi alle ultime parole del libro di Zaccaria che, ispirato alla visione finale del profeta Ezechiele (capitoli 40–48), annuncia la festa universale dei tabernacoli, celebrata nei tempi messianici in un tempio definitivamente purificato: «In quel giorno non vi sarà neppure un Cananeo (mercante) nella casa del Signore degli eserciti» (Zc 14,21).Questa purificazione esteriore suppone una purificazione nel servizio sacro e nel sacerdozio, come indica la profezia di Malachia: «Subito entrerà nel suo tempio il Signore ... Sederà per fondere e purificare; purificherà i figli di Levi, li affinerà come oro e argento, perché possano offrire al Signore un’oblazione secondo giustizia» (MI 3,1–3). Queste reminiscenze dell’Antico Testamento indicano la portata messianica del racconto.«E non permetteva che si portassero cose attraverso il tempio». È noto che non tutto il tempio era luogo di mercato, ma solo il grande cortile esterno chiamato «cortile dei gentili», cioè dei non ebrei. Israele l’aveva reso luogo di commercio e di traffico (si usava attraversarlo per passare da un quartiere all’altro della città; era la scorciatoia tra la città e il monte degli Ulivi: il disordine è facilmente immaginabile!) e in questo modo i gentili non avevano più un luogo di preghiera nel tempio del Signore. Questo atrio era separato dall’atrio riservato agli ebrei da un parapetto in pietra, con iscrizioni in greco e latino che interdicevano ai pagani l’accesso all’atrio interno: «Chiunque sarà preso dovrà attribuire a se stesso la morte che subirà come punizione».. Una di queste pietre è stata portata al museo di Istambul nel 1871; una seconda, ritrovata nel 1935, si trova nel museo di Gerusalemme. La citazione di Isaia nel versetto seguente sottolinea, appunto, che il tempio è casa di preghiera per tutte le genti e quindi anche l’atrio riservato ai pagani è santo come quello riservato agli ebrei.«La mia casa sarà chiamata casa di preghiera per tutte le genti». Marco ha scritto il suo vangelo per i pagani convertiti e, quindi, non ci deve meravigliare che citi l’intero versetto di Isaia 56,7, inclusa la frase «per tutte le genti», che Matteo e Luca tralasciano.«Una spelonca di ladri». Ai tempi di Gesù, i mercanti avevano la stessa fama che hanno oggi, e i cambiavalute non erano additati come una categoria di onesti. Ma non è questo il problema. L’espressione, di per sé, non accusa di essere ladri quelli che sono nel tempio, ma li paragona a dei ladri che cercano rifugio nel tempio, come in una spelonca, per sfuggire al castigo di Dio meritato con la loro condotta. Il significato viene chiarito molto bene se leggiamo per intero il testo di Geremia che rimprovera ogni sorta di infrazioni contro l’alleanza (cf. Ger 7,1–15). In definitiva, Gesù, citando Geremia, intende dire: «Il culto del tempio è menzognero se serve soltanto a dare un senso di sicurezza a gente che non si converte».«L’udirono i sommi sacerdoti e gli scribi e cercavano il modo per farlo morire». Ritroviamo qui la situazione già provocata da Gesù nel suo uditorio di Cafarnao, in occasione della sua manifestazione inaugurale: le folle stupite di fronte al suo insegnamento dato con autorità (1,22.27), e gli avversari che decidono di farlo morire (3,6).«Avevano paura di lui». È la paura di Adamo (Gen 3,10) e di Erode (Mt 2,3), la paura di chi non vuole Dio tra i piedi perché teme di perdere la supremazia: è la paura di riconoscere un Dio sopra la propria testa, la paura di perdere il posto di padroni degli altri e di Dio stesso, fatto a propria immagine e manovrato a proprio piacimento. È la paura di perdere l’eredità (12,7): da affittuari (12,1) volevano diventare usurpatori. È la tentazione gravissima, e sempre ricorrente, a cui sono esposti tutti i ministri della religione. Contro di essa ci mette in guardia l’apostolo Pietro: «Esorto gli anziani (= vescovi e preti) che sono tra voi ... : pascete il gregge di Dio che vi è affidato, sorvegliandolo non per forza, ma volentieri, secondo Dio; non per vile interesse, ma di buon animo; non spadroneggiando sulle persone a voi affidate, ma facendovi modelli del gregge» (1Pt 5,1–3). La mentalità di padroni della religione e di coloro che la praticano, manifestata dai sommi sacerdoti e dagli scribi, contro cui ha cozzato duramente Gesù, è tutt’altro che morta!«Quando venne la sera uscirono dalla città». Gesù prende le distanze dalla città che non lo riconosce per quello che egli è. Aveva fatto la stessa cosa nei confronti delle folle entusiaste nell’ascoltarlo, ma non disposte a comprenderlo (1,38; 3,9; 4,11.36; 6,45; 8,13).Il tempio era il centro del culto e del potere politico ed economico. La «purificazione» del tempio è figura della purificazione della nostra immagine di Dio, inquinata dai nostri deliri di potere, di ricchezza e di superbia. Oltre al commercio materiale, nel tempio c’è anche il commercio spirituale. È quello che, con la moneta sonante delle prestazioni e delle osservanze, intende comperare la grazia di Dio. È un male gravissimo, figlio del grande peccato originale che, dipingendo un Dio cattivo, induce a placarlo e ottenere le grazie dietro pagamento, come fosse una prostituta. È il peccato del giusto, che va direttamente contro l’essenza di Dio che è amore gratuito. Dio perdona senza limiti il peccatore e non si fa suo giudice, ma neanche può farsi suo complice nel peccato. Dio non può avallare le nostre malefatte. Il tempio o è casa di preghiera o è spelonca di ladri. E siccome tutto ciò che è accaduto a Israele è come un esempio per noi, scritto a nostro ammaestramento (1Cor 10,11), la Chiesa deve vigilare per non cadere nella stessa infedeltà.«La mattina seguente, passando, videro il fico seccato fin dalle radici. Pietro ricordatosi...». Nell’Antico Testamento, il ricordo è uno dei veicoli principali della rivelazione di Dio, e può essere considerato come un elemento essenziale dell’alleanza (Dt 4,9–15; Gs 24,1–13). Specialmente nel Deuteronomio, gli israeliti sono invitati a ricordare le passate azioni divine di misericordia come la base per la loro attuale fedeltà a Lui (Dt 4,32–40; 5,15; 6,20–25; 7,6–11; 8,2–6; 9,1–7; 29,1–8; 32,7). In Mc 8,18 Gesù aveva chiesto con forza: «E non vi ricordate....?», come un invito a fare una riflessione sui due miracoli del pane, perché i discepoli potessero capire chi egli fosse. Qui qualcosa sta muovendosi. Pietro comincia a ricordare, a fare attenzione, a riflettere, a collegare le parole e gli avvenimenti. E proprio questo impegno e questa capacità di ricordare sarà l’inizio del suo ravvedimento dopo aver rinnegato tre volte il Maestro: «Allora Pietro si ricordò di quella parola che Gesù gli aveva detto: «Prima che il gallo canti due volte, mi rinnegherai per tre volte». E scoppiò in pianto» (14,72).«Il fico che tu hai maledetto si è seccato». Gesù dopo aver seccato il fico secca e taglia di netto anche il discorso sull’argomento. Trascurando il fico, parla dell’importanza della preghiera fatta con fede. Il termine «preghiera» ci mette sulla buona strada perché rimanda alla scena della purificazione del tempio, destinato a diventare «casa di preghiera per tutte le genti» (11,17). il fico sterile è l’immagine della fede infeconda, della fedeltà puramente esteriore alla legge, della preghiera degli ipocriti (Mt 6,5).«Tutto quello che domandate nella preghiera, abbiate fede di averlo ottenuto e vi sarà accordato». Credere significa lasciarsi investire dalla potenza irresistibile di Gesù, che sconvolge il mondo, come aveva annunziato il profeta Zaccaria (4,7; 14,4). È in questo contesto che trova il suo vero significato la frase evangelica della fede che può tutto. Credere che ciò che si proclama sta avvenendo significa cogliere la presenza di Gesù, che sta operando attraverso la nostra azione: è questa la potenza della fede che diventa preghiera esaudita e fattiva.«Se avete qualcosa contro qualcuno, perdonate, perché anche il Padre vostro che è nei cieli perdoni a voi i vostri peccati». È l’unica volta, nel vangelo di Marco, in cui Gesù dichiara ai discepoli che il Padre suo è anche il loro. Gesù è più che figlio di Davide (10,47–48; 11,10; 12,35–37): è il vero Figlio di Dio che comunica ai suoi la propria realtà filiale. Abbiamo qui l’equivalente della quinta domanda del Padre nostro secondo Matteo (6,12). Alcuni manoscritti, infatti, aggiungono a questo punto un versetto (il 26) che ricalca esattamente la spiegazione riferita da Mt 6,15: «Ma se voi non perdonate, neppure il Padre vostro che è nei cieli perdonerà le vostre colpe» (11,26). Ciò dimostra che la preghiera del «Padre nostro» era ben nota alla Chiesa di Marco benché egli non la citi nella sua interezza.Il fico è stato seccato per istruire i discepoli sulla fede; il tempio è stato purificato per diventare casa di preghiera. Alla sterilità del fico corrisponde il pullulare di affari nel tempio. Infecondità nel bene e fecondità nel male vanno di pari passo.In questo brano si parla della fede e della preghiera, radici da cui viene il frutto dello Spirito, che essenzialmente è amore e perdono. Credere non è solo sapere che c’è un Dio, essere supremo e buono, onnipotente e onnisciente, sovrano e giudice di tutti. È aderire a Gesù e alla sua Parola, perché lui è il Signore, l’interlocutore fondamentale della nostra vita.La fede si esprime come preghiera verso Dio e perdono verso i fratelli. Non ci può essere l’una senza l’altro.Il cristiano è colui che ha fede in Gesù, potenza e sapienza di Dio, proprio nella sua debolezza. Gesù non chiede la fede in qualche idea, ma nel Dio che si rivela in lui, povero e umile che finisce sulla croce.27 Andarono di nuovo a Gerusalemme. E mentre egli si aggirava per il tempio, gli si avvicinarono i sommi sacerdoti, gli scribi e gli anziani e gli dissero: 28 «Con quale autorità fai queste cose? O chi ti ha dato l’autorità di farlo?». 29 Ma Gesù disse loro: «Vi farò anch’io una domanda e, se mi risponderete, vi dirò con quale potere lo faccio. 30 Il battesimo di Giovanni veniva dal cielo o dagli uomini? Rispondetemi». 31 Ed essi discutevano tra sé dicendo: «Se rispondiamo «dal cielo», dirà: Perché allora non gli avete creduto? 32 Diciamo dunque «dagli uomini»?». Però temevano la folla, perché tutti consideravano Giovanni come un vero profeta. 33 Allora diedero a Gesù questa risposta: «Non sappiamo». E Gesù disse loro: «Neanch’io vi dico con quale autorità faccio queste cose».Nei primi 26 versetti di questo capitolo Gesù aveva espresso il suo giudizio su Gerusalemme, il tempio e la falsa religiosità, con dei gesti, dei fatti (entrata in Gerusalemme, fico seccato, purificazione del tempio). Da 11,27 a 12,37 il suo giudizio viene espresso con le parole.L’agire di Gesù ha suscitato una reazione violenta da parte dei padroni della religione. Era entrato nel tempio senza chiedere permesso, come uno che entra in casa propria; aveva scacciato venditori e cambiavalute muniti di regolare permesso rilasciato dall’autorità; aveva messo sotto accusa il modo di far religione: il tempio non era più casa di preghiera, ma spelonca di ladri. Davanti a una simile accusa il potere costituito non poteva tacere. E non tacque.«Con quale autorità fai queste cose? O chi ti ha dato l’autorità per farle?» Nel contesto, la domanda si riferisce all’ingresso di Gesù in Gerusalemme e all’espulsione dei mercati dal tempio. Ma in pratica viene coinvolta tutta la sua attività. Perciò anche la domanda delle autorità giudaiche supera il quadro immediato nel quale è stata posta: il processo contro Gesù è già iniziato.«Vi farò anch’io una domanda». Il processo si capovolge e gli accusatori sono messi sotto accusa e invitati a rendere conto del loro comportamento. Gesù non pone una contro–domanda per sfuggire alle domande dei suoi avversari, ma per rendere possibile una risposta: non si capisce Gesù se prima non si è capito Giovanni il Battista. Se infatti Giovanni è venuto da Dio per preparare la strada al Messia, Gesù agisce con l’autorità che gli compete come Messia, ed è Dio che gli ha dato questa autorità. Ora essi non vogliono assolutamente ammettere questo: per loro Gesù non rivela il vero volto di Dio e perciò deve morire perché è un bestemmiatore. Su questa loro decisione essi non sono disposti a ritornare e rimangono ostili alla rivelazione di Gesù.Cosa farà Gesù? Li lascerà senza una risposta? Sembrerebbe di sì: «Gesù disse loro: ‘Neanch’io vi dico con quale autorità faccio queste cose’ «. In realtà Gesù risponde con la parabola dei vignaioli omicidi, che troviamo immediatamente dopo questo brano. E tutti e tre i sinottici dichiarano che i suoi interlocutori compresero che aveva detto quella parabola per loro (Mt 21,45; Mc 12,12; Lc 20,19).
CAPITOLO 121 Gesù si mise a parlare loro in parabole: «Un uomo piantò una vigna, vi pose attorno una siepe, scavò un torchio, costruì una torre, poi la diede in affitto a dei vignaioli e se ne andò lontano. 2 A suo tempo inviò un servo a ritirare da quei vignaioli i frutti della vigna. 3 Ma essi, afferratolo, lo bastonarono e lo rimandarono a mani vuote. 4 Inviò loro di nuovo un altro servo: anche quello lo picchiarono sulla testa e lo coprirono di insulti. 5 Ne inviò ancora un altro, e questo lo uccisero; e di molti altri, che egli ancora mandò, alcuni li bastonarono, altri li uccisero. 6 Aveva ancora uno, il figlio prediletto: lo inviò loro per ultimo, dicendo: Avranno rispetto per mio figlio! 7 Ma quei vignaioli dissero tra di loro: Questi è l’erede; su, uccidiamolo e l’eredità sarà nostra. 8 E afferratolo, lo uccisero e lo gettarono fuori della vigna. 9 Che cosa farà dunque il padrone della vigna? Verrà e sterminerà quei vignaioli e darà la vigna ad altri. 10 Non avete forse letto questa Scrittura:La pietra che i costruttori hanno scartata è diventata testata d’angolo;11 dal Signore è stato fatto questo ed è mirabile agli occhi nostri»?12 Allora cercarono di catturarlo, ma ebbero paura della folla; avevano capito infatti che aveva detto quella parabola contro di loro. E, lasciatolo, se ne andarono.L’immagine della vigna, designa spesso nei profeti il popolo di Israele. Il cantico della vigna (Is 5,1–7) era nella memoria di tutti: il profeta ne aveva fatto una parabola di giudizio per i capi di Gerusalemme e gli abitanti della Giudea.Non c’è molta differenza tra questi vignaioli e i falsi pastori di Ez 34, che invece di pascere le pecore pascono se stessi. Nell’uno e nell’altro caso, coloro che Dio ha posto come suoi rappresentanti in mezzo al popolo sfruttano la loro posizione a proprio beneficio.La citazione del salmo 118: «La pietra che i costruttori hanno scartato è diventata testata d’angolo» vuol dire che Dio è capace di annullare l’azione degli uomini e di capovolgerne il risultato. Gli uomini hanno ucciso suo Figlio, ma Dio l’ha risuscitato: «Dal Signore è stato fatto questo ed è mirabile agli occhi nostri!».Con questa parabola allegorica, Gesù dà la chiave di lettura della storia di Israele e della storia di ogni uomo, come scontro senza incontro tra la fedeltà di Dio e l’infedeltà dell’uomo. La sua offerta d’amore si trova sempre davanti il muro del nostro rifiuto ostinato.Alla sua crescente bontà corrisponde un crescendo della nostra cattiveria. Sembra proprio un amore infelice, senza possibilità di riuscita. Ma il Signore opera una meraviglia ai nostri occhi, facendo della croce, che è il vertice del nostro male e del nostro peccato, il dono del suo massimo amore e del suo perdono. Noi lo uccidiamo togliendogli la vita, e lui ci fa vivere donandoci la sua vita.La nostra malvagità non vanifica il suo piano di salvezza. Tutto il nostro male e quello della storia umana non fa fallire il disegno di Dio, ma lo compie in un modo più sublime, mostrando il suo potere che è solo e tutto misericordia.Il potere dell’uomo è quello di fare il male dal bene; quello di Dio è di fare il bene dal male. Egli vorrebbe diversamente, ma rispetta la nostra libertà. Egli è Dio proprio perché sa colmare la nostra miseria con la sua misericordia, rispondendo al nostro rifiuto con la sua offerta incondizionata d’amore. È la vittoria della croce, scontro inevitabile, che diventa incontro definitivo.Gesù è il Figlio unigenito che si è fatto servo e ultimo di tutti, dando la vita per noi che gli diamo la morte. Questo è il suo potere: la sua fedeltà al di là di ogni nostra infedeltà.13 Gli mandarono però alcuni farisei ed erodiani per coglierlo in fallo nel discorso. 14 E venuti, quelli gli dissero: «Maestro, sappiamo che sei veritiero e non ti curi di nessuno; infatti non guardi in faccia agli uomini, ma secondo verità insegni la via di Dio. È lecito o no dare il tributo a Cesare? Lo dobbiamo dare o no?». 15 Ma egli, conoscendo la loro ipocrisia, disse: «Perché mi tentate? Portatemi un denaro perché io lo veda». 16 Ed essi glielo portarono. Allora disse loro: «Di chi è questa immagine e l’iscrizione?». Gli risposero: «Di Cesare». 17 Gesù disse loro: «Rendete a Cesare ciò che è di Cesare e a Dio ciò che è di Dio». E rimasero ammirati di lui.I farisei e gli erodiani cercano di cogliere in fallo Gesù ponendogli una domanda alla quale sembra impossibile rispondere senza incorrere in gravi conseguenze: «È lecito o no dare il tributo a Cesare?».Rispondere di no sarebbe pericoloso perché trasformerebbe Gesù in un sobillatore politico; rispondere di sì sarebbe altrettanto pericoloso perché lo farebbe apparire come un collaborazionista, amico degli odiati occupanti romani.La risposta supera il livello al quale il problema era stato posto. Gesù non dà una ricetta per un comportamento civico; non raccomanda né la rassegnazione di fronte all’ordine costituito (punto di vista dei farisei) né il rifiuto (opinione degli zeloti) e neppure benedice lo stato imperiale (tendenza degli erodiani).La sua duplice dichiarazione constata, da una parte, l’esistenza di regole provvisorie sulla terra e, dall’altra, invita ad adottare nei confronti di esse un atteggiamento critico: distinguere tra l’accessorio e il principale, tra il relativo e l’assoluto, tra il transeunte e l’eterno, tra le realtà penultime e quelle ultime.La decisione apolitica di Gesù contiene un invito all’azione responsabile in favore della società umana, senza riduzioni o esaltazioni indebite, conformemente alla volontà di Dio.La risposta di Gesù non è una semplice astuzia per eludere il problema e non cadere nel tranello teso dai farisei e dagli erodiani. Non dice semplicemente: «Date a ciascuno ciò che gli spetta», senza determinare ciò che spetta a ciascuno.A quei tempi il dominio di un sovrano si estendeva ovunque la sua moneta aveva corso legale. Era ovvio che dove circolava la moneta di Cesare, si sottostava al dominio di Cesare e si rispettavano le regole del gioco, tra le quali quella di pagargli il tributo (cf. Rm 13,1–7; 1Pt 2,13ss).Per Gesù il problema è un altro: dare a Dio ciò che è di Dio. Come la moneta del tributo porta l’immagine di Cesare e appartiene a Cesare, così l’uomo è immagine di Dio e appartiene a Dio. Il tributo da pagargli è quello di darsi a lui, amando lui con tutto il cuore e il prossimo come se stessi (Mc 12,30–31).Circa l’autorità civile, è giusto distinguere il contenuto dal modo. Il suo contenuto è quello di servire al bene comune; in questo senso, anche se le sue forme sono storicamente più o meno imperfette, è legittimamente voluta da Dio (cf. Rm 13,1–4).Normalmente, il modo nel quale è esercitata è quello dei capi delle nazioni (cf. Mc 10,42), che bramano l’avere, il potere e l’apparire. Questo modo non è voluto da Dio. Esso schiavizza tutti, sia chi lo esercita sia chi lo subisce, togliendo a tutti, dominatori e dominati, la libertà, che è proprio ciò per cui siamo a immagine e somiglianza di Dio.Questo brano ci aiuta a capire il «potere» di Cristo che mette sempre in crisi quello dell’uomo. Esso infatti è amore, servizio e umiltà.Gesù ci dà un criterio in base al quale fare le nostre scelte: prima dare a Dio ciò che è di Dio. Solo così sapremo cosa dare al Cesare di turno.L’uso del denaro è l’accettazione implicita del potere di chi l’ha coniato. Gesù non ha con sé la moneta, a differenza dei farisei e degli erodiani. Le loro parole non presentano quindi un vero problema per loro, che possiedono molto volentieri le monete con l’iscrizione di Cesare. Le tasse fanno problema a quelli che hanno i soldi, non ai poveri. Inoltre l’iscrizione sulla moneta porta il nome e il ruolo divino dell’imperatore: Tiberio Cesare Imperatore, figlio del divino Augusto.Il titolo regale di Gesù non lo troveremo scritto su alcuna moneta, ma sulla croce (Mc 15,26). Chi ha orecchi per intendere, intenda!Ma il problema fondamentale è che l’uomo, immagine di Dio, è di Dio e deve ritornare a lui.18 Vennero a lui dei sadducei, i quali dicono che non c’è risurrezione, e lo interrogarono dicendo: 19 «Maestro, Mosè ci ha lasciato scritto che se muore il fratello di uno e lascia la moglie senza figli, il fratello ne prenda la moglie per dare discendenti al fratello. 20 C’erano sette fratelli: il primo prese moglie e morì senza lasciare discendenza; 21 allora la prese il secondo, ma morì senza lasciare discendenza; e il terzo egualmente, 22 e nessuno dei sette lasciò discendenza. Infine, dopo tutti, morì anche la donna. 23 Nella risurrezione, quando risorgeranno, a chi di loro apparterrà la donna? Poiché in sette l’hanno avuta come moglie». 24 Rispose loro Gesù: «Non siete voi forse in errore dal momento che non conoscete le Scritture, né la potenza di Dio? 25 Quando risusciteranno dai morti, infatti, non prenderanno moglie né marito, ma saranno come angeli nei cieli. 26 A riguardo poi dei morti che devono risorgere, non avete letto nel libro di Mosè, a proposito del roveto, come Dio gli parlò dicendo: Io sono il Dio di Abramo, il Dio di Isacco e di Giacobbe? 27 Non è un Dio dei morti ma dei viventi! Voi siete in grande errore».Anche i sadducei contestano Gesù: essi non credono alla risurrezione dei morti. La risposta di Gesù considera due momenti. Anzitutto egli fonda la fede nella risurrezione sul rapporto che Dio ha stabilito con gli uomini: un rapporto di alleanza, di amicizia, di solidarietà, di vita. Dio non è impotente di fronte alla morte, «non è il Dio dei morti, ma dei viventi» (v. 27).Citando Esodo 3, che è un testo su Dio e non sulla risurrezione dei morti, Gesù riconduce il dibattito all’amore di Dio e alla sua fedeltà: se Dio ama l’uomo non può abbandonarlo in potere della morte.Gesù inoltre corregge l’altro errore dei sadducei che pensano alla risurrezione come a una semplice continuazione della vita attuale, con gli stessi tipi di rapporti. Pensando in questo modo, essi non tengono conto della «potenza di Dio» (v. 24).La risurrezione non è una semplice continuazione della vita attuale, ma il passaggio a una vita nuova, creata dalla potenza di Dio. Non è la rianimazione di un cadavere: è una trasformazione qualitativa, è una nuova esistenza.La nostra risurrezione è il centro della vita cristiana. Senza di essa « è vana la nostra predicazione ed è vana anche la vostra fede» scrive Paolo ai Corinti (1Cor 15,14).I sadducei assomigliano a tanti credenti del nostro tempo. Credono in Dio, ma non nella risurrezione dei morti. Chiusi nel materialismo, non credono, né teoricamente né praticamente, al fine a cui Dio ci ha destinati: la vita eterna. È l’alienazione più tragica dell’uomo, che perde ciò per cui è fatto, l’orizzonte che dà senso alla vita. Tentare di superare la morte attraverso la generazione dei figli è un rimedio peggiore del male, una vittoria illusoria, perché non si fa che accrescere il numero dei destinati alla morte.La generazione dei figli ha senso solamente nella speranza che questi «destinati alla morte» incontrino Dio che dà loro la vita nella risurrezione.28 Allora si accostò uno degli scribi che li aveva uditi discutere, e, visto come aveva loro ben risposto, gli domandò: «Qual è il primo di tutti i comandamenti?». 29 Gesù rispose: «Il primo è: Ascolta, Israele. Il Signore Dio nostro è l’unico Signore; 30 amerai dunque il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua mente e con tutta la tua forza. 31 E il secondo è questo: Amerai il prossimo tuo come te stesso. Non c’è altro comandamento più importante di questi». 32 Allora lo scriba gli disse: «Hai detto bene, Maestro, e secondo verità che Egli è unico e non v’è altri all’infuori di lui; 33 amarlo con tutto il cuore, con tutta la mente e con tutta la forza e amare il prossimo come se stesso val più di tutti gli olocausti e i sacrifici». 34 Gesù, vedendo che aveva risposto saggiamente, gli disse: «Non sei lontano dal regno di Dio». E nessuno aveva più il coraggio di interrogarlo.La domanda che lo scriba pone a Gesù non è oziosa. Data la molteplicità delle prescrizioni della legge (se ne contavano 613, ripartite in 365 proibizioni – quanti sono i giorni dell’anno – e 248 comandamenti positivi, quante si credeva fossero le parti del corpo umano), ci si poteva legittimamente interrogare sul loro valore e chiedersi quale fosse il comandamento più grande.La risposta di Gesù che pone nell’amore di Dio e del prossimo il centro della legge, non è una novità assoluta: lo insegnavano anche i rabbini di allora. La novità consiste nell’avere unificato il testo del Dt 6,4–5 con il testo del Lv 19,18. Ma per cogliere questo centro sono necessarie due precisazioni. La Bibbia insegna che il nostro amore per Dio e per il prossimo suppone un fatto precedente, senza il quale tutto resterebbe incomprensibile: l’amore di Dio per noi. Qui è l’origine e la misura del nostro amore. L’amore dell’uomo nasce dall’amore di Dio e deve misurarsi su di esso. E qui si inserisce la seconda precisazione: chi è il prossimo da amare? La Bibbia risponde: ogni uomo che Dio ama, cioè tutti gli uomini, senza alcuna distinzione, perché Dio si è rivelato in Gesù come amore universale.La nostra vita è amare Dio e unirci a lui (Dt 30,20), diventando per grazia ciò che lui è per natura. Il nostro amore per lui è la via per la nostra divinizzazione, perché uno diventa ciò che ama. Chi risponde a questo amore passa dalla morte alla vita, mentre chi non ama Dio e il prossimo rimane nella morte (1Gv 3,14). Dio è amore più forte della morte (Ct 8,6). La sua fedeltà dura in eterno (Sal 117, 2). Quando noi moriamo, egli ci ridà la vita. «Riconoscerete che io sono il Signore quando aprirò le vostre tombe e vi risusciterò dai vostri sepolcri» (Ez 37,13). Dio ha creato tutto per l’esistenza, perché è un Dio amante della vita (cf. Sap 1,14; 11,26).L’amore per l’uomo non è in alternativa a quello per Dio, ma scaturisce da esso come dalla sua sorgente. Si ama veramente il prossimo solo quando lo si aiuta a diventare se stesso, raggiungendo il fine per cui è stato creato, che è quello di amare Dio sopra ogni cosa e il prossimo come se stesso. Alla luce di questa verità, dobbiamo rivedere radicalmente il nostro modo di amare: molto del cosiddetto amore, che schiavizza sé e gli altri, è una contraffazione dell’amore, è egoismo. Quanta purificazione, quanta grazia di Dio occorrono perché l’amore sia vero amore!35 Gesù continuava a parlare, insegnando nel tempio: «Come mai dicono gli scribi che il Messia è figlio di Davide?36 Davide stesso infatti ha detto, mosso dallo Spirito Santo:Disse il Signore al mio Signore: Siedi alla mia destra, finché io ponga i tuoi nemici come sgabello ai tuoi piedi.37 Davide stesso lo chiama Signore: come dunque può essere suo figlio?». E la numerosa folla lo ascoltava volentieri.Nella lettura del Vangelo di Marco ritorna con insistenza la domanda: Chi è Gesù? E ci è stata data la risposta con chiarezza: Gesù è il Messia (Mc 8,29). Ma subito si è riproposta un’altra domanda: Che cosa significa per Gesù essere il Messia e quale relazione ha il Messia con Dio? E la risposta è stata: Il Messia compirà la sua missione nella sofferenza (tre annunci della passione); il Messia è l’ultimo inviato di Dio, e il Figlio che Dio tanto ama (Mc 12,1–8).Ora qui si ripropone un problema importante: Chi è il Messia? Ogni ebreo poteva rispondere con semplicità e senza alcun dubbio: Il Messia è il figlio di Davide. E questa risposta trova il fondamento negli oracoli dei profeti, a cominciare da Natan (2Sam 7). E tuttavia la risposta è incompleta. Il Messia non è solamente il figlio di Davide; è il Figlio di Dio.Gesù fonda il suo ragionamento sull’interpretazione del salmo 110 , un salmo che la Bibbia attribuisce a Davide. Dunque è Davide stesso che parla e dice: «Disse il Signore (cioè Dio stesso) al mio Signore (cioè al Re–Messia): siedi alla mia destra». Dunque, dice Gesù, Davide chiama il Messia «mio Signore». Vuol dire, dunque, che il Messia è molto di più che «il figlio di Davide»: è addirittura «il Signore di Davide».Ne consegue che se Gesù è il Figlio di Dio, il suo regno non può essere ridotto al regno di Davide. Sarebbe un regno tra i regni di questo mondo o in alternativa ad essi. Invece il regno di Dio li supera, li trascende e non è legato alla loro realtà materiale.38 Diceva loro mentre insegnava: «Guardatevi dagli scribi, che amano passeggiare in lunghe vesti, ricevere saluti nelle piazze, 39 avere i primi seggi nelle sinagoghe e i primi posti nei banchetti. 40 Divorano le case delle vedove e ostentano di fare lunghe preghiere; essi riceveranno una condanna più grave».41 E sedutosi di fronte al tesoro, osservava come la folla gettava monete nel tesoro. E tanti ricchi ne gettavano molte.42 Ma venuta una povera vedova vi gettò due spiccioli, cioè un quattrino. 43 Allora, chiamati a sé i discepoli, disse loro: «In verità vi dico: questa vedova ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri. 44 Poiché tutti hanno dato del loro superfluo, essa invece, nella sua povertà, vi ha messo tutto quello che aveva, tutto quanto aveva per vivere».Gesù mette in guardia la folla perché sta per lasciarsi trascinare dai capi: bisogna che essa sappia chi sono in realtà i suoi capi. Con poche parole il Maestro fa il ritratto degli scribi: vanità, sfruttamento delle vedove, ostentazione nella preghiera. La loro logica è precisa: prima io, poi le donne, infine Dio. Forse ci aspettavamo un elogio degli scribi: sono gli studiosi della parola di Dio. Se è vero che la conoscenza è l’origine della virtù, essi dovrebbero essere molto virtuosi. Al contrario, non ci aspettavamo molto dalla vedova che Gesù, invece, ci propone come esempio: è limitata, è povera, è costretta ad occuparsi quotidianamente delle solite cose indispensabili per la sopravvivenza. Cosa può dare a Dio una persona insignificante come lei?Ma il giudizio di Dio capovolge le nostre valutazioni. Gli scribi usano la conoscenza delle Scritture per procurarsi onori umani, si servono della loro pietà religiosa per nascondere la cupidigia con cui si appropriano dei beni degli altri, in particolare dei beni dei poveri e degli indifesi. La povera vedova invece, che può mettere nel tesoro del tempio solo due spiccioli, viene presentata ai discepoli come il vero esempio da imitare: «Tutti hanno dato del loro superfluo, essa invece, nella sua povertà, vi ha messo tutto ciò che aveva, tutto quanto aveva per vivere» (v. 44). Così, con semplicità, questa donna insignificante, a cui nessuno aveva prestato attenzione, ha amato Dio con tutto il cuore (cfr Mc 12, 30).Gesù sta per andarsene dalla scena di questo mondo e non ci lascia come maestri dei personaggi dalle lunghe maniche e dalle parole altisonanti, ma mette in cattedra una donnetta discreta, che continua in silenzio la sua lezione: la vedova che offre a Dio tutta la sua vita. Essa è sola e inosservata, povera e umile, «getta» tutta la propria vita: è come Gesù che si è fatto ultimo di tutti e ha dato la sua vita in riscatto per tutti (cf. Mc 10,43–45).Il primo miracolo di Gesù fu la guarigione della suocera di Pietro, perché potesse servire (cf. Mc 1,29–31). L’ultimo suo insegnamento, prima del discorso escatologico, ci presenta questa vedova, che ama veramente Dio con tutta la sua vita. Sono loro le vere discepole di Gesù, e quindi le nostre maestre.
CAPITOLO 13
1 Mentre usciva dal tempio, un discepolo gli disse: «Maestro, guarda che pietre e che costruzioni!». 2 Gesù gli rispose: «Vedi queste grandi costruzioni? Non rimarrà qui pietra su pietra, che non sia distrutta». 3 Mentre era seduto sul monte degli Ulivi, di fronte al tempio, Pietro, Giacomo, Giovanni e Andrea lo interrogavano in disparte: 4 «Dicci, quando accadrà questo,e quale sarà il segno che tutte queste cose staranno per compiersi?».Per un conoscitore della Bibbia, è assai difficile leggere questi pochi versetti senza ricorrere col pensiero ai capitoli 8–11 del profeta Ezechiele. Molte Bibbie li intitolano così: ‘La gloria di Iahvè abbandona il tempio’.. Si trattava del grandioso tempio del re Salomone, considerato dai fedeli la casa di Dio sulla terra. Il profeta lo contempla e vede la gloria di Dio (un’immagine per dire Dio) che si alza e abbandona la sua casa. Dopo un breve tragitto, si sofferma un po’ sulla porta orientale del tempio per poi abbandonare definitivamente la città e fermarsi sul monte degli Ulivi. La città, senza Dio, è così destinata alla rovina e alla morte. Ciò avvenne l’anno 587 a.C.Qualcosa di simile si ripete con l’uscita di Gesù dal tempio. E Marco ci ha preparati a questi avvenimenti. Egli ha presentato Gesù che accusa Israele di essere come una pianta che non dà frutto, e di avere impedito che il tempio fosse una casa di preghiera per tutte le genti; e ha pure presentato Gesù come pietra fondamentale di un nuovo edificio, di un nuovo popolo: la Chiesa. Ora, dopo lunghe controversie, Marco ritorna al tema della condanna di Israele, e presenta Gesù che abbandona il tempio e ne predice la rovina: «Non rimarrà qui pietra su pietra, che non sia distrutta» (v. 2).Non hanno voluto accogliere Gesù come il Messia, come colui che instaura il Regno di Dio e ne realizza la presenza sulla terra. Ebbene, lui li abbandona. E dove non c’è lui ci può essere solo fallimento e rovina.I discepoli vogliono indagare e lo interrogano in disparte: «Dicci, quando accadrà questo, e quale sarà il segno che tutte queste cose staranno per compiersi?». La domanda è limitata alla distruzione del tempio, ma la risposta di Gesù andrà oltre questo evento, per prospettarne un altro molto più importante. Quello che conta per il discepolo non è la data o i segni della distruzione di Gerusalemme. Ciò che conta è il modo di vivere l’attesa del Signore.L’uomo è l’unico animale che sa di dover morire. Cosciente della propria morte, cerca di sapere quando sarà; ne spia i segni nell’illusione di controllarla. Ma, proprio così, invece di scansarla o allontanarla, si fa sua preda anticipata. Cade sotto il suo dominio dispotico, soggiogato dalla paura.Il vangelo non soddisfa il nostro prurito di curiosare circa il futuro. Non vuole alimentare la nostra ansia, ma vincerla con la fiducia. Con la croce è già venuta la fine del mondo vecchio e il principio di quello nuovo. Ciò che è avvenuto nel Signore è quanto avviene e avverrà a ciascuno di noi e a tutta la storia.Il cap. 13 non intende far previsioni catastrofiche e ineluttabili. Alla luce della storia di Gesù, vuol farci leggere il nostro presente per viverlo con responsabilità e determinare così il nostro futuro, che dipende appunto da ciò che facciamo ora. Ciò che conta è il presente, come luogo della fedeltà al Signore.Questo discorso, più che dirci le ultime cose che avverranno, ci svela il senso ultimo delle cose che avvengono. Gran parte di esso parla di guerre, carestie e terremoti. Non sono che gli ingredienti della nostra storia, quella di tutti i tempi, posta sotto il segno del peccato. È nella nostra storia attuale che noi viviamo la nostra pasqua di morte e risurrezione. I rantoli del vecchio mondo che agonizza sono anche le doglie del parto del mondo nuovo che nasce. Le parole che qui Gesù dice si sono avverate nella sua epoca e si avvereranno in ogni epoca. Per questo l’evangelista dice: «Chi legge, capisca!» (v. 14). Infatti, la storia di Gesù rivela il mistero dell’uomo e del cosmo: in lui è il destino di tutto e di tutti.Il discepolo sa che c’è una fine: la morte. Ma sa anche che c’è un fine: la risurrezione. Questo illumina tutto del suo vero senso, e gli infonde una fiducia costruttiva. A differenza di chi segue delle ideologie, egli non si illude e non si delude. Gli altri sono ottimisti o pessimisti; lui è realista perché ha speranza.5 Gesù si mise a dire loro: «Guardate che nessuno v’inganni! 6 Molti verranno in mio nome, dicendo: «Sono io», e inganneranno molti. 7 E quando sentirete parlare di guerre, non allarmatevi; bisogna infatti che ciò avvenga, ma non sarà ancora la fine. 8 Si leverà infatti nazione contro nazione e regno contro regno; vi saranno terremoti sulla terra e vi saranno carestie. Questo sarà il principio dei dolori.9 Ma voi badate a voi stessi! Vi consegneranno ai sinedri, sarete percossi nelle sinagoghe, comparirete davanti a governatori e re a causa mia, per render testimonianza davanti a loro. 10 Ma prima è necessario che il vangelo sia proclamato a tutte le genti. 11 E quando vi condurranno via per consegnarvi, non preoccupatevi di ciò che dovrete dire, ma dite ciò che in quell’ora vi sarà dato: poiché non siete voi a parlare, ma lo Spirito Santo. 12 Il fratello consegnerà a morte il fratello, il padre il figlio e i figli insorgeranno contro i genitori e li metteranno a morte. 13 Voi sarete odiati da tutti a causa del mio nome, ma chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato.14 Quando vedrete l’abominio della desolazione stare là dove non conviene, chi legge capisca, allora quelli che si trovano nella Giudea fuggano ai monti; 15 chi si trova sulla terrazza non scenda per entrare a prender qualcosa nella sua casa; 16 chi è nel campo non torni indietro a prendersi il mantello. 17 Guai alle donne incinte e a quelle che allatteranno in quei giorni! 18 Pregate che ciò non accada d’inverno; 19 perché quei giorni saranno una tribolazione, quale non è mai stata dall’inizio della creazione, fatta da Dio, fino al presente, né mai vi sarà. 20 Se il Signore non abbreviasse quei giorni, nessun uomo si salverebbe. Ma a motivo degli eletti che si è scelto ha abbreviato quei giorni. 21 Allora, dunque, se qualcuno vi dirà: «Ecco, il Cristo è qui, ecco è là», non ci credete; 22 perché sorgeranno falsi cristi e falsi profeti e faranno segni e portenti per ingannare, se fosse possibile, anche gli eletti. 23 Voi però state attenti! Io vi ho predetto tutto.Vivere l’attesa! Nei periodi di grande tensione nella storia, diversi uomini si presentano con soluzioni di salvezza e per il cristiano è il momento della scelta: continuare a sperare in Gesù, il Messia, o aspettare e accogliere altri messia?Gli anni che precedettero la distruzione di Gerusalemme furono certamente anni di lotta ma, come insegnano gli storici, furono pure anni di grande speranza. C’erano molti ispirati, profeti e capipopolo. Molti li accolsero come veri messia, come liberatori dal dominio di Roma, ma furono ingannati. Non erano il Messia, e Dio per mezzo loro non ha salvato Israele.Gerusalemme ha rigettato Gesù il Salvatore ed è andata in rovina. Chi invece lo accetta non si lascia turbare dalle guerre, dalla fame e dalle carestie. Egli sa che tutto ciò non è la fine della storia, ma solo il necessario travaglio per la nascita di un mondo migliore.Questa è la storia di tutti i tempi e anche la nostra storia personale. Il mondo ci propina ogni giorno messaggi di liberazione, ma il vangelo da duemila anni ci annunzia che il Salvatore è uno solo: Cristo. Finché il mondo non l’avrà accolto, non troverà la pace. Perché lui solo è la nostra pace (Ef 2,14).Quando Marco scriveva il suo Vangelo, a Roma, la Chiesa si trovava in piena persecuzione. Ed è proprio in questa situazione che il cristiano è chiamato a dare la sua testimonianza a Gesù.. In pochissimi decenni di cristianesimo, i discepoli erano già stati più volte «consegnati nei sinedri e percossi nelle sinagoghe ed erano comparsi davanti a governatori e re, a causa di Cristo, per rendere testimonianza davanti a loro» (v. 9). Molti avevano dato testimonianza a Cristo fino alla morte, ma altri no. Per salvare la vita in questo mondo alcuni fratelli di fede hanno consegnato alla morte altri fratelli. La divisione è penetrata anche nelle famiglie cristiane dove i padri hanno fatto morire i figli e viceversa. Chi voleva rimanere fedele a Cristo non si sentiva più sicuro e sentiva ovunque il tradimento e l’odio in agguato attorno a sé. A costoro Marco ripete: «Chi avrà perseverato sino alla fine (la morte) sarà salvato» (v. 13).La grande tribolazione di Gerusalemme viene annunciata con linguaggio apocalittico (1Mac 1,54; Dn 9,27; 11,31; 12,1.11; Gen 19,26 ecc.). In particolare, ci riferiamo al libro di Daniele. In questo libro, le immagini indicano la persecuzione scatenata da Antioco Epifane, che culminò nell’anno 168 a.C. con l’instaurazione nel tempio del culto idolatrico. In Marco si parla, quasi certamente, delle aquile romane (idolo, abominazione) che entrarono nel tempio e commisero ogni sorta di profanazione e di sacrilegio.Ma la fine di Gerusalemme non è la fine dei cristiani, né la fine del mondo: la storia continua!Gesù esorta i suoi discepoli a sostituire l’allarmismo col discernimento. Invece di preoccuparsi del futuro, devono occuparsi del presente, in fedeltà operosa alla Parola di Dio.È inutile speculare: nessuna risposta teorica muta il dato di fatto sicuro. La finitezza di tutto l’universo si impone. Ma proprio questa può essere vissuta da noi o come angoscia mortale o come dipendenza filiale da Dio.Il cristiano sa che nella realtà del peccato è presente il suo Signore crocifisso. Unito a lui, partecipa e prolunga in sé la sua stessa vicenda di morte salvifica.24 In quei giorni, dopo quella tribolazione, il sole si oscurerà e la luna non darà più il suo splendore25 e gli astri si metteranno a cadere dal cielo e le potenze che sono nei cieli saranno sconvolte.26 Allora vedranno il Figlio dell’uomo venire sulle nubi con grande potenza e gloria.27 Ed egli manderà gli angeli e riunirà i suoi eletti dai quattro venti, dall’estremità della terra fino all’estremità del cielo.28 Dal fico imparate questa parabola: quando già il suo ramo si fa tenero e mette le foglie, voi sapete che l’estate è vicina; 29 così anche voi, quando vedrete accadere queste cose, sappiate che egli è vicino, alle porte.30 In verità vi dico: non passerà questa generazione prima che tutte queste cose siano avvenute.31 Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno.32 Quanto poi a quel giorno o a quell’ora, nessuno li conosce, neanche gli angeli nel cielo, e neppure il Figlio, ma solo il Padre.Questo brano potrebbe essere intitolato «un canto di speranza». La persecuzione verso i discepoli e la rovina di Gerusalemme hanno disperso i cristiani, ma la venuta del Signore li riunirà, non per il giudizio, ma per l’incontro definitivo nella gioia della salvezza. La dispersione ha reso possibile la testimonianza e l’annuncio del vangelo a tutte le nazioni (Mc 13, 10); il raduno «dall’estremità della terra fino all’estremità del cielo» (v. 27) segnerà la piena realizzazione del regno di Dio.La descrizione dell’avvenimento è grandiosa. Il suo scopo è di dare, attraverso alcune immagini impressionanti tolte dall’Antico Testamento, l’idea del trionfo totale e definitivo. Come all’uscita di Israele dall’Egitto, il mare vide e fuggì e le montagne saltellarono come arieti davanti al Dio di Giacobbe (Sal 114), così avverrà al definitivo ritorno del Signore: sarà un avvenimento che scuoterà l’universo intero. Il sole, la luna, le stelle e tutte le forze del cielo saranno sconvolte, perché sulle nubi del cielo apparirà, pieno di potenza e gloria, il Figlio dell’uomo.A questo incontro con lui tutta la storia è condotta dalla mano sapiente e paziente di Dio. La creazione è in cammino verso la rivelazione del Figlio dell’uomo, nel quale ogni uomo è figlio in comunione con il Padre. La fine del mondo non è il cadere di tutto nel nulla, ma il compiersi di ogni speranza, al di là e al di sopra di ogni attesa, in una pienezza che non riusciamo a immaginare.La creazione tende con tutte le sue energie verso di lui, nel quale, per mezzo del quale, e in vista del quale tutto è stato fatto (Col 1,15–16). Egli infatti è la vita di tutto ciò che esiste. La fine del mondo non è qualcosa di tremendo. E’ l’incontro della sposa, la comunità dei salvati, che nello Spirito grida: «Vieni!», e lo Sposo che risponde: «Sì, verrò presto!» (cf. Ap 22,17–20).Le parole di Gesù, che leggiamo nel vangelo di oggi, presentano il quadro finale della vicenda cosmica. Al centro sta la venuta del Figlio dell’uomo (v. 26), che segna la fine del mondo vecchio con il suo male (vv. 24–25) e l’inizio del mondo nuovo in comunione con lui (v. 27).La venuta gloriosa del Signore e il suo giudizio hanno un passato, quello della croce, dove tutto è compiuto (cfr Gv 19,30); un presente, nel quale viviamo la nostra imitazione di Cristo; e un futuro, quando sarà compiuto tutto ciò che è già avvenuto in Gesù e sta avvenendo in noi.La storia è sotto il segno della croce, gloria di Dio che si manifesta in pienezza. Il braccio potente, con cui Dio ha vinto il male, sono le braccia misericordiose del Figlio inchiodate alla croce e allargate a tutti gli uomini.Il giudice del mondo è colui che muore in croce per noi peccatori. Quindi il suo giudizio è questo: lui, che è giusto, porta su di sé il nostro peccato e giustifica tutti gli ingiusti che si riconoscono tali e accettano la sua grazia. Il giudizio di Dio è il suo amore che salva. Egli ci giudica solo dopo aver perdonato tutti i nostri peccati.Il tragico presente non è quindi senza speranza. Esso è quel necessario travaglio da cui deve nascere il mondo nuovo e definitivo. Per il cristiano non c’è spazio per il pessimismo: sa che può sperare e che la sua speranza non andrà delusa.Ma quando verrà il Signore più precisamente? Lo sa solo il Padre. Gesù non l’ha rivelato a nessuno, perché il Padre non gli ha dato questo incarico. Il giorno e l’ora della fine della nostra vita e del mondo sono certi e determinati per Dio e sconosciuti per noi. Così Dio ha stabilito saggiamente per il nostro bene. Infatti, se sapessimo il giorno e l’ora di questi avvenimenti, cadremmo in un terrore paralizzante e in un’attesa alienante. Se Gesù non ci ha rivelato la fine della nostra vita è perché non ci serviva e ci avrebbe guastato totalmente l’esistenza.Tutta la storia ormai non è altro che il tempo della pazienza di Dio. «Davanti al Signore un giorno è come mille anni, e mille anni come un giorno solo. Il Signore non ritarda nell’adempiere la sua promessa, come certuni credono. Ma usa pazienza verso di voi, non volendo che alcuno perisca, ma che tutti abbiano modo di pentirsi» (2Pt 3,8–9). Infatti Dio, nostro salvatore, vuole che tutti gli uomini siano salvati (cf. 1Tm 2,4) e che la sua casa sia piena (Lc 14,23).33 State attenti, vegliate, perché non sapete quando sarà il momento preciso.34 E’ come uno che è partito per un viaggio dopo aver lasciato la propria casa e dato il potere ai servi, a ciascuno il suo compito, e ha ordinato al portiere di vigilare.35 Vigilate dunque, poiché non sapete quando il padrone di casa ritornerà, se alla sera o a mezzanotte o al canto del gallo o al mattino, 36 perché non giunga all’improvviso, trovandovi addormentati.37 Quello che dico a voi, lo dico a tutti: Vegliate!».La vita del cristiano non è un viaggio durante il quale i trasportati possono sonnecchiare e dormire. Lo indicano le esortazioni che strutturano l’intero discorso: «Guardate che nessuno vi inganni (v. 5)... Ma voi badate a voi stessi (v. 9)... Vigilate dunque (v. 33)... Vegliate (vv. 33.37)». E questi avvisi non sono dati solo a Pietro, Giacomo, Giovanni e Andrea (v. 4), ma a tutti noi che attendiamo la sua venuta: «Quello che dico a voi, lo dico a tutti: Vegliate!» (v. 37).Che cosa significa vegliare? Per l’evangelista Marco, il discepolo è sveglio se in ogni momento si preoccupa di dare testimonianza a Gesù affinché il vangelo raggiunga tutte le nazioni (13,9–10).Tutta la storia ormai non è altro che il tempo della pazienza di Dio. «Davanti al Signore un giorno è come mille anni, e mille anni come un giorno solo. Il Signore non ritarda nell’adempiere la sua promessa, come certuni credono. Ma usa pazienza verso di voi, non volendo che alcuno perisca, ma che tutti abbiano modo di pentirsi» (2 Pt 3,8–9). Infatti vuole che tutti gli uomini siano salvati (1Tm 2,4) e che la sua casa sia piena (Lc 14,23).Nell’attesa di questi grandi eventi bisogna vegliare. Il cristianesimo non è oppio. Fa tenere gli occhi aperti. Star svegli è necessario, ma non basta. Il Signore, quando ci ha lasciati, ci ha affidato una missione da compiere. La vigilanza costante deve quindi essere riempita da una fedeltà operosa. La storia non è una sala d’attesa. È un cammino alla sequela di Cristo. La nostra vita è il tempo per colmare la distanza da lui e poterlo raggiungere.Il discepolo non è un fanatico che attende con agitazione, speculando su date e scadenze; e neppure un deluso che non attende più nulla e nessuno, e dorme. Nell’attesa del ritorno definitivo del Signore, sa cosa fare: mettersi al servizio dei fratelli. E il lavoro non manca! «La messe è molta, ma gli operai sono pochi» (Lc 10,2).
CAPITOLO 14
1 Mancavano intanto due giorni alla Pasqua e agli Azzimi e i sommi sacerdoti e gli scribi cercavano il modo di impadronirsi di lui con inganno, per ucciderlo. 2 Dicevano infatti: «Non durante la festa, perché non succeda un tumulto di popolo».3 Gesù si trovava a Betània nella casa di Simone il lebbroso. Mentre stava a mensa, giunse una donna con un vasetto di alabastro, pieno di olio profumato di nardo genuino di gran valore; ruppe il vasetto di alabastro e versò l’unguento sul suo capo. 4 Ci furono alcuni che si sdegnarono fra di loro: «Perché tutto questo spreco di olio profumato? 5 Si poteva benissimo vendere quest’olio a più di trecento denari e darli ai poveri!». Ed erano infuriati contro di lei.6 Allora Gesù disse: «Lasciatela stare; perché le date fastidio? Ella ha compiuto verso di me un’opera buona; 7 i poveri infatti li avete sempre con voi e potete beneficarli quando volete, me invece non mi avete sempre. 8 Essa ha fatto ciò ch’era in suo potere, ungendo in anticipo il mio corpo per la sepoltura. 9 In verità vi dico che dovunque, in tutto il mondo, sarà annunziato il vangelo, si racconterà pure in suo ricordo ciò che ella ha fatto».10 Allora Giuda Iscariota, uno dei Dodici, si recò dai sommi sacerdoti, per consegnare loro Gesù.11 Quelli all’udirlo si rallegrarono e promisero di dargli denaro. Ed egli cercava l’occasione opportuna per consegnarlo.Questa prima sezione è composta da tre serie di immagini, che sembrano volerci offrire un primo contatto con i personaggi principali del racconto. La struttura è in sé significativa: alle due estremità stanno i sommi sacerdoti e gli scribi (vv. 1–2) e il discepolo traditore (vv. 10–11), che congiurano contro Gesù; al centro, invece, in contrasto con gli altri due quadri, vengono presentati Gesù e i discepoli (vv. 3–9). In pratica, la piccola sezione offre la situazione esistenziale dei diversi personaggi a due giorni dalla Pasqua.Una donna ci introduce alla passione, e Gesù interpreta il suo gesto come un’anticipazione della propria imbalsamazione. Da questo momento in avanti, facciamo attenzione alla presenza delle donne: mentre quasi tutti gli uomini fanno una pessima figura durante la passione, quasi tutte le donne, al contrario, danno un sublime esempio di fedeltà, di coraggio e di dedizione a Gesù.In contrasto con il gesto della donna, il tradimento di Giuda. Gesù tradito da uno dei suoi. La responsabilità per la morte di Gesù ricade in primo luogo su uno dei Dodici. Senza di lui, si ha l’impressione che il piano omicida dei capi non avrebbe potuto concretizzarsi, trattenuti com’erano dalla paura della folla (v. 2).«A che pro questo spreco?». Queste parole nei confronti della donna esprimono bene anche il nostro sentimento davanti alla passione del Signore: perché questo spreco di sofferenza e di amore? Non poteva evitarlo o almeno risparmiarsi un po’?Chi comprende questo eccesso entra nel mistero di Dio. Questa donna è figura della Chiesa e dell’umanità che accoglie lo Sposo. La sposa risponde finalmente all’amore dello Sposo, che l’ama di un amore eterno (Ger 31,3).La reciprocità dell’amore tra uomo e Dio è il punto di arrivo di tutta la creazione.L’unzione da parte della donna è la consacrazione di Gesù come messia, profeta, sacerdote, altare e vittima. E ci rivela anche che cos’è la fede: riconoscere Gesù povero e morente come proprio Salvatore e Signore, amandolo con tutto il cuore.Inoltre, quanto fa questa donna è figura di quanto farà Gesù sulla croce: il vaso del suo corpo sarà rotto, e ne uscirà per tutta la terra il profumo di Dio.Il racconto ruota su due gruppi di persone. Da una parte, i sommi sacerdoti, gli scribi, Giuda e tutti gli altri. Dall’altra, Gesù solo con la donna.In corrispondenza ci sono due gruppi di parole. Da una parte c’è: impadronirsi, inganno, uccidere, tumulto, vendere, denaro, comprare, fremere, dar fastidio. Dall’altra c’è: alabastro, profumo, nardo genuino, effondere, sprecare, dare, beneficare, opera buona, vangelo. Con il primo gruppo di parole si può scrivere tutta la storia umana; con il secondo quella di Dio in Gesù.I due gruppi di persone e di parole esprimono due economie opposte. Da una parte c’è quella dell’egoismo che si impadronisce, compra, vende, calcola e uccide, adirandosi e dando fastidio. È l’economia dell’uomo. Dall’altra c’è quella dell’amore che dona in gratuità e spreca follemente. È l’economia di Dio.Gesù sta terminando il suo cammino. Dopo aver dato tutto ciò che ha, dà tutto ciò che è.12 Il primo giorno degli Azzimi, quando si immolava la Pasqua, i suoi discepoli gli dissero: «Dove vuoi che andiamo a preparare perché tu possa mangiare la Pasqua?». 13 Allora mandò due dei suoi discepoli dicendo loro: «Andate in città e vi verrà incontro un uomo con una brocca d’acqua; seguitelo 14 e là dove entrerà dite al padrone di casa: Il Maestro dice: Dov’è la mia stanza, perché io vi possa mangiare la Pasqua con i miei discepoli? 15 Egli vi mostrerà al piano superiore una grande sala con i tappeti, già pronta; là preparate per noi». 16 I discepoli andarono e, entrati in città, trovarono come aveva detto loro e prepararono per la Pasqua.Tutto il vangelo di Marco è una lunga introduzione al racconto della passione, morte e risurrezione di Gesù, agnello della nostra Pasqua.Bisogna conoscere bene la Pasqua ebraica, perché solo alla sua luce è comprensibile l’eucaristia cristiana, compimento di cui l’Esodo è promessa.La Pasqua ebraica è la liberazione dagli idoli che schiavizzano, la fine dell’oppressione dell’uomo da parte dell’uomo, perché Dio non tollera l’ingiustizia e, infine, è rottura con il peccato e con la morte e attesa di cieli nuovi e terra nuova. Tutti questi vari elementi della Pasqua ebraica sono la promessa che trova compimento nella croce di Gesù e servono per capirne pienamente la portata.La Pasqua di Gesù è martirio, ossia testimonianza di un amore più forte di ogni male e della stessa morte, capace di farsi solidale coi fratelli fino alla debolezza estrema: «Fu crocifisso per la sua debolezza» (2Cor 13,4).Mangiare la Pasqua con lui significa essere associati alla sua stessa passione per il mondo, disposti a pagarne i costi, che assumiamo liberamente, nonostante le paure e le resistenze contrarie.17 Venuta la sera, egli giunse con i Dodici. 18 Ora, mentre erano a mensa e mangiavano, Gesù disse: «In verità vi dico, uno di voi, colui che mangia con me, mi tradirà». 19 Allora cominciarono a rattristarsi e a dirgli uno dopo l’altro: «Sono forse io?». 20 Ed egli disse loro: «Uno dei Dodici, colui che intinge con me nel piatto.21 Il Figlio dell’uomo se ne va, come sta scritto di lui, ma guai a quell’uomo dal quale il Figlio dell’uomo è tradito! Bene per quell’uomo se non fosse mai nato!».Una lettura superficiale del vangelo ci potrebbe far deviare dal vero significato delle parole e dei fatti. I veri protagonisti della passione, cioè quelli che agiscono per la salvezza, sono due: il Padre e Gesù che si mantiene unito a lui. È vero che qui viene ricordato il tradimento di uno dei Dodici, ma le parole che usa Marco per raccontare ai suoi l’accaduto hanno un colore decisamente anticotestamentario. La frase «colui che mangia con me» è tolta dal Sal 41,10, mentre il passivo «è tradito» (paradidotai) richiama Isaia 53,6.10.12. Infine, l’espressione «come sta scritto di lui» ricorda tutto ciò che di Cristo hanno detto i profeti. Da qui nasce un importante principio di lettura: se l’evangelista narra l’accaduto servendosi dell’Antico Testamento, ciò significa che noi dobbiamo leggerlo come una storia di salvezza. Ora, questa storia è guidata da Dio e non dagli uomini ed è per questo che Marco fa assumere a Giuda un ruolo strumentale, per mezzo del quale il Figlio dell’uomo viene consegnato (dal Padre). Il peccato di Giuda non è vangelo (buona notizia): guai a quell’uomo! Dio non accetta il suo agire, non lo fa suo collaboratore. Dio però vuole la nostra salvezza nel Figlio suo Gesù e perciò, malgrado gli uomini, rende colui che è stato rigettato salvezza per noi (12,10–11; Sal 118,22). Per esprimere questo la Bibbia usa una frase un po’ urtante per noi e, saltando le cause seconde (sono gli uomini che lo consegnano alla morte), dice che è Dio colui che consegna il Figlio suo alla morte per noi. La dottrina rimane quindi chiara: attraverso Gesù, anche in queste tristi circostanze, continua a svilupparsi la storia della salvezza.Marco, nel suo ragionamento, ha delineato una reale immagine di Gesù. Per lui Gesù continua a vivere nella piena coscienza di ciò che sta per accadergli. Usando parole tolte dall’Antico Testamento, Marco ci dice che Gesù era cosciente di essere unito all’agire salvifico del Padre e che vi si aggrappa, come dimostra l’istituzione dell’eucaristia, con tutte le sue forze.Il lamento di Gesù su Giuda: «Guai a quell’uomo» non è una predizione di condanna eterna. Viene giudicato l’atto in se stesso, in termini simili a quelli con i quali Gesù aveva giudicato lo scandalo (9,42): tradire il Figlio dell’uomo è così ignobile, che sarebbe meglio non aver neppure visto la luce.Sdraiato a mensa con i suoi, il Signore della vita annuncia la sua morte per noi, e si offre come cibo e bevanda a noi che lo uccidiamo. Davanti a lui che si dona, si evidenzia il nostro peccato. Se per l’unguento di Betania i discepoli si erano domandati: «A che pro tutto questo spreco?», cosa dovrebbero dire di fronte al dono della vita di Gesù e all’eucaristia?Ogni discepolo, che sta con lui attorno alla stessa tavola, si chiede: «Sono forse io colui che tradisce Cristo e lo consegna alla morte?». La risposta è facile. Se non sono dalla parte di Gesù e della donna di Betania, sono tra coloro che lo vendono, lo comprano, lo consegnano, lo prendono e lo uccidono. Se non sono nell’economia dell’amore e della vita, sono in quella dell’egoismo e della morte. Se non vivo il dono che ricevo, donando a mia volta, sono chiuso nell’inferno del mio io, nemico di me, degli altri e di Dio.Giuda non è il mostro che siamo abituati a pensare. Egli ha tanti fratelli quanti sono gli uomini. Il suo peccato è identico al nostro. Il suo suicidio, tentativo estremo di autogiustificazione, è mancanza di conoscenza dell’amore gratuito di Dio, tentativo di guadagnarsi il perdono con il massimo della punizione e della pena.L’uomo non può salvarsi da sé. Ogni suo tentativo in questa direzione aggrava la sua situazione e il suo peccato. Egli deve avere l’umiltà di lasciarsi salvare gratuitamente da Cristo, senza possibilità alcuna di sdebitarsi. L’essenza del vangelo, manifestata da Gesù che muore in croce, è questa: Dio è amore infinito, incondizionato e gratuito per tutti i peccatori.Gesù si dona a una comunità di persone che lo tradiscono, lo rinnegano e fuggono. E si dona non «nonostante» questo, ma proprio «per questo». Lo annuncia in anticipo perché sappiamo che il suo amore si riversa su di noi gratuitamente, non per i nostri meriti, anzi prevedendo i nostri peccati. Noi, invece, vorremmo sempre un amore meritato, senza accorgerci che, se è meritato, non è amore. Sarebbe uno stipendio dovuto e non un dono di grazia.Il cristiano trova in Giuda la sua prima identificazione (poi ce ne saranno altre) se vuol comprendere che Gesù muore per lui.La nostra miseria è il recipiente della misericordia di Dio. Il nostro peccato è la nostra parte di Vangelo. L’altra è il suo perdono, che fa della nostra perdizione il luogo della sua salvezza.22 Mentre mangiavano prese il pane e, pronunziata la benedizione, lo spezzò e lo diede loro, dicendo: «Prendete, questo è il mio corpo». 23 Poi prese il calice e rese grazie, lo diede loro e ne bevvero tutti.24 E disse: «Questo è il mio sangue, il sangue dell’alleanza versato per molti.25 In verità vi dico che io non berrò più del frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo nel regno di Dio».26 E dopo aver cantato l’inno, uscirono verso il monte degli Ulivi.Gesù pronuncia le parole che trasformano la Pasqua ebraica in celebrazione cristiana su una comunità di peccatori e di traditori. Ad essi dà da mangiare il suo corpo e da bere il suo sangue che sono l’oggetto del loro tradimento: all’eccesso di ingratitudine degli uomini, risponde con l’eccesso del suo amore. Notiamo il duplice sottofondo anticotestamentario: il richiamo all’alleanza del Sinai (Es 24,8) e al Servo di Dio che dona la propria vita per tutti (Is 53). Inoltre vi è un chiaro riferimento alla croce: in questa direzione ci conduce il simbolo del corpo donato e del sangue sparso.Gesù sta svelando l’intenzione fondamentale che ha guidato la sua vita, ci sta manifestando la sua verità ultima: egli ha vissuto una vita in dono per tutti. È questo «per» che indica il significato ultimo di Gesù: un’esistenza donata. È un donarsi per tutti, non solo per alcuni, è un donarsi consapevole del rifiuto: rifiutato da tutti, muore per tutti. È un donarsi universale e ostinato, una solidarietà che non si lascia vincere dall’incomprensione e dal rifiuto. Anche il tradimento mette in luce l’amore ostinato di Gesù.Ricordando il tradimento, la comunità è invitata a non scandalizzarsi quando scoprirà nel proprio seno il tradimento e il peccato: è un’esperienza che Gesù stesso ha vissuto e che ha previsto per la sua Chiesa. La comunità cristiana è invitata a non cullarsi in una falsa sicurezza e presunzione di sé, come ha fatto Pietro: il peccato è sempre possibile ed è vano fidarsi delle proprie forze. Ma il vangelo ci insegna che l’incomprensione e il tradimento del discepolo sono superati e vinti dall’amore del Maestro.Ogni religione prevede il sacrificio dell’uomo a Dio. Il cristianesimo invece si fonda sul sacrificio di Dio all’uomo. L’Eucaristia «culmine e fonte di tutta la vita cristiana» (LG 11) è veramente tutto e ci dà tutto: è tutta la creazione che si fa corpo e sangue di Cristo; è l’umanità intera assunta nella sua carne; è Dio che si dona all’uomo. Nell’Eucaristia l’amore di Dio raggiunge il suo fine: unirsi a noi e farsi nostra vita.L’Eucaristia divinizza realmente l’uomo, ma senza alcuna confusione. Distinto da Dio, l’uomo è realmente unito a lui in un unico amore e in un’unica vita. Questa unione viene chiamata alleanza. Il sangue della nuova alleanza è quello uscito dalla persona di Gesù. Questo sangue, come quello che Mosè asperse sull’altare e sul popolo (Es 24,6.8), unisce l’uomo a Dio, rendendoli consanguinei. Questa alleanza è eterna perché non possiamo più infrangerla. Qualunque cosa facciamo, anche se lo mettiamo in croce, Dio rimane sempre fedele al suo amore per noi «perché non può rinnegare se stesso» (2Tim 2,13). Paolo apostolo ha scritto: «A stento si trova chi sia disposto a morire per una persona dabbene. Ma Dio dimostra il suo amore verso di noi perché, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi» (Rm 5,7–8).Ora, «se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Chi accuserà gli eletti di Dio, se Dio giustifica?» (Rm 8,31.33). Per questo san Paolo dice di essere convinto che «né morte né vita, né angeli né principati, né presente né avvenire, né potenze, né altezza né profondità, né alcun’altra creatura potrà mai separarci dall’amore che Dio ha per noi in Cristo Gesù nostro Signore» (Rm 8,31ss).Il vino è bevanda della terra promessa. Gesù sarà pellegrino nel mondo, digiuno e abbeverato di morte, fino al giorno in cui l’ultimo fratello non si sarà arreso alla conoscenza dell’amore del Padre. Quando la sua casa sarà piena di tutti i suoi figli, sarà il regno di Dio in pienezza. Fino ad allora Gesù continuerà a bere il calice di morte per dare a tutti noi il calice di vita. Quanti ne bevono sono spinti a loro volta dal suo stesso amore di Figlio versi i fratelli che ancora non conoscono il Padre (2Cor 4,12).Alla fine della cena pasquale tutti cantano l’inno. È il grande Hallel (Sal 136). È un salmo che, passando in rassegna i doni della creazione e della storia, ripete ad ogni riga il ritornello «perché eterna è la sua misericordia». Queste parole dicono il perché profondo di tutta la creazione e di tutta la storia.Dopo l’Eucaristia anche noi comprendiamo che la sua misericordia eterna è il perché ultimo di tutto quanto c’è e accade: è il trionfo del suo amore su tutto il male del mondo. A noi, che abbiamo compiuto il massimo male uccidendo suo Figlio, il Padre concede il massimo bene, donandoci la vita del Figlio. La sua misericordia è eterna e onnipotente, capace di capovolgere in bene ogni male e di salvare tutto e tutti.27 Gesù disse loro: «Tutti rimarrete scandalizzati, poiché sta scritto: Percuoterò il pastore e le pecore saranno disperse.28 Ma, dopo la mia risurrezione, vi precederò in Galilea».29 Allora Pietro gli disse: «Anche se tutti saranno scandalizzati, io non lo sarò».30 Gesù gli disse: «In verità ti dico: proprio tu oggi, in questa stessa notte, prima che il gallo canti due volte, mi rinnegherai tre volte». 31 Ma egli, con grande insistenza, diceva: «Se anche dovessi morire con te, non ti rinnegherò».Lo stesso dicevano anche tutti gli altri.Terminata questa celebrazione, il piccolo gruppo raggiunge il monte degli Ulivi. Prima di riunirsi definitivamente nel Regno, questa comunità, la cui esistenza era legata alla presenza di Gesù, sperimenterà la propria fragilità: lo scandalo (14,27–29), la dispersione (14,27), il rinnegamento (14,30–31). Tutti, anche Pietro, malgrado le sue proteste confermate dagli altri, faranno questa dolorosa constatazione. Di fronte al mistero del peccato dei discepoli, la Scrittura rafforza la nostra fede nella misericordia divina: la profezia di Zaccaria annunzia che Dio avrebbe colpito il pastore del suo popolo perché i deboli, dispersi, potessero rientrare in se stessi e convertirsi (Zc 13,7). Infatti Gesù promette che li precederà in Galilea (14,27; cf. 16,7) e la sua presenza verrà loro assicurata per sempre.Gesù fa prendere coscienza a Pietro delle due verità di fede fondamentali: il peccato dell’uomo e il perdono di Dio.Se in Giuda vediamo il male, in Pietro vediamo il «bene», dal quale Cristo ci salva. È quel bene che veste splendidamente l’orgoglio, essenza di ogni male. Questo orgoglio è presente in quantità variabile nel peccatore normale, ma è concentrato allo stato puro nel «giusto».Davanti al suo amore, che si consegna per tutti, Gesù prevede e predice la caduta di Pietro e di tutti. Ma la sua grazia si manifesta pienamente nel cedimento dei discepoli, e promette la sua fedeltà fin oltre la morte: «Dopo che sarò risuscitato, vi precederò in Galilea» (v. 28). Il nostro peccato è il luogo dell’incontro e della conoscenza di Dio e l’unica misura della sua misericordia.Non solo è inevitabile, ma è anche bene che Pietro cada. Così, invece di presumere per poi disperare di sé, confiderà in lui, con una speranza che non delude più.La frana di tutti i suoi buoni desideri lascerà emergere dalle sue rovine la roccia salda che non crolla: la fedeltà del Signore.Ciò che ci salva non è il nostro amore per Dio, ma l’amore di Dio per noi; non è il nostro morire per lui, ma il suo morire per noi. Pietro dovrà passare dalla propria giustizia alla giustificazione, dalla Legge al Vangelo. È la difficilissima conversione di Paolo che porta alla sublimità della conoscenza di Gesù come Signore (Fil 3,1ss).Il discepolo non è più bravo degli altri. Peccatore come tutti, ha però la gioia di conoscere il Signore morto per lui peccatore. Questo è il nuovo principio di vita, che ha il potere di guarirlo dal suo male radicale.«Il giusto vivrà di fede» (Rm 1,17; cf. Ab 2,4) dice Paolo. Il che significa: il giusto vivrà della fedeltà del Signore verso di lui. Nulla infatti può separarlo dall’amore che Dio ha per lui in Cristo Gesù (Rm 8,35.39).Questa fede è incrollabile, perché poggia non sulla mia fedeltà a Dio, ma sulla sua fedeltà a me. Neanche il peccato e la morte mi sottraggono a lui, perché lui si è fatto per me peccato e morte, per essere mia giustizia e vita nuova.Inoltre è molto importante che il peccato di Pietro sia previsto e predetto. Solo in questo modo è chiaro chi è il Signore e chi è Pietro: il Signore è amore gratuito e fedele, Pietro è ciò che è, solo in quanto amato da lui.Davanti alla croce di Gesù tutti ci scandalizziamo. Ma proprio sbattendo contro la croce, inciampando e cadendo, scopriremo l’identità di Dio e la nostra.La differenza tra Giuda e Pietro non è tanto nel loro peccato, comune anche a tutti noi, ma nell’accettare o meno di vivere del suo perdono.Dio è scandalo per ogni uomo. È scandaloso perché è amore e quindi debolezza, povertà, servizio e umiltà. Contro di lui, pietra di scandalo, si infrange il nostro egoismo, con la sua brama di avere, di potere e di apparire.Pietro vive ancora di confronto e di competizione con gli altri: «Anche se tutti saranno scandalizzati, io però no!» (v. 29). L’egoismo e l’orgoglio sono più presenti nel bene che nel male. In genere facciamo il male per errore, e il bene per superbia. Per questo la conversione è più difficile per il giusto che per il peccatore.Solo nel peccato si conosce Dio come Dio, ossia come perdono e amore gratuito.Le verità complementari del vangelo sono due: il nostro peccato e il suo perdono, la nostra infedeltà e la sua fedeltà, la nostra miseria e la sua misericordia. Solo nella prima ci è dato di cogliere la seconda.Rinnegare Gesù significa vergognarsi di lui e delle sue parole. È il contrario di testimoniare. Il discepolo che non rinnega se stesso (8,34) rinnega necessariamente il suo Signore.In questa circostanza Pietro parla troppo: «E lui parlava eccessivamente» (v. 31). Lo stesso eccesso avrà poi nel rinnegare il Signore (v. 71). L’eccesso di parola copre sempre incertezza o addirittura menzogna. «L’insensato moltiplica le parole» (Qo 10,14).Il desiderio di Pietro di stare con Gesù, anche se dettato da amore, è ancora un’affermazione di sé, l’ultima.Tutte le religioni raggiungono il loro apice nel sacrificio a Dio, come esaltazione massima dell’io religioso. Contro questo errore fondamentale, abbiamo già detto che la salvezza non sta nel fatto che noi moriamo per il Signore, ma nel fatto che lui muore per noi. Ciò che salva non è, anzitutto, amare, ma essere amati.Volere morire per Cristo, invece di accettare che lui muoia per noi, è il solito protagonismo di Adamo, che mette l’io al posto di Dio. Inoltre noi crediamo, erroneamente, che il morire per Gesù sia il massimo che si possa fare per meritarsi il suo amore. Ma «meritare» l’amore è meretricio. Si tratta Dio come se fosse una prostituta, i cui favori sono da pagare a prezzo di opere buone. Questo è il peccato del giusto, l’unico che va direttamente contro l’essenza di Dio, che è amore gratuito. L’amore o è gratuito o non è amore. Pretendere di meritarlo è distruggerlo. Infatti ci pone in un dilemma diabolico: se Dio lo concede, non è gratuito (ossia me lo sono meritato); se non lo concede è cattivo. Amare Dio fino a dare la vita può essere solo un dono che lui ci concede, una risposta possibile perché lui mi ha amato per primo ed è morto per me. Diversamente è orgoglio, come se io fossi Dio e, peggio ancora, come se Dio volesse la mia morte.Per questo, accettare di essere amato è più difficile che pretendere di amare. Noi possiamo amare Dio solo se accettiamo che lui ci ami per primo. Anche perché il nostro amore per lui non è che una piccola restituzione del suo amore per noi. In definitiva è far dipendere la nostra vita da lui e accettare di essere suoi.In questa pretesa di morire orgogliosamente per il Signore sono d’accordo anche tutti gli altri presenti alla cena (v. 31). È lo stesso atteggiamento che manifestarono quando tutti litigavano su chi tra loro fosse il più grande (9,35). L’epilogo di tutto questo parlare eccessivo e presuntuoso lo troviamo al v. 50: «Abbandonandolo, fuggirono tutti quanti».32 Giunsero intanto a un podere chiamato Getsèmani, ed egli disse ai suoi discepoli: «Sedetevi qui, mentre io prego». 33 Prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e cominciò a sentire paura e angoscia. 34 Gesù disse loro: «La mia anima è triste fino alla morte. Restate qui e vegliate». 35 Poi, andato un po’ innanzi, si gettò a terra e pregava che, se fosse possibile, passasse da lui quell’ora. 36 E diceva: «Abbà, Padre! Tutto è possibile a te, allontana da me questo calice! Però non ciò che io voglio, ma ciò che vuoi tu». 37 Tornato indietro, li trovò addormentati e disse a Pietro: «Simone, dormi? Non sei riuscito a vegliare un’ora sola? 38 Vegliate e pregate per non entrare in tentazione; lo spirito è pronto, ma la carne è debole». 39 Allontanatosi di nuovo, pregava dicendo le medesime parole. 40 Ritornato li trovò addormentati, perché i loro occhi si erano appesantiti, e non sapevano che cosa rispondergli.41 Venne la terza volta e disse loro: «Dormite ormai e riposatevi! Basta, è venuta l’ora: ecco, il Figlio dell’uomo viene consegnato nelle mani dei peccatori. 42 Alzatevi, andiamo! Ecco, colui che mi tradisce è vicino».È tipico di Marco raccontare la passione di Gesù in tutta la sua crudezza. Così appare chiaramente il contrasto del mistero di Cristo: Figlio di Dio, eppure abbandonato alla sofferenza. Nell’agonia del Getsemani (che significa frantoio per l’olio), Marco mette in risalto la debolezza di Gesù, la sua paura di fronte alla sofferenza, la sua angoscia di fronte alla morte.Tra tutti gli episodi della passione, la preghiera di Gesù nel Getsemani è uno dei più misteriosi. Ci sconcerta vedere Gesù che cade a terra (14,35), oppure leggere che egli «cominciò a sentire paura e angoscia» (14,33), e ascoltare le sue parole che riecheggiano il Sal 42,6: «La mia anima è triste fino alla morte». Mai, forse, riusciamo a sentire Gesù così vicino a noi, le sue reazioni così pienamente umane.Gesù prega: «Abbà, Padre! Tutto è possibile a te, allontana da me questo calice! Però non ciò che io voglio, ma ciò che vuoi tu!» (14,36). Si riflette, in queste parole, non solo un modo corretto di pregare, ma, soprattutto, un modo giusto di vivere. Gesù si rivolge a Dio chiamandolo «Abbà», cioè «Papà», e riconosce la sua onnipotenza («Tutto è possibile a te»). In questo modo la preghiera e la vita stessa di Gesù sono collocate in un’atmosfera di obbedienza e di fiducia. Ci si può fidare di Dio perché egli è il Papà; e nulla può disturbare o infrangere questa fiducia perché egli è onnipotente. Il rapporto con Dio ha perciò una solidità che il mondo non può distruggere né il tempo sgretolare.Poi viene la richiesta vera e propria: «Allontana da me questo calice!». È il desiderio spontaneo e comprensibile dell’uomo di fronte alla morte, con tutto quello che essa comporta di oscurità e angoscia.Gesù comincia la sua preghiera con l’espressione del suo desiderio umano; non lo nasconde, non lo censura, ma lo mette liberamente davanti all’amore e alla potenza del Padre.La preghiera però non termina qui. «Però non ciò che io voglio, ma ciò che vuoi tu».La preghiera può avere qualsiasi punto di partenza, ma ha un unico punto di arrivo: la volontà del Padre. Pregare significa accostarsi alla volontà di Dio fino a che essa diventi la nostra.Non c’è commento migliore a questo testo di quanto leggiamo nella lettera agli Ebrei: «Nei giorni della sua vita terrena, Gesù offrì preghiere e suppliche con forti grida e lacrime a colui che poteva liberarlo da morte e fu esaudito per la sua pietà; pur essendo Figlio, imparò tuttavia l’obbedienza dalle cose che patì e, reso perfetto, divenne causa di salvezza eterna per tutti coloro che gli obbediscono» (Eb 5,7–9).Di fronte alla prova Gesù manterrà la sua fedeltà mentre i discepoli riveleranno miseramente la propria debolezza. Questa diversità di risultato dipende dalla diversità di comportamento nel Getsemani: Gesù prega con insistenza (tre volte ripete la stessa preghiera), gli apostoli dormono «perché i loro occhi si erano appesantiti». Gesù stesso dà la spiegazione: «Vegliate e pregate per non entrare in tentazione; lo spirito è pronto, ma la carne è debole» (14,38).L’uomo è «carne», cioè debolezza; se non lo vivifica il rapporto vivo con Dio, si troverà a sperimentare la propria debolezza.Pietro, Giacomo e Giovanni sono i tre testimoni prescelti, chiamati per primi a contemplare la sofferenza di Dio per il male del mondo.Chi rimane qui e veglia, vede il grande mistero: la passione d’amore del suo Signore per lui.Nella trasfigurazione il Padre chiamò Gesù: «Figlio»: ora, nella sfigurazione, il Figlio lo chiama: «Papà». Là sul monte della trasfigurazione l’umanità di Gesù lasciò trasparire la sua divinità.. Qui, nel Getsemani, Dio lascia trasparire tutta la sua umanità. E nell’aspetto più disumano della nostra umanità (la sofferenza, l’agonia e la morte) egli manifesta la sua Gloria.L’agonia del Getsemani è la finestra aperta sull’io più intimo di Gesù. Le sue parole ci svelano il suo rapporto di Figlio col Padre, proprio nel momento decisivo della sua vita.Figlio, infatti, è colui che compie la volontà del Padre. Per questo «nei giorni della sua vita terrena egli offrì preghiere con forti grida e lacrime a colui che poteva liberarlo da morte e fu esaudito per la sua riverenza». Non fu però esaudito nel senso che fu esentato dalla morte; fu invece esaudito con la risurrezione, dopo aver «accettato bene» la morte, con riverenza filiale. Infatti «pur essendo Figlio, imparò tuttavia l’obbedienza dalle cose che patì, e, reso perfetto, divenne causa di salvezza eterna per tutti coloro che gli obbediscono» (Eb 5,7ss.).Gesù, prostrato, veglia e prega, compiendo il passaggio dalla sua volontà umana a quella divina del Padre. I discepoli, seduti, dormono nella debolezza della carne, chiusi nella loro volontà.La fede è il difficile passaggio dalla nostra volontà a quella di Dio: consiste nell’abbandonarsi al suo amore in cui crediamo al di là di tutte le nostre paure.L’agonia e la morte di Gesù abbattono il muro tra l’uomo e Dio. Gesù si immerge in tutte le nostre notti di angoscia e di smarrimento per portarvi la sua luce.43 E subito, mentre ancora parlava, arrivò Giuda, uno dei Dodici, e con lui una folla con spade e bastoni mandata dai sommi sacerdoti, dagli scribi e dagli anziani. 44 Chi lo tradiva aveva dato loro questo segno: «Quello che bacerò, è lui; arrestatelo e conducetelo via sotto buona scorta». 45 Allora gli si accostò dicendo: «Rabbì» e lo baciò. 46 Essi gli misero addosso le mani e lo arrestarono. 47 Uno dei presenti, estratta la spada, colpì il servo del sommo sacerdote e gli recise l’orecchio.48 Allora Gesù disse loro: «Come contro un brigante, con spade e bastoni siete venuti a prendermi.49 Ogni giorno ero in mezzo a voi a insegnare nel tempio, e non mi avete arrestato. Si adempiano dunque le Scritture!».50 Tutti allora, abbandonandolo, fuggirono. 51 Un giovanetto però lo seguiva, rivestito soltanto di un lenzuolo, e lo fermarono. 52 Ma egli, lasciato il lenzuolo, fuggì via nudo.Il racconto dell’arresto è incorniciato da due scene: l’arrivo di Giuda e la fuga di tutti. Gesù passa così da una compagnia ad un’altra: dal gruppo degli amici a quello dei nemici.«Tutti, allora, abbandonandolo, fuggirono». Si realizza così quello che Gesù stesso aveva predetto: «Percuoterò il pastore e le pecore saranno disperse» (14,27).Gesù protesta contro l’aggressione, ma vuole soprattutto manifestare che anche in questo avvenimento si sta compiendo il disegno di Dio: «Si adempiano dunque le Scritture!».L’episodio del giovinetto che tenta di seguire Gesù, ma viene fermato e fugge via nudo (forse è un ricordo autobiografico dello stesso evangelista), non fa che sottolineare la solitudine assoluta di Gesù: «Anche il più coraggioso fuggirà nudo in quel giorno» (Am 2,16).A chi viene a prenderlo per ucciderlo, Gesù dice: «Si compiano le Scritture». Ciò che sta accadendo è il compimento di ogni promessa di Dio.Qui finisce l’azione di Gesù e inizia la sua passione. Ma Gesù non ci ha salvati con la sua azione, ma con la sua passione.La parola chiave del brano è «impadronirsi». In questo gesto si esprime il peccato dell’uomo, che invece di prendere in dono, benedicendo il donatore e donando al bisognoso, prende in possesso, misconoscendo il Donatore e chiudendosi al fratello.Dio, essendo amore, è dono. Impadronirsi è l’azione antidivina per eccellenza: riporta tutto al caos, che si divora nuovamente ciò che Dio gli ha sottratto.Se Dio, per un solo attimo, volesse possedere ciò che ha e ciò che è, all’istante non ci sarebbe più nulla. Il possesso è la negazione del dono, e quindi di ogni creatura e dello stesso Creatore.Gli strumenti per impadronirsi sono denari, spade, bastoni, baci. Ma a noi che ci impadroniamo di lui, egli risponde rimanendo ciò che è: dono.Si dona e si abbandona nelle nostre mani, e ci lascia fare di lui quello che vogliamo. Ma mentre noi lo prendiamo, lo «comprendiamo», ossia capiamo la sua essenza di dono assoluto, che non si sottrae a nessun male. Quando afferriamo il Figlio dell’uomo, il nostro peccato afferra il perdono, le nostre tenebre afferrano la luce, la nostra morte afferra la vita. La vittoria del male diventa la sua sconfitta definitiva.Gesù che si consegna è il compimento di tutte le Scritture. Esse infatti raccontano la passione di Dio per noi, e promettono la salvezza di Dio per i peccatori.Il discepolo deve capire che è tra coloro che prendono. Tradisce, rinnega, fugge e lo abbandona, come tutti.A chi lo consegna, Dio si consegna, rivelandogli pienamente se stesso come amore e offerta di salvezza senza condizioni.Adamo, con il suo impadronirsi, si staccò da Dio e uscì dall’Eden nel caos; Gesù, col suo consegnarsi, ci riporta a Dio, facendo entrare l’Eden nel caos.Il bacio di Giuda diventa segno di colui che bisogna prendere. Invece che dono d’amore, è stravolto nel suo contrario. Il bacio di Giuda è anche ostentato. Kataphílesen, in greco, indica un bacio tenero, dato con abbandono e intensità.Pietro, come tutti, confida nelle stesse armi dell’avversario. Anche se vuole il bene, in realtà, è fra quelli che moltiplicano il male. Dio, essendo perdono e misericordia, trionfa proprio perdendo. Per fortuna, i discepoli sono più deboli degli altri, che diversamente avrebbero dovuto fuggire. Quando siamo più forti e cantiamo vittoria siamo i veri nemici di Gesù, il quale per causa nostra deve continuare la sua agonia nel Getsemani e non può giungere alla gloria della risurrezione perché noi gli impediamo di morire, credendo di fargli il più grande piacere.Egli avrebbe a disposizione dodici legioni di angeli (Mt 26,53); ma l’unica sua arma è sempre e solo la debolezza dell’amore che si consegna e si arrende, perché Dio è amore e nient’altro che amore.«Rendere giustizia con la violenza» è una contraddizione in termini (Sir 20,4). Pietro ama Gesù, ma non conosce il suo spirito. È ancora nel campo avversario, nello stesso gioco di spade, di bastoni, di denari, di baci falsi. Nonostante la sua buona volontà, è anche lui prigioniero di quel male per il quale Gesù sta morendo.L’arma con cui Gesù colpirà al cuore il nemico sarà la misericordia. Vince il male con il bene.Quante difese di Gesù non entrano nel suo spirito! Egli non ha nemici da vincere, ma fratelli da conquistare all’amore del Padre.Ogni volta che abbiamo un nemico da combattere, siamo lontani da lui, siamo suoi nemici anche noi. Tutte le nostre crociate non servono che a tagliare orecchi, ossia a togliere ai fratelli la capacità di ascoltare la misericordia di Dio, unica possibilità di conversione.La spada di Pietro è profezia di tutti gli strumenti di potere che noi discepoli abbiamo usato, usiamo e useremo, ritardando la venuta del suo regno in proporzione alla nostra forza.A chi ha poco discernimento, il diavolo accresce tanto la «buona volontà». Dio doni intelligenza a chi ha zelo, perché, a fin di bene, non operi con tanta «buona volontà» a favore del diavolo.In conclusione, tutte le velleità di Pietro e degli altri (v. 31) si riducono ad una fuga precipitosa. I discepoli abbandonano Gesù perché è debole. La loro fuga fa vedere che sono con lui fino a quando possono pensarlo come lo vogliono loro. Lo amano come proiezione dei loro desideri, ma non per ciò che è. Ma chi cerca il Signore per il Signore?53 Allora condussero Gesù dal sommo sacerdote, e là si riunirono tutti i capi dei sacerdoti, gli anziani e gli scribi.54 Pietro lo aveva seguito da lontano, fin dentro il cortile del sommo sacerdote; e se ne stava seduto tra i servi, scaldandosi al fuoco. 55 Intanto i capi dei sacerdoti e tutto il sinedrio cercavano una testimonianza contro Gesù per metterlo a morte, ma non la trovavano. 56 Molti infatti attestavano il falso contro di lui e così le loro testimonianze non erano concordi.57 Ma alcuni si alzarono per testimoniare il falso contro di lui, dicendo: 58 «Noi lo abbiamo udito mentre diceva: Io distruggerò questo tempio fatto da mani d’uomo e in tre giorni ne edificherò un altro non fatto da mani d’uomo».59 Ma nemmeno su questo punto la loro testimonianza era concorde. 60 Allora il sommo sacerdote, levatosi in mezzo all’assemblea, interrogò Gesù dicendo: «Non rispondi nulla? Che cosa testimoniano costoro contro di te?».61 Ma egli taceva e non rispondeva nulla. Di nuovo il sommo sacerdote lo interrogò dicendogli: «Sei tu il Cristo, il Figlio di Dio benedetto?». 62 Gesù rispose: «Io lo sono! E vedrete il Figlio dell’uomo seduto alla destra della Potenzae venire con le nubi del cielo».63 Allora il sommo sacerdote, stracciandosi le vesti, disse: «Che bisogno abbiamo ancora di testimoni? 64 Avete udito la bestemmia; che ve ne pare?». Tutti sentenziarono che era reo di morte.65 Allora alcuni cominciarono a sputargli addosso, a coprirgli il volto, a schiaffeggiarlo e a dirgli: «Indovina». I servi intanto lo percuotevano.Gli avversari di Gesù ci sono proprio tutti al processo e al momento della condanna (vv. 53.55.64). A dire il vero, non è un tribunale obiettivo nel quale si cerca di appurare la verità, ma un conciliabolo nel quale si tenta di provocare con tutti i mezzi la condanna: «I capi dei sacerdoti e tutto il sinedrio cercavano una testimonianza contro Gesù per metterlo a morte» (v. 55). Ma nemmeno in questo modo il processo ottiene un’apparenza di legalità: «Cercavano una testimonianza contro Gesù, ma non la trovavano».Per condannare qualcuno ci volevano almeno due testimonianze concordi (Dt 19,15). Si dovevano perciò confrontare le deposizioni, e i falsi testimoni venivano puniti con la pena comminata all’accusato (Dt 19,16–21), come avvenne nel processo di Susanna (Dn 13,44–62), che somiglia stranamente a quello di Gesù. Fra le testimonianze presentate contro Gesù non c’è accordo, come osserva Marco per due volte (14,56.59).L’unico testimone veritiero, in definitiva, è Gesù stesso. Ma le sue dichiarazioni possono dar luogo alle interpretazioni più fantasiose. Perciò tace. Questo silenzio ci richiama immediatamente quello del servo sofferente di Iahvè: «Maltrattato, si lasciò umiliare e non aprì la sua bocca; era come agnello condotto al macello, come pecora muta di fronte ai suoi tosatori, e non aprì la sua bocca» (Is 53,7).Gesù tace davanti alle calunnie false e infondate, ma risponde senza esitazione quando gli viene rivolta una domanda seria e importante: «Sei tu il Cristo, il Figlio di Dio benedetto?». Gesù risponde: «Io lo sono! E vedrete il Figlio dell’uomo seduto alla destra della Potenza e venire con le nubi del cielo» (vv. 61–62). La risposta di Gesù unisce due testi importanti dell’Antico Testamento: il Sal 110, salmo di intronizzazione messianica, e Dn 7,13, un testo apocalittico che riconduce la storia del mondo al dominio finale del «Figlio dell’uomo». Gesù si presenta quindi come il Re–Messia atteso, come il Figlio dell’uomo al quale sarà conferito «un potere eterno, che non tramonta mai e il suo regno è tale che non sarà mai distrutto» (Dn 7,14). A coloro che vogliono eliminarlo, Gesù annunzia che la sua morte imminente significa il suo passaggio al Padre e la gloria del Figlio dell’uomo.Il sommo sacerdote si strappa le vesti, come doveva fare chi sentiva proferire una bestemmia, benché tale gesto fosse interdetto al sommo sacerdote (Lv 21,10). Un vestito strappato in caso di lutto, di disgrazia o di bestemmia, non poteva essere riparato. Così lo strappo assume nel vangelo un significato simbolico: il regime della legge interpretata secondo le tradizioni umane (cf. 7,9.13) volge al termine. Come capo della comunità, il sommo sacerdote rappresenta questa rottura in seno al popolo di Dio: Gesù è il segno di contraddizione tra la fede e l’incredulità (cf. Nm 14,6). A questa lacerazione corrisponderà lo squarcio del velo del santuario (15,38) come se Dio a sua volta gridasse alla bestemmia di fronte alla morte del proprio Figlio. Ricordiamo, per contrasto, che la tunica di Gesù, «tessuta tutta d’un pezzo da cima a fondo» (Gv 19,23), non fu stracciata. L’abito del sommo sacerdote doveva essere senza cuciture.Probabilmente qui Marco vuole dire che con questo gesto del sommo sacerdote finiva il sacerdozio antico; come Giovanni probabilmente nella tunica intatta di Cristo voleva alludere al nuovo sacerdozio di Cristo in croce.Alla sentenza unanime di morte, segue una scena oltraggiosa. Gli sputano addosso, come al servo di Iahvè: «Non ho sottratto il mio volto agli oltraggi e agli sputi» (Is 50,6). Questo è il preludio dell’ignominia finale (cf. Is 53,1–12).Gesù risponde al sommo sacerdote: «Io sono» confermando così per la prima volta la sua identità di Cristo e di Figlio di Dio, e proclamandosi Figlio dell’uomo, giudice supremo di tutta la storia.Il vangelo sfocia in questa sua autotestimonianza che risolve ogni mistero e sarà causa della sua condanna. Ma la sua uccisione sarà il sigillo di autenticità della sua rivelazione. Ai piedi della croce siamo invitati a dire con il centurione: «Veramente quest’uomo era Figlio di Dio» (15,39).Tutto il vangelo di Marco è stato scritto per rispondere alla domanda: «Chi è Gesù?». Ora lui stesso risponde direttamente, dicendo la propria identità. Qui finisce il «segreto messianico» e ogni segreto; e comincia ogni nostra comprensione di Gesù e di Dio.Ogni teologia (il parlare su Dio) deve partire dalla visione della croce, diversamente è una proiezione dei nostri desideri (8,33) avvelenati dalla falsa immagine di Dio. La croce è la differenza «irriducibile» tra il cristianesimo e ogni altra religione, compresi l’islamismo e l’ebraismo. In nessun dialogo inter–religioso si deve togliere questo «scandalo», che è inciampo e salvezza per tutti. Solo partendo da questo il cristianesimo ha qualcosa di assolutamente inaudito da dire, significativo anche per l’uomo moderno.Il problema della fede cristiana non si pone prima della croce, che è appunto la distanza infinita che Dio ha posto tra sé e ogni nostra cattiva fantasia su di lui. Lì Gesù rivela per la prima volta che è Dio e si rivela Dio.Per noi cristiani, la croce è diventata troppo ovvia, spesso ridotta a ornamento o ad amuleto religioso. In realtà un Dio che è un uomo, e per di più crocifisso, suona bestemmia per tutte le religioni e per tutti gli ateismi. Questa bestemmia, che critica ogni religione e ateismo, è l’essenza della fede cristiana: è la stoltezza e debolezza alla quale arriva la sapienza e la potenza di un Dio che è solo e tutto amore per l’uomo. Per questo san Paolo compendia ogni suo sapere con le parole: «Io ritenni di non sapere altro in mezzo a voi se non Gesù Cristo, e questi crocifisso» (1Cor 2,2).La fede cristiana consiste nell’accettare come proprio Salvatore, Dio e Giudice (v. 62), l’uomo Gesù che va in croce per noi. Egli è la fine di ogni falsa speranza dell’uomo, di ogni raffigurazione di Dio come nostro antagonista, e di ogni giudizio dell’uomo che pretenda di autosalvarsi e autogiustificarsi. Ai piedi della croce si dissolve ogni menzogna, e inizia la verità che ci fa liberi (Gv 8,32). Davanti a un Dio così diverso dalle nostre opinioni, la reazione di tutti è il rifiuto.Il sommo sacerdote lo accusa di bestemmia, tutti sentenziano che è reo di morte, i servi lo dileggiano e Pietro, in rappresentanza dei cristiani di tutti i tempi, professa di non conoscerlo.Gesù sarà condannato non per testimonianza altrui, ma per «questa» sua rivelazione.Gesù è il Salvatore perché si perde per noi. È il Signore perché porta su di sé il nostro male. È il giudice perché si lascia condannare in vece nostra. Così ci fa conoscere cos’è la salvezza, chi è Dio e quale è il suo giudizio: l’amore di uno che sa perdersi senza riserve per tutti i perduti.Ogni cristiano è chiamato a conoscerlo così com’è, e non come l’aveva pensato. Gesù viene condannato innocente. Se così non fosse non ci giustificherebbe: sarebbe giustamente condannato per il proprio peccato e non morrebbe da giusto, per il nostro peccato.Davanti al sinedrio e ai falsi testimoni Gesù tace, come il giusto del Sal 38,14–15. Il suo silenzio è di grande importanza per Marco. Lo sottolinea due volte davanti al sinedrio e due volte davanti a Pilato (15,4). Se avesse risposto alle accuse, dimostrandole false, sugli accusatori sarebbe caduta la pena prevista per lui. Ma egli è l’agnello di Dio che porta il peccato del mondo (Gv 1,29), muto davanti ai suoi tosatori (Is 53,7). Non apre bocca e si lascia giudicare, affinché non siamo condannati noi. Questo suo silenzio, espressione massima di misericordia, è la rivelazione estrema di Dio, cui risponde la nostra riverente adorazione. Il silenzio di Dio è segno della sua gloria irraggiungibile: «Egli non ha da rispondere» (Gb 37,23).Gesù muore per un reato preciso: la parola con cui si dichiara Dio e rivela un Dio così scandalosamente diverso da tutti i nostri idoli e da tutte le nostre filosofie e teologie.Gesù fu accusato di bestemmia già nel suo primo miracolo pubblico, quando rivelò il suo «potere», che appartiene solo a Dio: perdonare i peccati. «Perché costui parla così? Bestemmia!» (2,6). La bestemmia è una parola contro Dio. In effetti la parola di Gesù suona bestemmia ai nostri orecchi perché demolisce ogni immagine che l’uomo si fa di Dio.La forza di Dio è debolezza, colpita dalla nostra violenza (Is 53,5). Non sottrae la sua faccia agli sputi e alle percosse (Is 50,6). I servi, umiliati e frustrati, duplicano subito il male, appena trovano uno più debole su cui sfogarsi. Attraverso i loro sputi e le loro percosse, è tutto il male del mondo che si riversa su di lui.66 Mentre Pietro era giù nel cortile, venne una serva del sommo sacerdote 67 e, vedendo Pietro che stava a scaldarsi, lo fissò e gli disse: «Anche tu eri con il Nazareno, con Gesù». 68 Ma egli negò: «Non so e non capisco quello che vuoi dire».. Uscì quindi fuori del cortile e il gallo cantò. 69 E la serva, vedendolo, ricominciò a dire ai presenti: «Costui è di quelli».70 Ma egli negò di nuovo. Dopo un poco i presenti dissero di nuovo a Pietro: «Tu sei certo di quelli, perché sei Galileo».71 Ma egli cominciò a imprecare e a giurare: «Non conosco quell’uomo che voi dite». 72 Per la seconda volta un gallo cantò. Allora Pietro si ricordò di quella parola che Gesù gli aveva detto: «Prima che il gallo canti due volte, mi rinnegherai per tre volte». E scoppiò in pianto.«Lo spirito è pronto, ma la carne è debole» aveva detto Gesù nel Getsemani, e il rinnegamento di Pietro è la prova più evidente delle parole di Gesù. Lui che a Cesarea aveva proclamato: «Tu sei il Cristo», ora impreca e giura: «Non conosco quell’uomo che voi dite». Lo conosceva quando faceva miracoli e attirava le folle; lo conosceva quando predicava con autorità. Ma adesso è un prigioniero, un condannato, umiliato e percosso.Allora conveniva, ora no. Ma anche questo era già stato scritto: «Sono un estraneo per i miei fratelli, un forestiero per i figli di mia madre... Ho atteso compassione, ma invano, consolatori, ma non ne ho trovati» (Sal 69,9–21).Tuttavia, anche se Pietro non conosce più Gesù, è pur sempre vero che Gesù conosce Pietro. Il canto del gallo richiama alla mente di Pietro le parole che Gesù aveva detto annunciando il suo rinnegamento. Dunque Gesù «sapeva». «Allora Pietro si ricordò della parola che Gesù gli aveva detto ... e scoppiò in pianto». La predizione di questo rinnegamento era già un segno di perdono e di amore. Questo perdono lo fa piangere, in attesa che Maria di Magdala venga a toglierlo dalla sua tristezza (16,10).Questo brano è il punto di arrivo dell’esperienza di Pietro, esemplare per ogni discepolo.Pietro, non riconoscendo e rinnegando tre volte il suo Maestro, non mente. Confessa la propria verità: non è con lui, non è di quelli che sono suoi discepoli, non conosce quest’uomo. Lui conosce un altro Cristo, per il quale era anche disposto a morire; questo invece, povero e umiliato, lo sconcerta e lo scandalizza.Solo il suo pianto squarcia il velo che gli nasconde Gesù, e scopre insieme la sua verità di uomo che non conosce il Signore, e la verità di Dio che muore per lui che lo rinnega. Al di là di ogni illusione, vede finalmente se stesso.Le lacrime di Pietro sono il battesimo del cuore. Lo purificano e lo illuminano. Lui non è quello che crede di essere; si smentisce come discepolo e perde la sua presunta identità. Deve constatare che non è capace di morire per Gesù, mentre Gesù, senza tante parole, anzi, in silenzio, muore per lui.Gesù vuole bene a Pietro, non perché è bravo, ma perché gli vuole bene gratis. Non gli perdona perché è pentito, ma può pentirsi perché da sempre è perdonato.Il discepolo accetta l’amore gratuito di Gesù come principio della propria vita. La vera conversione, quella dalla legge al vangelo, è il passaggio dal mio amore per Dio al suo amore per me. Il mio peccato diventa il luogo in cui lo esperimento inequivocabilmente.La fede si fonda sulla certezza non della mia fedeltà a lui, ma della sua a me. Nulla mi potrà separare dall’amore che Dio ha per me in Cristo Gesù (Rm 8,31–39).Un elemento importante di questo brano è la frase: «E Pietro ricordò la parola che gli aveva detto Gesù» (v.72). Senza questa parola, Pietro sarebbe perduto. Essa gli ricorda che il Signore lo ha scelto sapendo che l’avrebbe rinnegato, e gli garantisce che il Signore lo conosce e lo ama così com’è.
CAPITOLO 15
1 Al mattino i sommi sacerdoti, con gli anziani, gli scribi e tutto il sinedrio, dopo aver tenuto consiglio, misero in catene Gesù, lo condussero e lo consegnarono a Pilato. 2 Allora Pilato prese a interrogarlo: «Sei tu il re dei Giudei?». Ed egli rispose: «Tu lo dici». 3 I sommi sacerdoti frattanto gli muovevano molte accuse. 4 Pilato lo interrogò di nuovo: «Non rispondi nulla? Vedi di quante cose ti accusano!». 5 Ma Gesù non rispose più nulla, sicché Pilato ne restò meravigliato.6 Per la festa egli era solito rilasciare un carcerato a loro richiesta. 7 Un tale chiamato Barabba si trovava in carcere insieme ai ribelli che nel tumulto avevano commesso un omicidio. 8 La folla, accorsa, cominciò a chiedere ciò che sempre egli le concedeva. 9 Allora Pilato rispose loro: «Volete che vi rilasci il re dei Giudei?». 10 Sapeva infatti che i sommi sacerdoti glielo avevano consegnato per invidia. 11 Ma i sommi sacerdoti sobillarono la folla perché egli rilasciasse loro piuttosto Barabba. 12 Pilato replicò: «Che farò dunque di quello che voi chiamate il re dei Giudei?». 13 Ed essi di nuovo gridarono: «Crocifiggilo!». 14 Ma Pilato diceva loro: «Che male ha fatto?». Allora essi gridarono più forte: «Crocifiggilo!». 15 E Pilato, volendo dar soddisfazione alla moltitudine, rilasciò loro Barabba e, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso.16 Allora i soldati lo condussero dentro il cortile, cioè nel pretorio, e convocarono tutta la coorte. 17 Lo rivestirono di porpora e, dopo aver intrecciato una corona di spine, gliela misero sul capo. 18 Cominciarono poi a salutarlo: «Salve, re dei Giudei!». 19 E gli percuotevano il capo con una canna, gli sputavano addosso e, piegando le ginocchia, si prostravano a lui. 20 Dopo averlo schernito, lo spogliarono della porpora e gli rimisero le sue vesti, poi lo condussero fuori per crocifiggerlo.La comparsa di Gesù davanti a Pilato viene presentata da Marco dopo una nuova riunione del sinedrio al completo, tenutasi al mattino. Non si parla di testimoni, ma Pilato a sua volta istituisce un vero processo: lui interroga, i sommi sacerdoti fungono da accusatori. Improvvisamente l’interrogatorio assume una svolta politica: il capo d’accusa diventa la rivendicazione da parte di Gesù del titolo di «re dei Giudei» (15,2.9.12.18.26). Questo titolo è evidentemente ambiguo. Gesù è re dei giudei, ma in senso diverso da quello che Pilato poteva intendere. C’è un equivoco, certamente, ma a che scopo farlo notare? Il procuratore romano non può giudicare che sul piano della sua competenza, il piano politico. Così Gesù entra definitivamente nel silenzio. Solo la testimonianza della sua morte potrà aprire i pagani a qualcosa di diverso dalle realtà terrene. Pensiamo nuovamente al Servo sofferente e umiliato (Is 53,7), il cui atteggiamento meraviglia le genti (Is 52,15), come quello di Gesù stupisce Pilato (15,5.44). Il racconto di Marco, volutamente stilizzato, passa all’episodio di Barabba, proposto da Pilato come moneta di scambio per liberare Gesù. Nessun documento, al di fuori dei vangeli, accenna ad un’amnistia del genere da parte di Pilato, il quale non passava per generoso agli occhi degli ebrei: aveva represso duramente molte sommosse, e finirà per essere rimosso dalle sue funzioni nel 36 d.C., in seguito ad un rapporto negativo fatto pervenire a Roma da parte del suo superiore Vitellio, legato di Siria. Nei vangeli Pilato appare come un diplomatico ambizioso e opportunista, che cerca di conciliarsi le autorità politiche come Erode (Lc 23,6–12) o religiose come i sommi sacerdoti, ma soprattutto la folla.Consegnando Gesù a Pilato, senza lapidarlo come bestemmiatore, i sommi sacerdoti lo fanno passare come un agitatore; ma Pilato non avalla questa accusa perché lo dichiara non colpevole. Lo condanna per paura e opportunismo. E questa condanna appare come una mascherata ridicola e tragica. Ma leggiamo la profezia: «Ho presentato il dorso ai flagellatori, la guancia a coloro che mi strappavano la barba; non ho sottratto la faccia agli insulti e agli sputi» (Is 50,6); «Disprezzato e reietto dagli uomini, uomo dei dolori che ben conosce il patire, come uno davanti al quale ci si copre la faccia, era disprezzato e non ne avevamo alcuna stima. Eppure egli si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato i nostri dolori e noi lo giudicavamo castigato, percosso da Dio e umiliato...Maltrattato, si lasciò umiliare e non aprì la sua bocca; era come agnello (servo: talja’ in lingua aramaica; cf. Gv 1,29) condotto al macello, come pecora muta di fronte ai suoi tosatori, e non aprì la sua bocca. Con oppressione e ingiusta sentenza fu tolto di mezzo; chi si affligge per la sua sorte? Sì, fu eliminato dalla terra dei viventi, per l’iniquità del mio popolo fu percosso a morte. Gli si diede sepoltura con gli empi, con il ricco fu il suo tumulo, sebbene non avesse commesso violenza né vi fosse inganno nella sua bocca. Ma al Signore è piaciuto prostrarlo con dolori. Quando offrirà se stesso in espiazione, vedrà una discendenza, vivrà a lungo, si compirà per mezzo suo la volontà del Signore» (Is 53,3–10).Come aveva detto a proposito del figlio unico ucciso dai vignaioli fuori della vigna (12,8), Gesù, il re dei giudei, viene condotto fuori dalla città per essere crocifisso. Nella lettera agli Ebrei leggiamo: «I corpi degli animali, il cui sangue viene portato nel santuario dal sommo sacerdote per i peccati, vengono bruciati fuori dell’accampamento. Perciò, anche Gesù, per santificare il popolo con il proprio sangue, patì fuori della porta della città» (Eb 13,11–12; cf. Lv 16).L’unica colpa di Gesù è che serve invece di dominare. Il popolo lo rifiuta come re e chiede per lui la morte dello schiavo: «Crocifiggilo!».Il re infatti spadroneggia sui sudditi e li rende suoi servi, togliendo loro ciò che li rende simili a Dio: la libertà. Il re è un Dio capovolto, la cui intelligenza scambia il vero con l’utile, la cui volontà sostituisce l’amore con l’egoismo, la cui azione mira al potere invece che al servizio. È una caricatura d’uomo, è l’uomo fallito! Gli strumenti che usa sono le spade e i bastoni per sottomettere i nemici; i denari e i favori per tenere in mano gli amici.Dio aveva promesso a Israele di liberarlo, mandando un re che lo avrebbe veramente rappresentato, anzi, regnando lui stesso. Il regno di Dio, nocciolo della predicazione di Gesù, è la grande attesa dei contemporanei. Questa promessa ora si realizza: Gesù è il re autentico, libero da ogni potere, capace di testimoniare la verità di Dio (Gv 18,37). Infatti, si fa schiavo di tutti, donando tutto, fino al dono di sé.Il seguito del racconto procede come un solenne cerimoniale di corte: la condanna a morte è l’editto che lo proclama re; il dileggio dei soldati è la sua coronazione; la via della croce è il corteo trionfale; la crocifissione la sua intronizzazione. Dall’alto del suo trono, infine, esercita il suo potere: invece di uccidere i nemici, muore per loro, uccidendo la morte, nemica ultima di tutti.Gesù appare ora in solitudine assoluta. Lui che si è abbandonato nelle mani di tutti perché nessuno si sentisse solo, sperimenta l’abbandono di tutti, anche del Padre.Questa solitudine è la sua forza divina di una solidarietà estrema con tutti. Nessuno lo desidera più. Un Dio e un re così è rifiutato da tutti. Anche la folla, fino a ieri osannante, lo vuole morto. Barabba rappresenta tutti noi, uomini falliti e meritevoli di morte, che siamo salvati per la sua morte.Gesù è re. Egli è l’uomo libero e potente che ci salva proprio perché ama fino a farsi schiavo e impotente, portando su di sé la morte di tutti. È il Signore che regna, e dà la libertà a tutti gli oppressi (Sal 146); la sua condanna alla morte di croce è il prezzo della nostra libertà.A questo punto del vangelo, il discepolo non può non identificarsi con Barabba, il delinquente condannato a morte, al cui posto viene ucciso l’innocente. È la grazia concessa in occasione della Pasqua di morte e risurrezione di Gesù.. Tutti i disgraziati sono graziati, perché al loro posto Gesù subisce la morte a favore di tutti.Barabba significa «figlio del padre»: è il nome che si dava ai figli di genitori ignoti. Figlio di nessuno, ribelle, omicida, legato in catene, in attesa dell’esecuzione capitale, è l’uomo, specchio di ognuno di noi. Infatti, dopo il peccato, ignorando il Padre, siamo figli e fratelli di nessuno, e viviamo l’uno contro l’altro, reclusi come in carcere, aspettando di subire la nostra morte dopo averla data ad altri.«Pilato sapeva che i sommi sacerdoti gli avevano consegnato Gesù per invidia» (v. 10). La morte, entrata nel mondo per invidia del diavolo (Sap 2,24), entra ora in Dio per l’invidia dell’uomo. L’invidia è l’incapacità di godere del bene altrui e la brama di possederlo in proprio, anche a costo di sopprimere l’altro. È il sentimento più umano e più contrario a Dio: l’egoismo.Al suo opposto c’è la lode, che consiste nel godere del bene altrui. Dio è lode e gioia per tutte le sue creature, in particolare per l’uomo. Il suo occhio si compiace della creazione intera (Gen 1), e il suo cuore gode di tutte le sue opere (Sal 104,31).Lodare è la nostra salvezza, perché ci fa gioire della sua stessa gioia, godere del suo stesso bene più che se fosse nostro. La lode, espressione perfetta di amore, è la nostra somiglianza con Dio. L’invidia e la lode fanno, rispettivamente, della nostra vita un inferno o un paradiso.Come Gesù, anche Abele il giusto fu ucciso per invidia; per lo stesso motivo anche il patriarca Giuseppe fu venduto dai fratelli, e così li salvò.La folla è facilmente sobillabile perché ha lo stesso modo di pensare dei capi, che per questo appunto sono i suoi capi! Anch’essa non sa che farsene di un Cristo debole: «Fu crocifisso per la sua debolezza» (2Cor 13,4). Proprio qui e così Dio si rivela il Signore della misericordia e il Salvatore dall’egoismo.21 Allora costrinsero un tale che passava, un certo Simone di Cirene che veniva dalla campagna, padre di Alessandro e Rufo, a portare la croce. 22 Condussero dunque Gesù al luogo del Gòlgota, che significa luogo del cranio, 23 e gli offrirono vino mescolato con mirra, ma egli non ne prese.24 Poi lo crocifissero e si divisero le sue vesti, tirando a sorte su di esse quello che ciascuno dovesse prendere. 25 Erano le nove del mattino quando lo crocifissero. 26 E l’iscrizione con il motivo della condanna diceva: Il re dei Giudei. 27 Con lui crocifissero anche due ladroni, uno alla sua destra e uno alla sinistra. 28 .29 I passanti lo insultavano e, scuotendo il capo, esclamavano: «Ehi, tu che distruggi il tempio e lo riedifichi in tre giorni, 30 salva te stesso scendendo dalla croce!». 31 Ugualmente anche i sommi sacerdoti con gli scribi, facendosi beffe di lui, dicevano: «Ha salvato altri, non può salvare se stesso! 32 Il Cristo, il re d’Israele, scenda ora dalla croce, perché vediamo e crediamo».. E anche quelli che erano stati crocifissi con lui lo insultavano.33 Venuto mezzogiorno, si fece buio su tutta la terra, fino alle tre del pomeriggio. 34 Alle tre Gesù gridò con voce forte: Eloì, Eloì, lemà sabactàni?, che significa: Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? 35 Alcuni dei presenti, udito ciò, dicevano: «Ecco, chiama Elia!». 36 Uno corse a inzuppare di aceto una spugna e, postala su una canna, gli dava da bere, dicendo: «Aspettate, vediamo se viene Elia a toglierlo dalla croce». 37 Ma Gesù, dando un forte grido, spirò.38 Il velo del tempio si squarciò in due, dall’alto in basso.39 Allora il centurione che gli stava di fronte, vistolo spirare in quel modo, disse: «Veramente quest’uomo era Figlio di Dio!».40 C’erano anche alcune donne, che stavano ad osservare da lontano, tra le quali Maria di Màgdala, Maria madre di Giacomo il minore e di Ioses, e Salome, 41 che lo seguivano e servivano quando era ancora in Galilea, e molte altre che erano salite con lui a Gerusalemme.Il racconto di Marco è sobrio e preciso, senza esprimere sentimenti. Appare inquadrato dal gesto di Simone di Cirene e dall’attenta presenza delle donne di Galilea venute a Gerusalemme (15,21.40–41).Per quanto riguarda Simone, si dice che è di Cirene (Africa del nord). Marco è il solo che parla dei suoi figli, Alessandro e Rufo, noti probabilmente nella comunità di Roma, perché san Paolo sembra alludere al secondo in Rm 16,13.. Fermato dai soldati, porta la croce dietro a Gesù, come avrebbero dovuto fare i discepoli (8,34).Anche le donne vengono ricordate per nome: Maria di Magdala, villaggio sulle rive del lago di Tiberiade, che Gesù aveva liberata da sette demoni (16,9); Maria madre di Giacomo il minore e di Ioses «fratelli di Gesù» (6,3); Salome, o secondo Matteo, «la madre dei figli di Zebedeo» (Mt 27,56), che una tradizione ha identificato con quella che Giovanni chiama «sorella di sua madre» (Gv 19,25). Esse lo seguivano e lo servivano in Galilea, ed erano salite con lui a Gerusalemme (10,32).Il racconto preciso della crocifissione è narrato sulla falsariga dell’Antico Testamento, e, in particolare, del Sal 22. Numerosi particolari, che Marco nota, trovano riscontro in questo salmo: la divisione delle vesti tra i soldati che crocifissero Gesù (Mc 15,24 = Sal 22,19); i passanti che scuotono il capo (Mc 15,29 = Sal 22,8); e soprattutto quel grido sconvolgente che esce dalla bocca del Crocifisso: «Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?» (Mc 15,34 = Sal 22,2). Se a questo aggiungiamo che il riferimento all’aceto offerto da bere a Gesù (Mc 15,36) richiama il Sal 69,22, si vede bene come uno dei temi costanti di Marco è il riferimento ai salmi del giusto sofferente. Gesù ha fatto propria questa sofferenza, ha preso su di sé l’angoscia di tutti i giusti che non hanno veduto nella loro esistenza la giustizia di Dio.Prima della morte, dobbiamo assistere ad un’ultima scena: quella degli oltraggi rivolti al Crocifisso. Sono anzitutto i passanti che lo oltraggiano, poi i sommi sacerdoti e gli scribi, poi quelli che sono stati crocifissi con lui. Perfino i delinquenti si sentono superiori nei confronti di Gesù! Il loro atteggiamento è comprensibile. L’uomo è abituato a ragionare sulla base dei risultati, del successo: tutto il resto gli sembra illusione e chiacchiere vuote. I risultati, a questo punto, danno torto a Gesù. Può aver fatto tutti i miracoli che vuole, può aver detto parole sacrosante, ma ora deve ammettere che è impotente e perdente. Dunque la sua forza era falsa, le sue parole illusorie; dunque avevano ragione loro, i capi dei giudei, a non credere. Così ragionavano gli uomini duemila anni fa e così ragionano ancor oggi. Liberarsi dal fascino dell’efficienza richiede una forza interiore straordinaria che l’uomo normale non possiede.Giungiamo così all’episodio decisivo della passione, un episodio sconvolgente: «Venuto mezzogiorno, si fece buio su tutta la terra fino alle tre del pomeriggio». Si realizza cioè quello che il profeta Amos aveva annunciato per il «giorno del Signore»: «In quel giorno – oracolo del Signore Dio – farò tramontare il sole a mezzodì e oscurerò la terra in pieno giorno! Cambierò le vostre feste in lutto... ne farò come un lutto per un figlio unico» (Am 8,9–10).«Alle tre Gesù gridò con voce forte: «Eloì, Eloì, lemà sabactàni?» che significa: Dio mio, Dio mio, perché mi ha abbandonato?». Insieme con l’episodio del Getsemani, queste parole sono le più misteriose di tutto il racconto della passione. Per comprenderle è utile ricordare che si tratta dell’inizio del Sal 22, il salmo di fiducia dell’uomo sofferente. Ma anche questo non toglie del tutto lo sgomento di fronte al fatto che Gesù di Nazaret, il Figlio prediletto nel quale il Padre si compiace, possa sentire l’abbandono di Dio. Eppure che cos’altro poteva sperimentare sul Calvario? Perché sul Calvario Dio non si fa vedere. Ci sono i soldati che hanno crocifisso Gesù, ci sono le persone che l’hanno schernito, ci sono i due crocifissi con lui, ma Dio no. Dio sembra il grande assente. Eppure è suo Figlio che viene crocifisso. L’unico vero innocente viene ucciso e Dio tace.Ma era necessario che così avvenisse perché lui, giusto, doveva conoscere la sofferenza di tutti i giusti che, come Giobbe, si sono turbati davanti al silenzio di Dio. Quanti hanno sentito l’angoscia dell’assenza di Dio nel momento del loro dolore! A quanti Dio ha chiesto di fidarsi senza dar loro alcun segno esterno credibile! Gesù doveva conoscere tutto questo per riscattarlo con la sua preghiera. Perché, per quanto angoscioso, il grido di Gesù è una preghiera dove Dio è ancora il «tu», l’interlocutore di Gesù, l’unico al quale può ancora appellarsi e al quale può affidare la sua causa. Gesù non maledice quelli che l’hanno crocifisso, né contesta Dio, ma prega. Prega come hanno pregato i giusti senza alcun appiglio.«Ma Gesù, dando un forte grido, spirò». È un grido inarticolato che esprime l’incomprensibilità umana di quanto avviene sul Calvario. Tuttavia, paradossalmente, è proprio in questo momento che incontriamo la più esplicita professione di fede sulla bocca di un uomo: «Allora il centurione che gli stava di fronte, vistolo spirare in quel modo, disse: «Veramente quest’uomo era Figlio di Dio!»».. Nel contesto di Marco, queste parole sono un’anticipazione della professione di fede che si diffonderà tra i pagani.Il velo del tempio che si squarcia da cima a fondo sembra un’anticipazione della rovina del tempio annunciata da Gesù: il tempio antico è distrutto, il nuovo tempio sta per innalzarsi su colui che Israele ha rigettato: «La pietra che i costruttori hanno scartata è divenuta testata d’angolo» (12,10). Il Crocifisso del calvario è diventato il vero tempio e il santuario senza veli, da cui si irradia per tutti la presenza di Dio.È a questo punto della narrazione che compaiono dei personaggi nuovi, delle donne salite a Gerusalemme dalla Galilea insieme con Gesù, come testimoni a distanza della morte di Gesù.. Marco fa il nome di tre, che avranno un ruolo nei due episodi seguenti.«Lo crocifissero». Con questa parola cruda si indica ciò che gli uomini fanno al Figlio dell’uomo. Consegnato nelle loro mani, prestano il loro servizio a colui che è venuto a servirli: gli inchiodano le mani alla croce. Il patibolo dello schiavo diventa il suo trono regale. Qui, come ultimo e servo di tutti, realizza pienamente la regalità di Dio. Dio regna su tutti perché porta il peso di tutti. Fu crocifisso per la sua debolezza (2Cor 13,4). È la debolezza di chi, amando, fa suo tutto il male dell’amato. L’amore è una malattia mortale che solo Dio, pienezza di vita, può sopportare.Paolo diceva: «Io ritenni di non sapere altro in mezzo a voi se non Gesù Cristo, e questi crocifisso» (1Cor 2,2). Gesù crocifisso è scandalo per la religione, stupidità per la ragione, ma è potenza e sapienza di Dio, del Dio–Amore. La carne di Gesù in croce ne è l’esibizione totale.La sapienza dell’uomo è affermare se stesso, servendosi degli altri; la sua potenza è possedere, dominare ed esaltarsi. La sapienza di Dio invece è affermare l’amato servendolo; la sua potenza è spogliarsi di tutto, anche del proprio io, abbassandosi fino alla morte, e alla morte di croce.La croce è il suo giudizio, con cui convince di stoltezza la nostra sapienza e di impotenza la nostra potenza. In Gesù egoismo e morte sono vinti definitivamente.Gesù crocifisso è re. Egli è l’uomo libero, immagine di Dio, che ama e serve a sue spese, caricandosi del male di tutta la nostra debolezza e stupidità.Il discepolo riconosce nella persona di Gesù la potenza e la sapienza di Dio che è amore senza condizioni e senza misura.Tutti gridano al Crocifisso: «Salva te stesso!». Salvarsi è la molla profonda di ogni attività dell’uomo. Il suo pulsante è la paura della morte che, travestita da ansia di vita, suggerisce ad ogni istante il motto segreto: «Salva te stesso, pensa a te, ai tuoi interessi, a ciò che ti garantisce di sopravvivere». L’amor proprio, che in realtà è odio di sé e degli altri, pervade ogni nostra intenzione, azione e operazione, ed è padre di tutti i mali.Chi vuol salvare la propria vita la perde, vittima dell’egoismo che lo distrugge come immagine di Dio. Chi invece sa perderla la salva (8,35). Diventa come Dio, amore che dà tutto, anche se stesso, e proprio così è se stesso. Gesù perdendosi per noi perduti, salva la sua vita e la nostra, realizzando in sé e donando a noi un amore più forte della stessa morte.Ai piedi della croce esce allo stato puro il nostro peccato: ignoriamo Dio e vorremmo che fosse come noi, invece di essere noi come lui. Qui viene distrutto il falso ideale dell’uomo e della salvezza. Il re, l’uomo libero che libera, è colui che sa amare in povertà, servizio e umiltà fino alla morte. Realmente, la croce è il giudizio di Dio che liquida tutti i non valori religiosi e mondani, facendo giustizia dei vari idoli che ci tengono schiavi.Gesù crocifisso è il nuovo re, la nuova presenza di Dio, la legge suprema dell’amore e della perfetta libertà. I potenti credono in uno che salva se stesso a tutti i costi, a spese, ovviamente, degli altri. È il loro modello. Il discepolo, invece, crede Gesù come Salvatore e Signore, proprio perché è morto in croce.Il centurione vede Gesù morire dopo aver gridato: «Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?» (v. 34). E vedendolo morire in questo modo, esclama: «Veramente quest’uomo era Figlio di Dio!» (v. 39). Il grido di Gesù in croce è la somma di tutta la disperazione dell’umanità. L’abbandono di Dio è «il» male, lo sprofondare del tutto nell’abisso del nulla.Egli sulla croce porta il male di ogni peccato: l’abbandono stesso di Dio. In questo modo, solidale in tutto, ci garantisce che ovunque e sempre sarà con noi. Nell’amore ci si scambia ciò che si ha e ciò che si è. Qui lo scambio è perfetto: Dio ci dà il suo bene e noi gli diamo il nostro male.La Bibbia inizia col Signore che grida all’uomo: «Dove sei?» (Gen 3,9). La sua lunga ricerca, cominciata allora, termina sulla croce. Qui il cammino del tempo giunge alla meta prefissata dall’eternità: Dio trova l’uomo, anche il più lontano; e ogni uomo, anche il più maledetto, trova Dio. Il Crocifisso è l’unione perfetta di Dio e dell’uomo.La carne di Gesù, in quanto si fa carico di ogni male, è l’uomo nella maledizione del peccato; in quanto si consegna per noi alla morte, è epifania di Dio. Sulla croce si sono celebrate le nozze definitive di Dio con l’umanità.. Finalmente, vediamo chi siamo noi e chi è Dio: noi siamo amati da lui infinitamente e più di quanto ama se stesso, e lui è amore infinito per noi, che ci ama sopra ogni misura. «La misura dell’amore è amare senza misura» (san Basilio). Oltre la croce Dio non ha più nulla da dirci e da darci: ci ha manifestato totalmente se stesso, senza veli, dandosi tutto a noi. Nella croce egli si è totalmente espresso. Dio ha come spremuto fuori di sé la sua essenza per riversarla in noi. Tutta la pienezza della divinità presente in Gesù (Col 2,9) è travasata in noi, in questo abbraccio definitivo avvenuto sulla croce.Noi avevamo un’immagine negativa e rovesciata di Dio: lo pensavamo il contrario di quello che è. Sulla croce infatti vediamo che la Vita muore, la Parola tace, il Primo è l’ultimo, il Signore è schiavo, il patibolo è Trono, il Giudice è giudicato, il Giusto è giustiziato, il Salvatore si perde, il Benedetto è maledetto, il Santo è peccato. Realmente Dio abbandonando se stesso per farsi in tutto simile a noi, ha rivelato chi è lui, amore più forte della morte (Ct 8,6).La passione e morte di Gesù potrebbe essere paragonata ad un negativo fotografico, e la risurrezione alla stampa in positivo. Tutto ciò che si vede in un negativo fotografico deve essere pensato all’incontrario: il nero nella realtà è bianco, e il bianco è nero. Tutta la negatività della passione e morte di Gesù è in realtà la luce infinita della risurrezione che vedremo a Pasqua.Il centurione, unico interprete autentico della croce, è la persona meno indicata, che non ha alcun titolo (se non negativo) per parlare di questo avvenimento che supera ogni parola umana: è pagano, comandante del plotone di esecuzione, empio giustiziere del Giusto. L’uomo non ha altro punto di vista per capire Dio se non la propria empietà. Marco vuol portarci a questo faccia a faccia col Crocifisso, invitandoci ad identificarci col centurione che l’ha crocifisso, per farci ripetere con convinzione e fede profonda: «Veramente quest’uomo era Figlio di Dio» (v. 39). Solo qui nasce la fede, senza più pericolo di ambiguità. Tolto ogni segreto, comprendiamo per la prima volta chi è Gesù e chi è Dio. Le due conoscenze sono inseparabili tra loro e dalla croce. Gesù, infatti, è Dio, perché muore così; e quel Dio che nessuno ha mai visto è quest’uomo che spira così.. Un Dio crocifisso per nostro amore non lo conoscevamo neanche per sentito dire. È ignoto ad ogni religione e ad ogni ateismo. La «carne» del Verbo è l’unico principio di conoscenza di Dio, sua esegesi autentica (Gv 1,18), vero criterio di discernimento spirituale.L’umanità crocifissa di Gesù è il suo vaso rotto da cui esce il profumo della sua divinità. Ecco perché tutto questo spreco, che solo può rivelare Dio come amore, la cui misura è solo l’eccesso.La vicenda di Gesù non finisce con la morte. Continua, anzi, comincia il suo nuovo corso con queste donne che osservano la croce. Presto le ritroveremo al sepolcro dove, tre giorni dopo, riceveranno per prime l’annuncio della risurrezione. Esse non fanno niente. Il far niente della contemplazione è l’azione somma, la sola capace di cambiare il cuore: lo svuota di sé, riempiendolo di ciò che contempla.I discepoli maschi, persone forti e qualificate, intelligenti e capaci, si sono eclissati. L’uomo resta finché ha qualcosa da dare o da fare. Dopo rimane solo chi ama. Cessata l’azione, inizia la com–passione, che mette in gioco la persona stessa. Qui, e non prima, inizia l’amore, che rende vulnerabili a tutto il male dell’altro. La compassione è la qualità del debole, da cui ci si difende con cura. Ma è anche la forza più grande che esista, l’unica in grado di superare la soglia invalicabile della solitudine estrema: non abbandona l’amato neanche nell’impotenza della morte. Più forte di ogni azione, arriva dove l’azione ha perso ogni efficacia. A ben guardare, ogni azione che non è mossa dalla com–passione non è amore dell’altro, ma affermazione di sé. Attraverso la contemplazione di Gesù, le caratteristiche del Dio–Amore passano alla Chiesa e diventano le sue note essenziali, che la distinguono da qualunque altra società. Il discepolo è colui che sta ai piedi della croce con queste donne, e con loro compie il cammino del battesimo. Il battesimo è immergersi e affogare nel suo amore, per morire al proprio io e vivere di lui.All’osservatore normale queste donne paiono insignificanti. Ma a loro è affidato il mistero della morte, della sepoltura, della risurrezione e dell’annuncio di Gesù. È da notare anche che, nella cultura giudaica, le donne non erano autorizzate a testimoniare. Ma Gesù, «la pietra scartata» (12,10), sceglie proprio la loro testimonianza squalificata.La donna rappresenta la verità profonda dell’uomo, proprio per le sue qualità «deboli», che la rendono simile a Dio: amore umile, accogliente, servizievole, compassionevole e fecondo.Le cosiddette qualità forti sono il fallimento dell’uomo. L’egoismo, l’orgoglio, il potere, il dominio, la durezza chiudono nella sterilità della solitudine. Sono l’inferno. «Se non diventerete come le donne, non entrerete nel regno dei cieli» si potrebbe dire, parafrasando Mt 18,3; Mc 10,15; Lc 18,17 e Gv 3,3.42 Sopraggiunta ormai la sera, poiché era la Parascève, cioè la vigilia del sabato, 43 Giuseppe d’Arimatèa, membro autorevole del sinedrio, che aspettava anche lui il regno di Dio, andò coraggiosamente da Pilato per chiedere il corpo di Gesù. 44 Pilato si meravigliò che fosse già morto e, chiamato il centurione, lo interrogò se fosse morto da tempo. 45 Informato dal centurione, concesse la salma a Giuseppe. 46 Egli allora, comprato un lenzuolo, lo calò giù dalla croce e, avvoltolo nel lenzuolo, lo depose in un sepolcro scavato nella roccia. Poi fece rotolare un masso contro l’entrata del sepolcro. 47 Intanto Maria di Màgdala e Maria madre di Ioses stavano ad osservare dove veniva deposto.Due di queste tre donne, Maria di Magdala e Maria madre di Ioses, sono le testimoni del luogo in cui, grazie all’intervento di Giuseppe di Arimatea, il corpo di Gesù viene deposto. Giuseppe di Arimatea è un membro ragguardevole del sinedrio, un credente che aspetta il regno di Dio. Qui non si dice che sia un discepolo (cf. invece Mt 27,57). La sua posizione gli permette l’audacia di chiedere a Pilato il corpo di Gesù, per dargli una sepoltura decorosa prima che, alla fine del giorno, cominci il sabato. I discepoli sono assenti e le donne che conoscono Gesù non hanno alcuna parte attiva nella sepoltura: esse guardano.Il sepolcro di Gesù racchiude la realtà di ogni promessa: contiene quel seme che, gettato sotto terra, diviene il grande albero del Regno (4,26). Adoriamo nel sepolcro l’umiltà del Signore. Egli è in tutto simile all’uomo. È humus, umiltà essenziale. Tratto dalla terra, ad essa è destinato. Gesù, secondo la tradizione, nasce in una grotta e in una grotta conclude la sua vita terrena. Dopo aver trovato l’uomo sulla croce, ora Gesù scende con lui negli inferi.La sua discesa agli inferi è il mistero più grande della fede, limite ultimo possibile della kenosis, dello svuotamento, dell’abbassamento di Dio. Rivela un Dio–Amore solidale con noi in tutto, fino a diventare ciò che nessuno vuol essere e ognuno diventa: il niente di sé.Nel sepolcro finalmente incontra tutti, nessuno escluso. È il luogo di convegno universale. Il passato è tutto lì nel sepolcro. Negli inferi tutti si riuniscono, stolti e sapienti, ugualmente sconfitti e vinti. Lì la morte regna sovrana sull’uomo e la sua storia. Lì Gesù annuncia il vangelo (1Pt 3,19). La buona notizia è proprio il fatto che lui sia lì. Il Signore sta con noi nella valle oscura (Sal 23,4). Egli non ci libera dalla morte, ma nella morte.Per garantirmi di questo mi dà il segno più sicuro: si è fatto solidale col mio sepolcro, perché io non possa più dubitare che lui sia con me, ovunque mi trovi, anche nella maledizione estrema. La contemplazione del sepolcro di Gesù ci deve progressivamente liberare dal terrore della morte. Ora sappiamo che dietro la pietra del sepolcro c’è il Signore che ci ama e che noi amiamo.Essere battezzato significa accettare la mia vita e la mia morte, rispettivamente, come dono di Dio e abbandono in lui. Questo è l’atto di fede che mi guarisce dalla sfiducia, radice di ogni male. Liberato dalla paura del futuro, posso finalmente vivere con gioia il presente, godendo di ogni dono, senza l’affanno di possederlo nel timore che sfugga. So che la parola ultima non è la morte, ma la vita piena di tutto ciò che ora possiedo solo parzialmente.
CAPITOLO 16
1 Passato il sabato, Maria di Màgdala, Maria di Giacomo e Salome comprarono oli aromatici per andare a imbalsamare Gesù. 2 Di buon mattino, il primo giorno dopo il sabato, vennero al sepolcro al levar del sole. 3 Esse dicevano tra loro: «Chi ci rotolerà via il masso dall’ingresso del sepolcro?». 4 Ma, guardando, videro che il masso era già stato rotolato via, benché fosse molto grande. 5 Entrando nel sepolcro, videro un giovane, seduto sulla destra, vestito d’una veste bianca, ed ebbero paura. 6 Ma egli disse loro: «Non abbiate paura! Voi cercate Gesù Nazareno, il crocifisso. È risorto, non è qui. Ecco il luogo dove l’avevano deposto. 7 Ora andate, dite ai suoi discepoli e a Pietro che egli vi precede in Galilea. Là lo vedrete, come vi ha detto». 8 Ed esse, uscite, fuggirono via dal sepolcro perché erano piene di timore e di spavento. E non dissero niente a nessuno, perché avevano paura.La sezione centrale del vangelo ci ha mostrato l’importanza che aveva per Marco la risurrezione del Cristo, prefigurata dalla scena della trasfigurazione (9,2–10), e annunziata nel triplice insegnamento di Gesù sul destino del Figlio dell’uomo (8,31; 9,31; 10,34). Si può comprendere allora la sua discrezione a proposito dell’avvenimento pasquale. Gli dedica solo otto versetti, che riguardano la visita delle donne al sepolcro e il messaggio che viene loro trasmesso: questi versetti rappresentano forse il più antico documento che possediamo in proposito. Quanto ai dodici versetti che seguono, essi sono assenti da un certo numero di buoni manoscritti e furono aggiunti probabilmente in seguito: lo stile e il vocabolario rivelano un modo diverso di scrivere e le notizie che riferiscono sembrano attinte da altri racconti della risurrezione, soprattutto da Luca e da Giovanni.Marco descrive essenzialmente l’episodio delle tre donne che vanno ad imbalsamare il corpo di Gesù. La loro visita al sepolcro è sconvolgente: vi trovano infatti un giovane, seduto sulla destra (segno di buon auspicio), vestito di una veste bianca (segno di vittoria), che trasmette loro un messaggio per i discepoli di Gesù: «Non abbiate paura! Voi cercate Gesù Nazareno, il crocifisso. È risorto, non è qui. Ecco il luogo dove l’avevano deposto. Ora andate, dite ai suoi discepoli e a Pietro che vi precede in Galilea. Là lo vedrete, come vi ha detto». Gesù aveva predetto, infatti: «Dopo la mia risurrezione, vi precederò in Galilea» (14,28). Quindi, le donne avrebbero dovuto ricordare ai discepoli quello che già sapevano.In Galilea, dove era incominciata l’avventura di Gesù, dove i discepoli lo avevano incontrato per la prima volta, essi lo vedranno di nuovo e l’avventura continuerà.. Dio ha capovolto il giudizio degli uomini e della storia e ha risuscitato colui che gli uomini avevano crocifisso. È comprensibile che davanti a questo annuncio le donne abbiano paura. Nel racconto della passione si era notata la presenza delle donne alla crocifissione di Gesù (15,40) e alla sepoltura (15,47): esse avevano accompagnato il Maestro dalla Galilea fino a Gerusalemme e lo servivano. La loro presenza al Calvario e durante la sepoltura sottolinea l’assenza dei discepoli. Davanti al pericolo, essi sono scappati; le donne invece sono là, come testimoni oculari. Ora le stesse tre donne le troviamo, il mattino di Pasqua, testimoni della risurrezione. Quanto al loro sconcerto per la manifestazione e il messaggio dell’angelo, tutto questo fa risaltare la trascendenza dell’azione di Dio, sia nell’atto della risurrezione di Gesù che nell’origine del messaggio pasquale. Né l’una né l’altro sono stati opera dell’uomo. L’affanno di Maria di Magdala, di Maria di Giacomo e di Salome non proviene semplicemente dalla fragilità femminile. Esso fa apparire fino a che punto l’uomo viene superato da ciò che Dio fa e rivela attraverso la vita, la morte e la risurrezione di Gesù. Dovremmo ricordarcene quando cerchiamo di imprigionare Dio nei nostri schemi, nei nostri progetti e ideali umani.Marco è l’uomo dello scandalo della fede e quando, con la sua guida, rifacciamo l’itinerario della fede, siamo costretti a chiederci se abbiamo ben capito il messaggio. Il ritratto dell’uomo, nel vangelo di Marco, non è molto carezzevole, tuttavia al termine della lettura di questo vangelo rimane una visione profondamente ottimistica: tutti i progetti umani sono naufragati, la debolezza e l’incomprensione degli uomini è venuta a galla in continuità, eppure siamo invitati a rimetterci nelle mani di Dio, che ci lancia nuovamente e definitivamente nell’avvenire.La paura delle donne (16,5) non indica un fatto psicologico di fronte ad un avvenimento clamoroso, ma una violenta emozione religiosa. Per l’evangelista lo stupore, il timore e lo sgomento indicano una crisi delle percezioni umane, in seguito ad una novità radicale e inattesa.Così la gente di Cafarnao era stata presa da timore dopo il primo intervento di Gesù (1,27), come anche coloro che lo avevano accolto dopo la trasfigurazione (9,15). Le severe esigenze del Maestro avevano provocato lo stesso effetto sui discepoli (10,24.32), e Gesù stesso si trova in questo stato nell’agonia (14,33). Le tre testimoni della risurrezione sono ammesse alla presenza di Dio: in tutte le teofanie bibliche (Gn 28,17; Es 3,6; Gdc 6,22–23; Is 5,5; Ez 1,27 ecc.) questo stato d’angoscia s’impadronisce dell’uomo, perché «non si può vedere Dio e rimanere in vita» (Es 33,10). Ma se l’apparizione del totalmente Altro sconvolge, la sua presenza subito rassicura e tranquillizza: «Non abbiate paura» (16,6).Le donne stupite e disorientate, s’incamminano per andare a rendere testimonianza al Risorto. Ma ecco che queste testimoni privilegiate diventano mute: «Fuggirono via dal sepolcro perché erano piene di timore e di spavento. E non dissero niente a nessuno, perché avevano paura» (16,8). Ci si è interrogati a lungo su questa conclusione improvvisa e si è cercato di interpretarla in vari modi. Come comprendere il silenzio di queste donne che avevano avuto l’incarico esplicito di parlare? Gli altri sinottici le presentano mentre si dedicano alla loro missione: «Abbandonato in fretta il sepolcro, con timore e gioia grande, le donne corsero a dare l’annunzio ai suoi discepoli» (Mt 28,8); «E tornate dal sepolcro, annunziarono tutto questo agli undici e a tutti gli altri... Quelle parole parvero loro come un vaneggiamento e non credettero ad esse» (Lc 24,9–11). Il nostro evangelista non riferisce come sia avvenuta in concreto la trasmissione del messaggio pasquale. I versetti che seguono (16,9–20), aggiunti più tardi, colmeranno questa lacuna.«Gesù il Nazareno, il Crocifisso, è risorto». È il grido pasquale di vittoria sulla morte, che dal sepolcro risuona per il mondo intero. L’annuncio incredibile del Crocifisso risorto è il «principio» del vangelo di Gesù Cristo, Figlio di Dio (1,1). Le donne sono le prime ad ascoltarlo e a ricevere la missione di raccontarlo.La prova negativa della risurrezione è l’assenza del suo corpo là dove dovrebbe essere: «Non è qui, ecco il luogo dove era deposto!» (v. 6). La prova positiva della risurrezione è la promessa ricevuta dalle donne e trasmessa agli apostoli: «Vi precede in Galilea; là lo vedrete, come vi ha detto» (v. 7).9 Risuscitato al mattino nel primo giorno dopo il sabato, apparve prima a Maria di Màgdala, dalla quale aveva cacciato sette demòni. 10 Questa andò ad annunziarlo ai suoi seguaci che erano in lutto e in pianto.11 Ma essi, udito che era vivo ed era stato visto da lei, non vollero credere.12 Dopo ciò, apparve a due di loro sotto altro aspetto, mentre erano in cammino verso la campagna.13 Anch’essi ritornarono ad annunziarlo agli altri; ma neanche a loro vollero credere.14 Alla fine apparve agli undici, mentre stavano a mensa, e li rimproverò per la loro incredulità e durezza di cuore, perché non avevano creduto a quelli che lo avevano visto risuscitato.L’apparizione del Risorto a Maria di Magdala è un riassunto dei versetti 11–18 del capitolo 20 di Giovanni. Per caratterizzare la figura della Maddalena, l’autore ricorre al testo di Luca (8,2), dove è detto che Gesù scacciò da lei sette demoni. Da tale notizia non è lecito dedurre che Maria fosse una grande peccatrice, ma piuttosto che era affetta da grave malattia, dalla quale Gesù l’aveva guarita.Particolarmente stringato è il riassunto della storia dei due discepoli in cammino verso Emmaus, tratto dal capitolo 24 di Luca. All’evangelista interessa, anche questa volta, solo il fatto che i discepoli non credettero al racconto dei compagni.Infine l’autore ricorda l’apparizione di Gesù agli Undici, riferendosi chiaramente al racconto di Luca (24,36–43). In questo brano viene denunciata pesantemente la mancanza di fede dei discepoli (vv. 11.13.14). Gli apostoli passano dal dubbio alla fede sotto l’urto delle manifestazioni di Gesù.La fede nella risurrezione non è una scoperta umana, ma il prodotto di un annuncio fatto a noi da Dio mediante angeli o inviati vestiti di bianco (colore delle vesti del paradiso), e attraverso l’incontro diretto, visibile e palpabile con il diretto interessato, il Cristo risorto.La risurrezione di Cristo (e la nostra futura risurrezione) è corporea, come lo fu anche la sua morte. La prova è il sepolcro vuoto, testimoniata da tutti e quattro i vangeli, ma soprattutto l’incontro con il Risorto, che non è un fantasma, ma ha carne e ossa, come hanno potuto constatare i discepoli, e che mangia davanti a loro una porzione di pesce arrostito (cf. Lc 24).Gesù, il Nazareno crocifisso, è risorto. Questa è la parola fondamentale della fede cristiana.15 Gesù disse loro: «Andate in tutto il mondo e predicate il vangelo ad ogni creatura.16 Chi crederà e sarà battezzato sarà salvo, ma chi non crederà sarà condannato.17 E questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono: nel mio nome scacceranno i demòni, parleranno lingue nuove, 18 prenderanno in mano i serpenti e, se berranno qualche veleno, non recherà loro danno, imporranno le mani ai malati e questi guariranno».19 Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu assunto in cielo e sedette alla destra di Dio.20 Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore operava insieme con loro e confermava la parola con i prodigi che l’accompagnavano.La finale del vangelo di Marco insiste sulla missione di portare il vangelo in tutto il mondo, unendo strettamente la testimonianza della parola a quella delle opere, dei segni.Con l’esortazione alla missione universale si congiunge l’affermazione che per la salvezza sono richiesti la fede e il battesimo. Inoltre agli annunciatori del vangelo viene promesso che la loro predicazione missionaria sarà sostenuta e confermata dai miracoli compiuti da Gesù risorto.La trasmissione delle parole di Gesù è al centro del testo e ha lo scopo di fare cristiani tutti i popoli. La missione, l’andare da tutti gli uomini, è un incarico che va capito bene.Se la missione è trasmettere agli uomini la parola di Gesù e le sue direttive per fare di loro, mediante il battesimo, dei discepoli, ciò esclude due malintesi.Il primo è il malinteso della rivendicazione del potere politico. Una concezione utopistica è quella di W. Soloviev che ritiene il regno di Dio come uno stato teocratico in questo mondo, e vede questa concezione radicata nella volontà di Gesù. Sulla terra vi sarebbe un unico potere, e questo non apparterebbe a Cesare, ma a Gesù Cristo.L’altro malinteso è la relativizzazione dell’incarico missionario, che arriva a sostenere che il compito dell’evangelizzazione consiste nell’aiutare i buddisti a diventare buddisti migliori, i musulmani a diventare più ferventi musulmani, e via dicendo.Il dialogo necessario con le religioni mondiali non elimina la necessità dell’annuncio e della testimonianza della fede cristiana e del battesimo. È il Cristo risorto al quale è stato dato ogni potere in cielo e in terra (cf. Mt 18,28), che manda i cristiani a predicare il vangelo ad ogni creatura.La missione è necessaria per volontà di Dio, che ha risuscitato Gesù Cristo dai morti.

